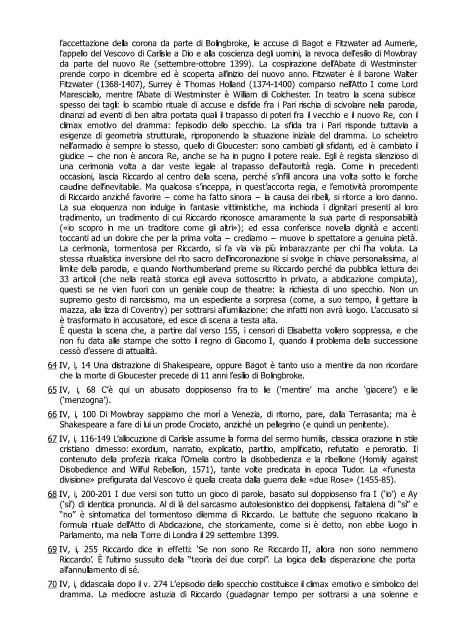Page 2974 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2974
l’accettazione della corona da parte di Bolingbroke, le accuse di Bagot e Fitzwater ad Aumerle,
l’appello del Vescovo di Carlisle a Dio e alla coscienza degli uomini, la revoca dell’esilio di Mowbray
da parte del nuovo Re (settembre-ottobre 1399). La cospirazione dell’Abate di Westminster
prende corpo in dicembre ed è scoperta all’inizio del nuovo anno. Fitzwater è il barone Walter
Fitzwater (1368-1407), Surrey è Thomas Holland (1374-1400) comparso nell’Atto I come Lord
Maresciallo, mentre l’Abate di Westminster è William di Colchester. In teatro la scena subisce
spesso dei tagli: lo scambio rituale di accuse e disfide fra i Pari rischia di scivolare nella parodia,
dinanzi ad eventi di ben altra portata quali il trapasso di poteri fra il vecchio e il nuovo Re, con il
climax emotivo del dramma: l’episodio dello specchio. La sfida tra i Pari risponde tuttavia a
esigenze di geometria strutturale, riproponendo la situazione iniziale del dramma. Lo scheletro
nell’armadio è sempre lo stesso, quello di Gloucester: sono cambiati gli sfidanti, ed è cambiato il
giudice - che non è ancora Re, anche se ha in pugno il potere reale. Egli è regista silenzioso di
una cerimonia volta a dar veste legale al trapasso dell’autorità regia. Come in precedenti
occasioni, lascia Riccardo al centro della scena, perché s’infili ancora una volta sotto le forche
caudine dell’inevitabile. Ma qualcosa s’inceppa, in quest’accorta regia, e l’emotività prorompente
di Riccardo anziché favorire - come ha fatto sinora - la causa dei ribelli, si ritorce a loro danno.
La sua eloquenza non indulge in fantasie vittimistiche, ma inchioda i dignitari presenti al loro
tradimento, un tradimento di cui Riccardo riconosce amaramente la sua parte di responsabilità
(«io scopro in me un traditore come gli altri»); ed essa conferisce novella dignità e accenti
toccanti ad un dolore che per la prima volta - crediamo - muove lo spettatore a genuina pietà.
La cerimonia, tormentosa per Riccardo, si fa via via più imbarazzante per chi l’ha voluta. La
stessa ritualistica inversione del rito sacro dell’incoronazione si svolge in chiave personalissima, al
limite della parodia, e quando Northumberland preme su Riccardo perché dia pubblica lettura dei
33 articoli (che nella realtà storica egli aveva sottoscritto in privato, a abdicazione compiuta),
questi se ne vien fuori con un geniale coup de theatre: la richiesta di uno specchio. Non un
supremo gesto di narcisismo, ma un espediente a sorpresa (come, a suo tempo, il gettare la
mazza, alla lizza di Coventry) per sottrarsi all’umiliazione: che infatti non avrà luogo. L’accusato si
è trasformato in accusatore, ed esce di scena a testa alta.
È questa la scena che, a partire dal verso 155, i censori di Elisabetta vollero soppressa, e che
non fu data alle stampe che sotto il regno di Giacomo I, quando il problema della successione
cessò d’essere di attualità.
64 IV, i, 14 Una distrazione di Shakespeare, oppure Bagot è tanto uso a mentire da non ricordare
che la morte di Gloucester precede di 11 anni l’esilio di Bolingbroke.
65 IV, i, 68 C’è qui un abusato doppiosenso fra to lie (‘mentire’ ma anche ‘giacere’) e lie
(‘menzogna’).
66 IV, i, 100 Di Mowbray sappiamo che morì a Venezia, di ritorno, pare, dalla Terrasanta; ma è
Shakespeare a fare di lui un prode Crociato, anziché un pellegrino (e quindi un penitente).
67 IV, i, 116-149 L’allocuzione di Carlisle assume la forma del sermo humilis, classica orazione in stile
cristiano dimesso: exordium, narratio, explicatio, partitio, amplificatio, refutatio e peroratio. Il
contenuto della profezia ricalca l’Omelia contro la disobbedienza e la ribellione (Homily against
Disobedience and Wilful Rebellion, 1571), tante volte predicata in epoca Tudor. La «funesta
divisione» prefigurata dal Vescovo è quella creata dalla guerra delle «due Rose» (1455-85).
68 IV, i, 200-201 I due versi son tutto un gioco di parole, basato sul doppiosenso fra I (‘io’) e Ay
(‘sì’) di identica pronuncia. Al di là del sarcasmo autolesionistico dei doppisensi, l’altalena di “sì” e
“no” è sintomatica del tormentoso dilemma di Riccardo. Le battute che seguono ricalcano la
formula rituale dell’Atto di Abdicazione, che storicamente, come si è detto, non ebbe luogo in
Parlamento, ma nella Torre di Londra il 29 settembre 1399.
69 IV, i, 255 Riccardo dice in effetti: ‘Se non sono Re Riccardo II, allora non sono nemmeno
Riccardo’. È l’ultimo sussulto della “teoria dei due corpi”. La logica della disperazione che porta
all’annullamento di sé.
70 IV, i, didascalia dopo il v. 274 L’episodio dello specchio costituisce il climax emotivo e simbolico del
dramma. La mediocre astuzia di Riccardo (guadagnar tempo per sottrarsi a una solenne e