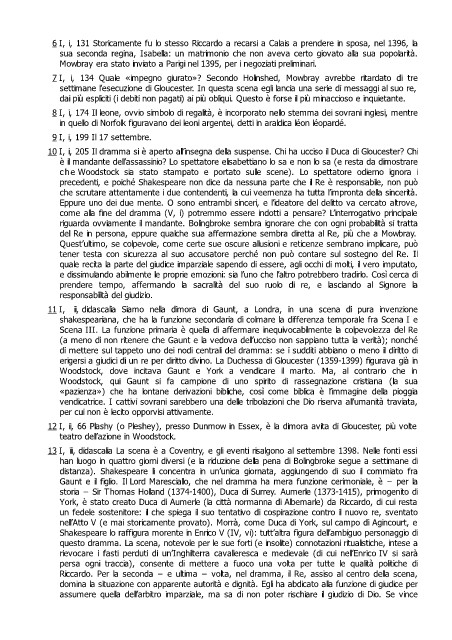Page 2967 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2967
6 I, i, 131 Storicamente fu lo stesso Riccardo a recarsi a Calais a prendere in sposa, nel 1396, la
sua seconda regina, Isabella: un matrimonio che non aveva certo giovato alla sua popolarità.
Mowbray era stato inviato a Parigi nel 1395, per i negoziati preliminari.
7 I, i, 134 Quale «impegno giurato»? Secondo Holinshed, Mowbray avrebbe ritardato di tre
settimane l’esecuzione di Gloucester. In questa scena egli lancia una serie di messaggi al suo re,
dai più espliciti (i debiti non pagati) ai più obliqui. Questo è forse il più minaccioso e inquietante.
8 I, i, 174 Il leone, ovvio simbolo di regalità, è incorporato nello stemma dei sovrani inglesi, mentre
in quello di Norfolk figuravano dei leoni argentei, detti in araldica léon léopardé.
9 I, i, 199 Il 17 settembre.
10 I, i, 205 Il dramma si è aperto all’insegna della suspense. Chi ha ucciso il Duca di Gloucester? Chi
è il mandante dell’assassinio? Lo spettatore elisabettiano lo sa e non lo sa (e resta da dimostrare
c h e Woodstock sia stato stampato e portato sulle scene). Lo spettatore odierno ignora i
precedenti, e poiché Shakespeare non dice da nessuna parte che il Re è responsabile, non può
che scrutare attentamente i due contendenti, la cui veemenza ha tutta l’impronta della sincerità.
Eppure uno dei due mente. O sono entrambi sinceri, e l’ideatore del delitto va cercato altrove,
come alla fine del dramma (V, i) potremmo essere indotti a pensare? L’interrogativo principale
riguarda ovviamente il mandante. Bolingbroke sembra ignorare che con ogni probabilità si tratta
del Re in persona, eppure qualche sua affermazione sembra diretta al Re, più che a Mowbray.
Quest’ultimo, se colpevole, come certe sue oscure allusioni e reticenze sembrano implicare, può
tener testa con sicurezza al suo accusatore perché non può contare sul sostegno del Re. Il
quale recita la parte del giudice imparziale sapendo di essere, agli occhi di molti, il vero imputato,
e dissimulando abilmente le proprie emozioni: sia l’uno che l’altro potrebbero tradirlo. Così cerca di
prendere tempo, affermando la sacralità del suo ruolo di re, e lasciando al Signore la
responsabilità del giudizio.
11 I, ii, didascalia Siamo nella dimora di Gaunt, a Londra, in una scena di pura invenzione
shakespeariana, che ha la funzione secondaria di colmare la differenza temporale fra Scena I e
Scena III. La funzione primaria è quella di affermare inequivocabilmente la colpevolezza del Re
(a meno di non ritenere che Gaunt e la vedova dell’ucciso non sappiano tutta la verità); nonché
di mettere sul tappeto uno dei nodi centrali del dramma: se i sudditi abbiano o meno il diritto di
erigersi a giudici di un re per diritto divino. La Duchessa di Gloucester (1359-1399) figurava già in
Woodstock, dove incitava Gaunt e York a vendicare il marito. Ma, al contrario che in
Woodstock, qui Gaunt si fa campione di uno spirito di rassegnazione cristiana (la sua
«pazienza») che ha lontane derivazioni bibliche, così come biblica è l’immagine della pioggia
vendicatrice. I cattivi sovrani sarebbero una delle tribolazioni che Dio riserva all’umanità traviata,
per cui non è lecito opporvisi attivamente.
12 I, ii, 66 Plashy (o Pleshey), presso Dunmow in Essex, è la dimora avita di Gloucester, più volte
teatro dell’azione in Woodstock.
13 I, iii, didascalia La scena è a Coventry, e gli eventi risalgono al settembre 1398. Nelle fonti essi
han luogo in quattro giorni diversi (e la riduzione della pena di Bolingbroke segue a settimane di
distanza). Shakespeare li concentra in un’unica giornata, aggiungendo di suo il commiato fra
Gaunt e il figlio. Il Lord Maresciallo, che nel dramma ha mera funzione cerimoniale, è - per la
storia - Sir Thomas Holland (1374-1400), Duca di Surrey. Aumerle (1373-1415), primogenito di
York, è stato creato Duca di Aumerle (la città normanna di Albemarle) da Riccardo, di cui resta
un fedele sostenitore: il che spiega il suo tentativo di cospirazione contro il nuovo re, sventato
nell’Atto V (e mai storicamente provato). Morrà, come Duca di York, sul campo di Agincourt, e
Shakespeare lo raffigura morente in Enrico V (IV, vi): tutt’altra figura dell’ambiguo personaggio di
questo dramma. La scena, notevole per le sue forti (e insolite) connotazioni ritualistiche, intese a
rievocare i fasti perduti di un’Inghilterra cavalleresca e medievale (di cui nell’Enrico IV si sarà
persa ogni traccia), consente di mettere a fuoco una volta per tutte le qualità politiche di
Riccardo. Per la seconda - e ultima - volta, nel dramma, il Re, assiso al centro della scena,
domina la situazione con apparente autorità e dignità. Egli ha abdicato alla funzione di giudice per
assumere quella dell’arbitro imparziale, ma sa di non poter rischiare il giudizio di Dio. Se vince