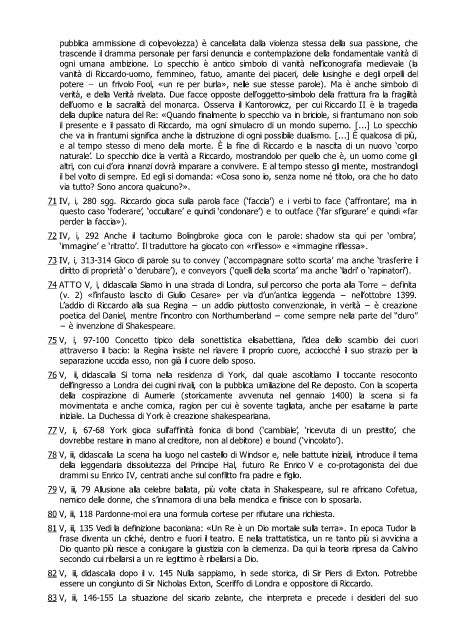Page 2975 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2975
pubblica ammissione di colpevolezza) è cancellata dalla violenza stessa della sua passione, che
trascende il dramma personale per farsi denuncia e contemplazione della fondamentale vanità di
ogni umana ambizione. Lo specchio è antico simbolo di vanità nell’iconografia medievale (la
vanità di Riccardo-uomo, femmineo, fatuo, amante dei piaceri, delle lusinghe e degli orpelli del
potere - un frivolo Fool, «un re per burla», nelle sue stesse parole). Ma è anche simbolo di
verità, e della Verità rivelata. Due facce opposte dell’oggetto-simbolo della frattura fra la fragilità
dell’uomo e la sacralità del monarca. Osserva il Kantorowicz, per cui Riccardo II è la tragedia
della duplice natura del Re: «Quando finalmente lo specchio va in briciole, si frantumano non solo
il presente e il passato di Riccardo, ma ogni simulacro di un mondo superno. [...] Lo specchio
che va in frantumi significa anche la distruzione di ogni possibile dualismo. [...] È qualcosa di più,
e al tempo stesso di meno della morte. È la fine di Riccardo e la nascita di un nuovo ‘corpo
naturale’. Lo specchio dice la verità a Riccardo, mostrandolo per quello che è, un uomo come gli
altri, con cui d’ora innanzi dovrà imparare a convivere. E al tempo stesso gli mente, mostrandogli
il bel volto di sempre. Ed egli si domanda: «Cosa sono io, senza nome né titolo, ora che ho dato
via tutto? Sono ancora qualcuno?».
71 IV, i, 280 sgg. Riccardo gioca sulla parola face (‘faccia’) e i verbi to face (‘affrontare’, ma in
questo caso ‘foderare’, ‘occultare’ e quindi ‘condonare’) e to outface (‘far sfigurare’ e quindi «far
perder la faccia»).
72 IV, i, 292 Anche il taciturno Bolingbroke gioca con le parole: shadow sta qui per ‘ombra’,
‘immagine’ e ‘ritratto’. Il traduttore ha giocato con «riflesso» e «immagine riflessa».
73 IV, i, 313-314 Gioco di parole su to convey (‘accompagnare sotto scorta’ ma anche ‘trasferire il
diritto di proprietà’ o ‘derubare’), e conveyors (‘quelli della scorta’ ma anche ‘ladri’ o ‘rapinatori’).
74 ATTO V, i, didascalia Siamo in una strada di Londra, sul percorso che porta alla Torre - definita
(v. 2) «l’infausto lascito di Giulio Cesare» per via d’un’antica leggenda - nell’ottobre 1399.
L’addio di Riccardo alla sua Regina - un addio piuttosto convenzionale, in verità - è creazione
poetica del Daniel, mentre l’incontro con Northumberland - come sempre nella parte del “duro”
- è invenzione di Shakespeare.
75 V, i, 97-100 Concetto tipico della sonettistica elisabettiana, l’idea dello scambio dei cuori
attraverso il bacio: la Regina insiste nel riavere il proprio cuore, acciocché il suo strazio per la
separazione uccida esso, non già il cuore dello sposo.
76 V, ii, didascalia Si torna nella residenza di York, dal quale ascoltiamo il toccante resoconto
dell’ingresso a Londra dei cugini rivali, con la pubblica umiliazione del Re deposto. Con la scoperta
della cospirazione di Aumerle (storicamente avvenuta nel gennaio 1400) la scena si fa
movimentata e anche comica, ragion per cui è sovente tagliata, anche per esaltarne la parte
iniziale. La Duchessa di York è creazione shakespeariana.
77 V, ii, 67-68 York gioca sull’affinità fonica di bond (‘cambiale’, ‘ricevuta di un prestito’, che
dovrebbe restare in mano al creditore, non al debitore) e bound (‘vincolato’).
78 V, iii, didascalia La scena ha luogo nel castello di Windsor e, nelle battute iniziali, introduce il tema
della leggendaria dissolutezza del Principe Hal, futuro Re Enrico V e co-protagonista dei due
drammi su Enrico IV, centrati anche sul conflitto fra padre e figlio.
79 V, iii, 79 Allusione alla celebre ballata, più volte citata in Shakespeare, sul re africano Cofetua,
nemico delle donne, che s’innamora di una bella mendica e finisce con lo sposarla.
80 V, iii, 118 Pardonne-moi era una formula cortese per rifiutare una richiesta.
81 V, iii, 135 Vedi la definizione baconiana: «Un Re è un Dio mortale sulla terra». In epoca Tudor la
frase diventa un cliché, dentro e fuori il teatro. E nella trattatistica, un re tanto più si avvicina a
Dio quanto più riesce a coniugare la giustizia con la clemenza. Da qui la teoria ripresa da Calvino
secondo cui ribellarsi a un re legittimo è ribellarsi a Dio.
82 V, iii, didascalia dopo il v. 145 Nulla sappiamo, in sede storica, di Sir Piers di Exton. Potrebbe
essere un congiunto di Sir Nicholas Exton, Sceriffo di Londra e oppositore di Riccardo.
83 V, iii, 146-155 La situazione del sicario zelante, che interpreta e precede i desideri del suo