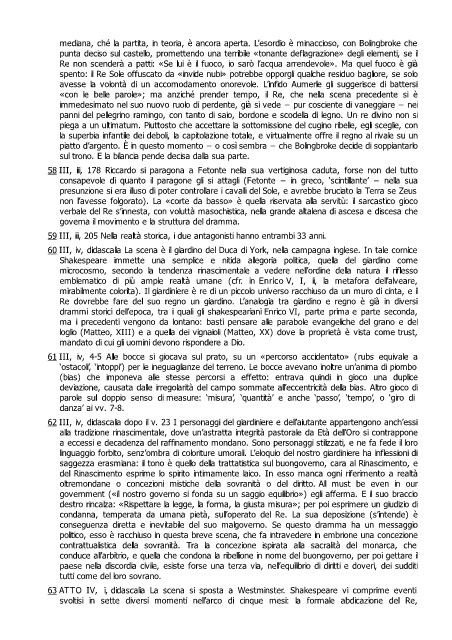Page 2973 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2973
mediana, ché la partita, in teoria, è ancora aperta. L’esordio è minaccioso, con Bolingbroke che
punta deciso sul castello, promettendo una terribile «tonante deflagrazione» degli elementi, se il
Re non scenderà a patti: «Se lui è il fuoco, io sarò l’acqua arrendevole». Ma quel fuoco è già
spento: il Re Sole offuscato da «invide nubi» potrebbe opporgli qualche residuo bagliore, se solo
avesse la volontà di un accomodamento onorevole. L’infido Aumerle gli suggerisce di battersi
«con le belle parole»; ma anziché prender tempo, il Re, che nella scena precedente si è
immedesimato nel suo nuovo ruolo di perdente, già si vede - pur cosciente di vaneggiare - nei
panni del pellegrino ramingo, con tanto di saio, bordone e scodella di legno. Un re divino non si
piega a un ultimatum. Piuttosto che accettare la sottomissione del cugino ribelle, egli sceglie, con
la superbia infantile dei deboli, la capitolazione totale, e virtualmente offre il regno al rivale su un
piatto d’argento. È in questo momento - o così sembra - che Bolingbroke decide di soppiantarlo
sul trono. E la bilancia pende decisa dalla sua parte.
58 III, iii, 178 Riccardo si paragona a Fetonte nella sua vertiginosa caduta, forse non del tutto
consapevole di quanto il paragone gli si attagli (Fetonte - in greco, ‘scintillante’ - nella sua
presunzione si era illuso di poter controllare i cavalli del Sole, e avrebbe bruciato la Terra se Zeus
non l’avesse folgorato). La «corte da basso» è quella riservata alla servitù: il sarcastico gioco
verbale del Re s’innesta, con voluttà masochistica, nella grande altalena di ascesa e discesa che
governa il movimento e la struttura del dramma.
59 III, iii, 205 Nella realtà storica, i due antagonisti hanno entrambi 33 anni.
60 III, iv, didascalia La scena è il giardino del Duca di York, nella campagna inglese. In tale cornice
Shakespeare immette una semplice e nitida allegoria politica, quella del giardino come
microcosmo, secondo la tendenza rinascimentale a vedere nell’ordine della natura il riflesso
emblematico di più ampie realtà umane (cfr. in Enrico V, I, ii, la metafora dell’alveare,
mirabilmente colorita). Il giardiniere è re di un piccolo universo racchiuso da un muro di cinta, e il
Re dovrebbe fare del suo regno un giardino. L’analogia tra giardino e regno è già in diversi
drammi storici dell’epoca, tra i quali gli shakespeariani Enrico VI, parte prima e parte seconda,
ma i precedenti vengono da lontano: basti pensare alle parabole evangeliche del grano e del
loglio (Matteo, XIII) e a quella dei vignaioli (Matteo, XX) dove la proprietà è vista come trust,
mandato di cui gli uomini devono rispondere a Dio.
61 III, iv, 4-5 Alle bocce si giocava sul prato, su un «percorso accidentato» (rubs equivale a
‘ostacoli’, ‘intoppi’) per le ineguaglianze del terreno. Le bocce avevano inoltre un’anima di piombo
(bias) che imponeva alle stesse percorsi a effetto: entrava quindi in gioco una duplice
deviazione, causata dalle irregolarità del campo sommate all’eccentricità della bias. Altro gioco di
parole sul doppio senso di measure: ‘misura’, ‘quantità’ e anche ‘passo’, ‘tempo’, o ‘giro di
danza’ ai vv. 7-8.
62 III, iv, didascalia dopo il v. 23 I personaggi del giardiniere e dell’aiutante appartengono anch’essi
alla tradizione rinascimentale, dove un’astratta integrità pastorale da Età dell’Oro si contrappone
a eccessi e decadenza del raffinamento mondano. Sono personaggi stilizzati, e ne fa fede il loro
linguaggio forbito, senz’ombra di coloriture umorali. L’eloquio del nostro giardiniere ha inflessioni di
saggezza erasmiana: il tono è quello della trattatistica sul buongoverno, cara al Rinascimento, e
del Rinascimento esprime lo spirito intimamente laico. In esso manca ogni riferimento a realtà
oltremondane o concezioni mistiche della sovranità o del diritto. All must be even in our
government («il nostro governo si fonda su un saggio equilibrio») egli afferma. E il suo braccio
destro rincalza: «Rispettare la legge, la forma, la giusta misura»; per poi esprimere un giudizio di
condanna, temperata da umana pietà, sull’operato del Re. La sua deposizione (s’intende) è
conseguenza diretta e inevitabile del suo malgoverno. Se questo dramma ha un messaggio
politico, esso è racchiuso in questa breve scena, che fa intravedere in embrione una concezione
contrattualistica della sovranità. Tra la concezione ispirata alla sacralità del monarca, che
conduce all’arbitrio, e quella che condona la ribellione in nome del buongoverno, per poi gettare il
paese nella discordia civile, esiste forse una terza via, nell’equilibrio di diritti e doveri, dei sudditi
tutti come del loro sovrano.
63 ATTO IV, i, didascalia La scena si sposta a Westminster. Shakespeare vi comprime eventi
svoltisi in sette diversi momenti nell’arco di cinque mesi: la formale abdicazione del Re,