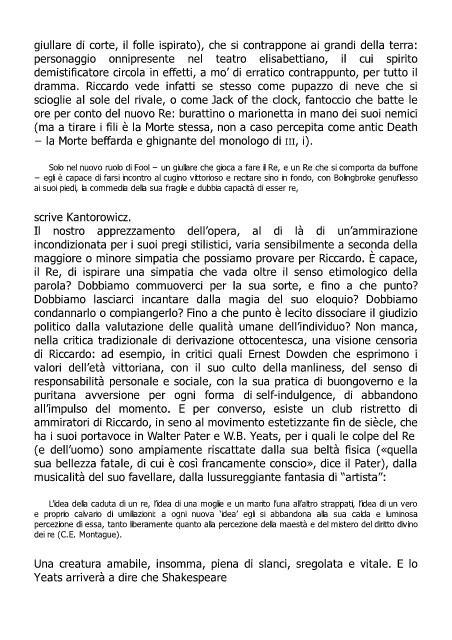Page 2736 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2736
giullare di corte, il folle ispirato), che si contrappone ai grandi della terra:
personaggio onnipresente nel teatro elisabettiano, il cui spirito
demistificatore circola in effetti, a mo’ di erratico contrappunto, per tutto il
dramma. Riccardo vede infatti se stesso come pupazzo di neve che si
scioglie al sole del rivale, o come Jack of the clock, fantoccio che batte le
ore per conto del nuovo Re: burattino o marionetta in mano dei suoi nemici
(ma a tirare i fili è la Morte stessa, non a caso percepita come antic Death
- la Morte beffarda e ghignante del monologo di III, i).
Solo nel nuovo ruolo di Fool - un giullare che gioca a fare il Re, e un Re che si comporta da buffone
- egli è capace di farsi incontro al cugino vittorioso e recitare sino in fondo, con Bolingbroke genuflesso
ai suoi piedi, la commedia della sua fragile e dubbia capacità di esser re,
scrive Kantorowicz.
Il nostro apprezzamento dell’opera, al di là di un’ammirazione
incondizionata per i suoi pregi stilistici, varia sensibilmente a seconda della
maggiore o minore simpatia che possiamo provare per Riccardo. È capace,
il Re, di ispirare una simpatia che vada oltre il senso etimologico della
parola? Dobbiamo commuoverci per la sua sorte, e fino a che punto?
Dobbiamo lasciarci incantare dalla magia del suo eloquio? Dobbiamo
condannarlo o compiangerlo? Fino a che punto è lecito dissociare il giudizio
politico dalla valutazione delle qualità umane dell’individuo? Non manca,
nella critica tradizionale di derivazione ottocentesca, una visione censoria
di Riccardo: ad esempio, in critici quali Ernest Dowden che esprimono i
valori dell’età vittoriana, con il suo culto della manliness, del senso di
responsabilità personale e sociale, con la sua pratica di buongoverno e la
puritana avversione per ogni forma di self-indulgence, di abbandono
all’impulso del momento. E per converso, esiste un club ristretto di
ammiratori di Riccardo, in seno al movimento estetizzante fin de siècle, che
ha i suoi portavoce in Walter Pater e W.B. Yeats, per i quali le colpe del Re
(e dell’uomo) sono ampiamente riscattate dalla sua beltà fisica («quella
sua bellezza fatale, di cui è così francamente conscio», dice il Pater), dalla
musicalità del suo favellare, dalla lussureggiante fantasia di “artista”:
L’idea della caduta di un re, l’idea di una moglie e un marito l’una all’altro strappati, l’idea di un vero
e proprio calvario di umiliazioni: a ogni nuova ‘idea’ egli si abbandona alla sua calda e luminosa
percezione di essa, tanto liberamente quanto alla percezione della maestà e del mistero del diritto divino
dei re (C.E. Montague).
Una creatura amabile, insomma, piena di slanci, sregolata e vitale. E lo
Yeats arriverà a dire che Shakespeare