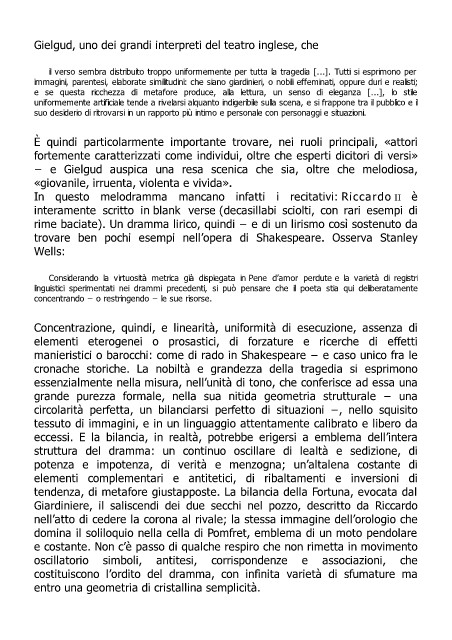Page 2731 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2731
Gielgud, uno dei grandi interpreti del teatro inglese, che
il verso sembra distribuito troppo uniformemente per tutta la tragedia [...]. Tutti si esprimono per
immagini, parentesi, elaborate similitudini: che siano giardinieri, o nobili effeminati, oppure duri e realisti;
e se questa ricchezza di metafore produce, alla lettura, un senso di eleganza [...], lo stile
uniformemente artificiale tende a rivelarsi alquanto indigeribile sulla scena, e si frappone tra il pubblico e il
suo desiderio di ritrovarsi in un rapporto più intimo e personale con personaggi e situazioni.
È quindi particolarmente importante trovare, nei ruoli principali, «attori
fortemente caratterizzati come individui, oltre che esperti dicitori di versi»
- e Gielgud auspica una resa scenica che sia, oltre che melodiosa,
«giovanile, irruenta, violenta e vivida».
In questo melodramma mancano infatti i recitativi: Ri cca rdo II è
interamente scritto in blank verse (decasillabi sciolti, con rari esempi di
rime baciate). Un dramma lirico, quindi - e di un lirismo così sostenuto da
trovare ben pochi esempi nell’opera di Shakespeare. Osserva Stanley
Wells:
Considerando la virtuosità metrica già dispiegata in Pene d’amor perdute e la varietà di registri
linguistici sperimentati nei drammi precedenti, si può pensare che il poeta stia qui deliberatamente
concentrando - o restringendo - le sue risorse.
Concentrazione, quindi, e linearità, uniformità di esecuzione, assenza di
elementi eterogenei o prosastici, di forzature e ricerche di effetti
manieristici o barocchi: come di rado in Shakespeare - e caso unico fra le
cronache storiche. La nobiltà e grandezza della tragedia si esprimono
essenzialmente nella misura, nell’unità di tono, che conferisce ad essa una
grande purezza formale, nella sua nitida geometria strutturale - una
circolarità perfetta, un bilanciarsi perfetto di situazioni -, nello squisito
tessuto di immagini, e in un linguaggio attentamente calibrato e libero da
eccessi. E la bilancia, in realtà, potrebbe erigersi a emblema dell’intera
struttura del dramma: un continuo oscillare di lealtà e sedizione, di
potenza e impotenza, di verità e menzogna; un’altalena costante di
elementi complementari e antitetici, di ribaltamenti e inversioni di
tendenza, di metafore giustapposte. La bilancia della Fortuna, evocata dal
Giardiniere, il saliscendi dei due secchi nel pozzo, descritto da Riccardo
nell’atto di cedere la corona al rivale; la stessa immagine dell’orologio che
domina il soliloquio nella cella di Pomfret, emblema di un moto pendolare
e costante. Non c’è passo di qualche respiro che non rimetta in movimento
oscillatorio simboli, antitesi, corrispondenze e associazioni, che
costituiscono l’ordito del dramma, con infinita varietà di sfumature ma
entro una geometria di cristallina semplicità.