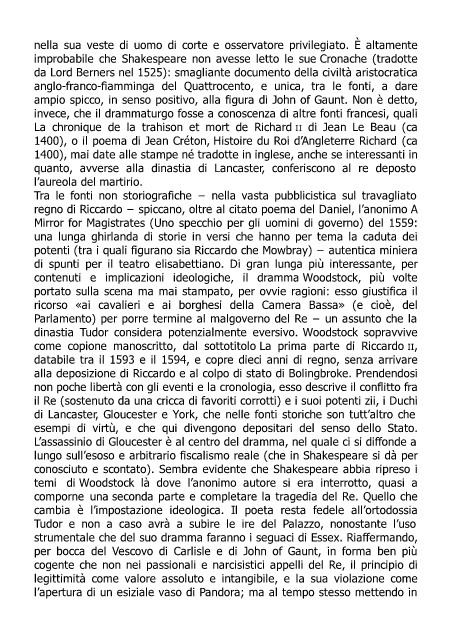Page 2741 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2741
nella sua veste di uomo di corte e osservatore privilegiato. È altamente
improbabile che Shakespeare non avesse letto le sue Cronache (tradotte
da Lord Berners nel 1525): smagliante documento della civiltà aristocratica
anglo-franco-fiamminga del Quattrocento, e unica, tra le fonti, a dare
ampio spicco, in senso positivo, alla figura di John of Gaunt. Non è detto,
invece, che il drammaturgo fosse a conoscenza di altre fonti francesi, quali
La chronique de la trahison et mort de Richard II di Jean Le Beau (ca
1400), o il poema di Jean Créton, Histoire du Roi d’Angleterre Richard (ca
1400), mai date alle stampe né tradotte in inglese, anche se interessanti in
quanto, avverse alla dinastia di Lancaster, conferiscono al re deposto
l’aureola del martirio.
Tra le fonti non storiografiche - nella vasta pubblicistica sul travagliato
regno di Riccardo - spiccano, oltre al citato poema del Daniel, l’anonimo A
Mirror for Magistrates (Uno specchio per gli uomini di governo) del 1559:
una lunga ghirlanda di storie in versi che hanno per tema la caduta dei
potenti (tra i quali figurano sia Riccardo che Mowbray) - autentica miniera
di spunti per il teatro elisabettiano. Di gran lunga più interessante, per
contenuti e implicazioni ideologiche, il dramma Woodstock, più volte
portato sulla scena ma mai stampato, per ovvie ragioni: esso giustifica il
ricorso «ai cavalieri e ai borghesi della Camera Bassa» (e cioè, del
Parlamento) per porre termine al malgoverno del Re - un assunto che la
dinastia Tudor considera potenzialmente eversivo. Woodstock sopravvive
come copione manoscritto, dal sottotitolo La prima parte di Riccardo II,
databile tra il 1593 e il 1594, e copre dieci anni di regno, senza arrivare
alla deposizione di Riccardo e al colpo di stato di Bolingbroke. Prendendosi
non poche libertà con gli eventi e la cronologia, esso descrive il conflitto fra
il Re (sostenuto da una cricca di favoriti corrotti) e i suoi potenti zii, i Duchi
di Lancaster, Gloucester e York, che nelle fonti storiche son tutt’altro che
esempi di virtù, e che qui divengono depositari del senso dello Stato.
L’assassinio di Gloucester è al centro del dramma, nel quale ci si diffonde a
lungo sull’esoso e arbitrario fiscalismo reale (che in Shakespeare si dà per
conosciuto e scontato). Sembra evidente che Shakespeare abbia ripreso i
temi di Woodstock là dove l’anonimo autore si era interrotto, quasi a
comporne una seconda parte e completare la tragedia del Re. Quello che
cambia è l’impostazione ideologica. Il poeta resta fedele all’ortodossia
Tudor e non a caso avrà a subire le ire del Palazzo, nonostante l’uso
strumentale che del suo dramma faranno i seguaci di Essex. Riaffermando,
per bocca del Vescovo di Carlisle e di John of Gaunt, in forma ben più
cogente che non nei passionali e narcisistici appelli del Re, il principio di
legittimità come valore assoluto e intangibile, e la sua violazione come
l’apertura di un esiziale vaso di Pandora; ma al tempo stesso mettendo in