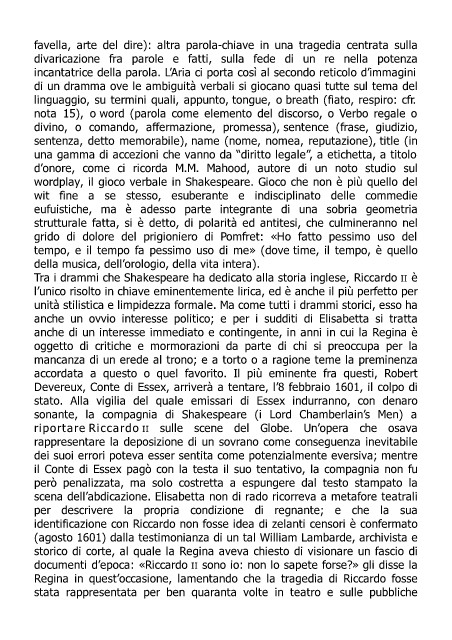Page 2733 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2733
favella, arte del dire): altra parola-chiave in una tragedia centrata sulla
divaricazione fra parole e fatti, sulla fede di un re nella potenza
incantatrice della parola. L’Aria ci porta così al secondo reticolo d’immagini
di un dramma ove le ambiguità verbali si giocano quasi tutte sul tema del
linguaggio, su termini quali, appunto, tongue, o breath (fiato, respiro: cfr.
nota 15), o word (parola come elemento del discorso, o Verbo regale o
divino, o comando, affermazione, promessa), sentence (frase, giudizio,
sentenza, detto memorabile), name (nome, nomea, reputazione), title (in
una gamma di accezioni che vanno da “diritto legale”, a etichetta, a titolo
d’onore, come ci ricorda M.M. Mahood, autore di un noto studio sul
wordplay, il gioco verbale in Shakespeare. Gioco che non è più quello del
wit fine a se stesso, esuberante e indisciplinato delle commedie
eufuistiche, ma è adesso parte integrante di una sobria geometria
strutturale fatta, si è detto, di polarità ed antitesi, che culmineranno nel
grido di dolore del prigioniero di Pomfret: «Ho fatto pessimo uso del
tempo, e il tempo fa pessimo uso di me» (dove time, il tempo, è quello
della musica, dell’orologio, della vita intera).
Tra i drammi che Shakespeare ha dedicato alla storia inglese, Riccardo II è
l’unico risolto in chiave eminentemente lirica, ed è anche il più perfetto per
unità stilistica e limpidezza formale. Ma come tutti i drammi storici, esso ha
anche un ovvio interesse politico; e per i sudditi di Elisabetta si tratta
anche di un interesse immediato e contingente, in anni in cui la Regina è
oggetto di critiche e mormorazioni da parte di chi si preoccupa per la
mancanza di un erede al trono; e a torto o a ragione teme la preminenza
accordata a questo o quel favorito. Il più eminente fra questi, Robert
Devereux, Conte di Essex, arriverà a tentare, l’8 febbraio 1601, il colpo di
stato. Alla vigilia del quale emissari di Essex indurranno, con denaro
sonante, la compagnia di Shakespeare (i Lord Chamberlain’s Men) a
ri porta re Ri cca rdo II sulle scene del Globe. Un’opera che osava
rappresentare la deposizione di un sovrano come conseguenza inevitabile
dei suoi errori poteva esser sentita come potenzialmente eversiva; mentre
il Conte di Essex pagò con la testa il suo tentativo, la compagnia non fu
però penalizzata, ma solo costretta a espungere dal testo stampato la
scena dell’abdicazione. Elisabetta non di rado ricorreva a metafore teatrali
per descrivere la propria condizione di regnante; e che la sua
identificazione con Riccardo non fosse idea di zelanti censori è confermato
(agosto 1601) dalla testimonianza di un tal William Lambarde, archivista e
storico di corte, al quale la Regina aveva chiesto di visionare un fascio di
documenti d’epoca: «Riccardo II sono io: non lo sapete forse?» gli disse la
Regina in quest’occasione, lamentando che la tragedia di Riccardo fosse
stata rappresentata per ben quaranta volte in teatro e sulle pubbliche