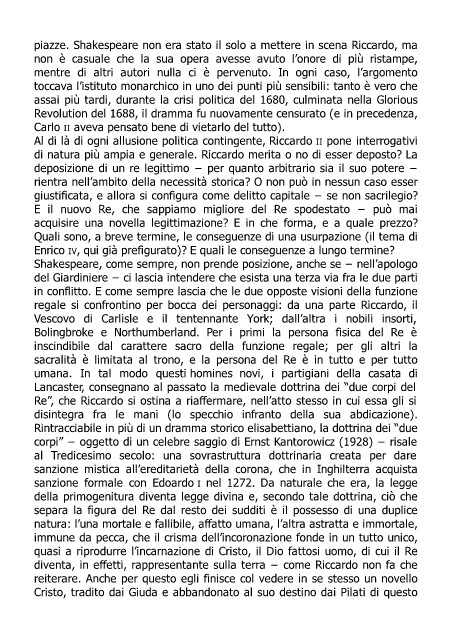Page 2734 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2734
piazze. Shakespeare non era stato il solo a mettere in scena Riccardo, ma
non è casuale che la sua opera avesse avuto l’onore di più ristampe,
mentre di altri autori nulla ci è pervenuto. In ogni caso, l’argomento
toccava l’istituto monarchico in uno dei punti più sensibili: tanto è vero che
assai più tardi, durante la crisi politica del 1680, culminata nella Glorious
Revolution del 1688, il dramma fu nuovamente censurato (e in precedenza,
Carlo II aveva pensato bene di vietarlo del tutto).
Al di là di ogni allusione politica contingente, Riccardo II pone interrogativi
di natura più ampia e generale. Riccardo merita o no di esser deposto? La
deposizione di un re legittimo - per quanto arbitrario sia il suo potere -
rientra nell’ambito della necessità storica? O non può in nessun caso esser
giustificata, e allora si configura come delitto capitale - se non sacrilegio?
E il nuovo Re, che sappiamo migliore del Re spodestato - può mai
acquisire una novella legittimazione? E in che forma, e a quale prezzo?
Quali sono, a breve termine, le conseguenze di una usurpazione (il tema di
Enrico IV, qui già prefigurato)? E quali le conseguenze a lungo termine?
Shakespeare, come sempre, non prende posizione, anche se - nell’apologo
del Giardiniere - ci lascia intendere che esista una terza via fra le due parti
in conflitto. E come sempre lascia che le due opposte visioni della funzione
regale si confrontino per bocca dei personaggi: da una parte Riccardo, il
Vescovo di Carlisle e il tentennante York; dall’altra i nobili insorti,
Bolingbroke e Northumberland. Per i primi la persona fisica del Re è
inscindibile dal carattere sacro della funzione regale; per gli altri la
sacralità è limitata al trono, e la persona del Re è in tutto e per tutto
umana. In tal modo questi homines novi, i partigiani della casata di
Lancaster, consegnano al passato la medievale dottrina dei “due corpi del
Re”, che Riccardo si ostina a riaffermare, nell’atto stesso in cui essa gli si
disintegra fra le mani (lo specchio infranto della sua abdicazione).
Rintracciabile in più di un dramma storico elisabettiano, la dottrina dei “due
corpi” - oggetto di un celebre saggio di Ernst Kantorowicz (1928) - risale
al Tredicesimo secolo: una sovrastruttura dottrinaria creata per dare
sanzione mistica all’ereditarietà della corona, che in Inghilterra acquista
sanzione formale con Edoardo I nel 1272. Da naturale che era, la legge
della primogenitura diventa legge divina e, secondo tale dottrina, ciò che
separa la figura del Re dal resto dei sudditi è il possesso di una duplice
natura: l’una mortale e fallibile, affatto umana, l’altra astratta e immortale,
immune da pecca, che il crisma dell’incoronazione fonde in un tutto unico,
quasi a riprodurre l’incarnazione di Cristo, il Dio fattosi uomo, di cui il Re
diventa, in effetti, rappresentante sulla terra - come Riccardo non fa che
reiterare. Anche per questo egli finisce col vedere in se stesso un novello
Cristo, tradito dai Giuda e abbandonato al suo destino dai Pilati di questo