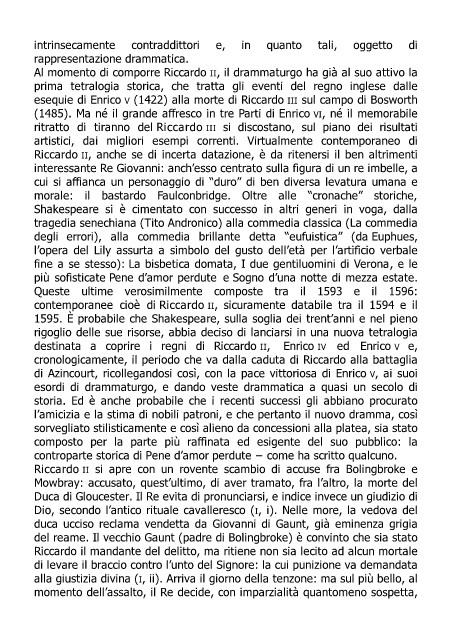Page 2726 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2726
intrinsecamente contraddittori e, in quanto tali, oggetto di
rappresentazione drammatica.
Al momento di comporre Riccardo II, il drammaturgo ha già al suo attivo la
prima tetralogia storica, che tratta gli eventi del regno inglese dalle
esequie di Enrico V (1422) alla morte di Riccardo III sul campo di Bosworth
(1485). Ma né il grande affresco in tre Parti di Enrico VI, né il memorabile
ritratto di tiranno del Riccardo III si discostano, sul piano dei risultati
artistici, dai migliori esempi correnti. Virtualmente contemporaneo di
Riccardo II, anche se di incerta datazione, è da ritenersi il ben altrimenti
interessante Re Giovanni: anch’esso centrato sulla figura di un re imbelle, a
cui si affianca un personaggio di “duro” di ben diversa levatura umana e
morale: il bastardo Faulconbridge. Oltre alle “cronache” storiche,
Shakespeare si è cimentato con successo in altri generi in voga, dalla
tragedia senechiana (Tito Andronico) alla commedia classica (La commedia
degli errori), alla commedia brillante detta “eufuistica” (da Euphues,
l’opera del Lily assurta a simbolo del gusto dell’età per l’artificio verbale
fine a se stesso): La bisbetica domata, I due gentiluomini di Verona, e le
più sofisticate Pene d’amor perdute e Sogno d’una notte di mezza estate.
Queste ultime verosimilmente composte tra il 1593 e il 1596:
contemporanee cioè di Riccardo II, sicuramente databile tra il 1594 e il
1595. È probabile che Shakespeare, sulla soglia dei trent’anni e nel pieno
rigoglio delle sue risorse, abbia deciso di lanciarsi in una nuova tetralogia
destinata a coprire i regni di Riccardo II, Enrico IV ed Enrico V e,
cronologicamente, il periodo che va dalla caduta di Riccardo alla battaglia
di Azincourt, ricollegandosi così, con la pace vittoriosa di Enrico V, ai suoi
esordi di drammaturgo, e dando veste drammatica a quasi un secolo di
storia. Ed è anche probabile che i recenti successi gli abbiano procurato
l’amicizia e la stima di nobili patroni, e che pertanto il nuovo dramma, così
sorvegliato stilisticamente e così alieno da concessioni alla platea, sia stato
composto per la parte più raffinata ed esigente del suo pubblico: la
controparte storica di Pene d’amor perdute - come ha scritto qualcuno.
Riccardo II si apre con un rovente scambio di accuse fra Bolingbroke e
Mowbray: accusato, quest’ultimo, di aver tramato, fra l’altro, la morte del
Duca di Gloucester. Il Re evita di pronunciarsi, e indice invece un giudizio di
Dio, secondo l’antico rituale cavalleresco (I, i). Nelle more, la vedova del
duca ucciso reclama vendetta da Giovanni di Gaunt, già eminenza grigia
del reame. Il vecchio Gaunt (padre di Bolingbroke) è convinto che sia stato
Riccardo il mandante del delitto, ma ritiene non sia lecito ad alcun mortale
di levare il braccio contro l’unto del Signore: la cui punizione va demandata
alla giustizia divina (I, ii). Arriva il giorno della tenzone: ma sul più bello, al
momento dell’assalto, il Re decide, con imparzialità quantomeno sospetta,