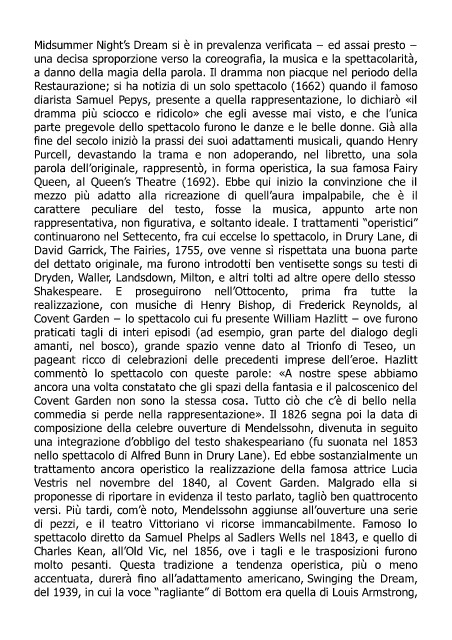Page 2528 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2528
Midsummer Night’s Dream si è in prevalenza verificata - ed assai presto -
una decisa sproporzione verso la coreografia, la musica e la spettacolarità,
a danno della magia della parola. Il dramma non piacque nel periodo della
Restaurazione; si ha notizia di un solo spettacolo (1662) quando il famoso
diarista Samuel Pepys, presente a quella rappresentazione, lo dichiarò «il
dramma più sciocco e ridicolo» che egli avesse mai visto, e che l’unica
parte pregevole dello spettacolo furono le danze e le belle donne. Già alla
fine del secolo iniziò la prassi dei suoi adattamenti musicali, quando Henry
Purcell, devastando la trama e non adoperando, nel libretto, una sola
parola dell’originale, rappresentò, in forma operistica, la sua famosa Fairy
Queen, al Queen’s Theatre (1692). Ebbe qui inizio la convinzione che il
mezzo più adatto alla ricreazione di quell’aura impalpabile, che è il
carattere peculiare del testo, fosse la musica, appunto arte non
rappresentativa, non figurativa, e soltanto ideale. I trattamenti “operistici”
continuarono nel Settecento, fra cui eccelse lo spettacolo, in Drury Lane, di
David Garrick, The Fairies, 1755, ove venne sì rispettata una buona parte
del dettato originale, ma furono introdotti ben ventisette songs su testi di
Dryden, Waller, Landsdown, Milton, e altri tolti ad altre opere dello stesso
Shakespeare. E proseguirono nell’Ottocento, prima fra tutte la
realizzazione, con musiche di Henry Bishop, di Frederick Reynolds, al
Covent Garden - lo spettacolo cui fu presente William Hazlitt - ove furono
praticati tagli di interi episodi (ad esempio, gran parte del dialogo degli
amanti, nel bosco), grande spazio venne dato al Trionfo di Teseo, un
pageant ricco di celebrazioni delle precedenti imprese dell’eroe. Hazlitt
commentò lo spettacolo con queste parole: «A nostre spese abbiamo
ancora una volta constatato che gli spazi della fantasia e il palcoscenico del
Covent Garden non sono la stessa cosa. Tutto ciò che c’è di bello nella
commedia si perde nella rappresentazione». Il 1826 segna poi la data di
composizione della celebre ouverture di Mendelssohn, divenuta in seguito
una integrazione d’obbligo del testo shakespeariano (fu suonata nel 1853
nello spettacolo di Alfred Bunn in Drury Lane). Ed ebbe sostanzialmente un
trattamento ancora operistico la realizzazione della famosa attrice Lucia
Vestris nel novembre del 1840, al Covent Garden. Malgrado ella si
proponesse di riportare in evidenza il testo parlato, tagliò ben quattrocento
versi. Più tardi, com’è noto, Mendelssohn aggiunse all’ouverture una serie
di pezzi, e il teatro Vittoriano vi ricorse immancabilmente. Famoso lo
spettacolo diretto da Samuel Phelps al Sadlers Wells nel 1843, e quello di
Charles Kean, all’Old Vic, nel 1856, ove i tagli e le trasposizioni furono
molto pesanti. Questa tradizione a tendenza operistica, più o meno
accentuata, durerà fino all’adattamento americano, Swinging the Dream,
del 1939, in cui la voce “ragliante” di Bottom era quella di Louis Armstrong,