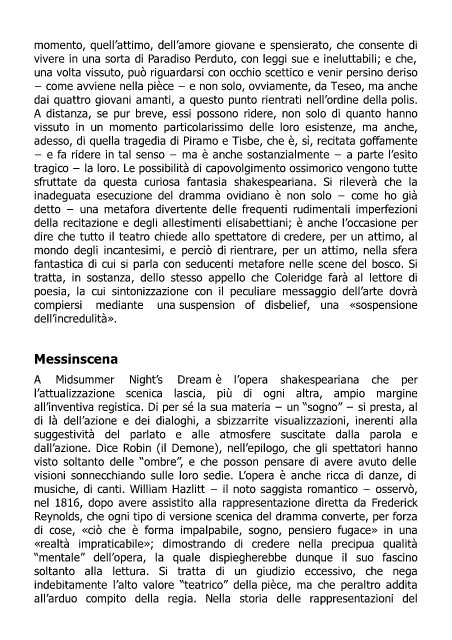Page 2527 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2527
momento, quell’attimo, dell’amore giovane e spensierato, che consente di
vivere in una sorta di Paradiso Perduto, con leggi sue e ineluttabili; e che,
una volta vissuto, può riguardarsi con occhio scettico e venir persino deriso
- come avviene nella pièce - e non solo, ovviamente, da Teseo, ma anche
dai quattro giovani amanti, a questo punto rientrati nell’ordine della polis.
A distanza, se pur breve, essi possono ridere, non solo di quanto hanno
vissuto in un momento particolarissimo delle loro esistenze, ma anche,
adesso, di quella tragedia di Piramo e Tisbe, che è, sì, recitata goffamente
- e fa ridere in tal senso - ma è anche sostanzialmente - a parte l’esito
tragico - la loro. Le possibilità di capovolgimento ossimorico vengono tutte
sfruttate da questa curiosa fantasia shakespeariana. Si rileverà che la
inadeguata esecuzione del dramma ovidiano è non solo - come ho già
detto - una metafora divertente delle frequenti rudimentali imperfezioni
della recitazione e degli allestimenti elisabettiani; è anche l’occasione per
dire che tutto il teatro chiede allo spettatore di credere, per un attimo, al
mondo degli incantesimi, e perciò di rientrare, per un attimo, nella sfera
fantastica di cui si parla con seducenti metafore nelle scene del bosco. Si
tratta, in sostanza, dello stesso appello che Coleridge farà al lettore di
poesia, la cui sintonizzazione con il peculiare messaggio dell’arte dovrà
compiersi mediante una suspension of disbelief, una «sospensione
dell’incredulità».
Messinscena
A Midsummer Night’s Dream è l’opera shakespeariana che per
l’attualizzazione scenica lascia, più di ogni altra, ampio margine
all’inventiva registica. Di per sé la sua materia - un “sogno” - si presta, al
di là dell’azione e dei dialoghi, a sbizzarrite visualizzazioni, inerenti alla
suggestività del parlato e alle atmosfere suscitate dalla parola e
dall’azione. Dice Robin (il Demone), nell’epilogo, che gli spettatori hanno
visto soltanto delle “ombre”, e che posson pensare di avere avuto delle
visioni sonnecchiando sulle loro sedie. L’opera è anche ricca di danze, di
musiche, di canti. William Hazlitt - il noto saggista romantico - osservò,
nel 1816, dopo avere assistito alla rappresentazione diretta da Frederick
Reynolds, che ogni tipo di versione scenica del dramma converte, per forza
di cose, «ciò che è forma impalpabile, sogno, pensiero fugace» in una
«realtà impraticabile»; dimostrando di credere nella precipua qualità
“mentale” dell’opera, la quale dispiegherebbe dunque il suo fascino
soltanto alla lettura. Si tratta di un giudizio eccessivo, che nega
indebitamente l’alto valore “teatrico” della pièce, ma che peraltro addita
all’arduo compito della regia. Nella storia delle rappresentazioni del