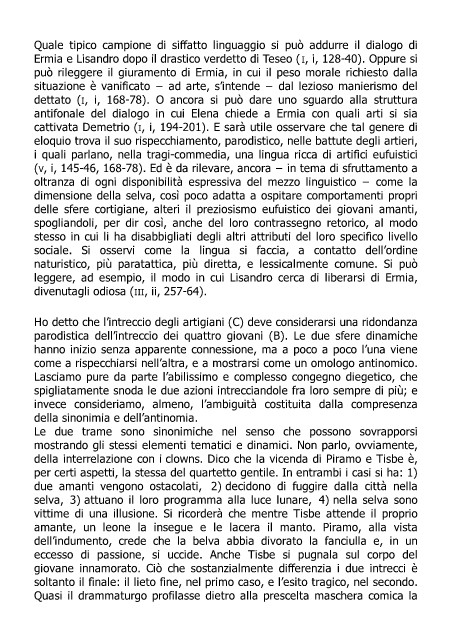Page 2522 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2522
Quale tipico campione di siffatto linguaggio si può addurre il dialogo di
Ermia e Lisandro dopo il drastico verdetto di Teseo ( I, i, 128-40). Oppure si
può rileggere il giuramento di Ermia, in cui il peso morale richiesto dalla
situazione è vanificato - ad arte, s’intende - dal lezioso manierismo del
dettato (I, i, 168-78). O ancora si può dare uno sguardo alla struttura
antifonale del dialogo in cui Elena chiede a Ermia con quali arti si sia
cattivata Demetrio (I, i, 194-201). E sarà utile osservare che tal genere di
eloquio trova il suo rispecchiamento, parodistico, nelle battute degli artieri,
i quali parlano, nella tragi-commedia, una lingua ricca di artifici eufuistici
(V, i, 145-46, 168-78). Ed è da rilevare, ancora - in tema di sfruttamento a
oltranza di ogni disponibilità espressiva del mezzo linguistico - come la
dimensione della selva, così poco adatta a ospitare comportamenti propri
delle sfere cortigiane, alteri il preziosismo eufuistico dei giovani amanti,
spogliandoli, per dir così, anche del loro contrassegno retorico, al modo
stesso in cui li ha disabbigliati degli altri attributi del loro specifico livello
sociale. Si osservi come la lingua si faccia, a contatto dell’ordine
naturistico, più paratattica, più diretta, e lessicalmente comune. Si può
leggere, ad esempio, il modo in cui Lisandro cerca di liberarsi di Ermia,
divenutagli odiosa (III, ii, 257-64).
Ho detto che l’intreccio degli artigiani (C) deve considerarsi una ridondanza
parodistica dell’intreccio dei quattro giovani (B). Le due sfere dinamiche
hanno inizio senza apparente connessione, ma a poco a poco l’una viene
come a rispecchiarsi nell’altra, e a mostrarsi come un omologo antinomico.
Lasciamo pure da parte l’abilissimo e complesso congegno diegetico, che
spigliatamente snoda le due azioni intrecciandole fra loro sempre di più; e
invece consideriamo, almeno, l’ambiguità costituita dalla compresenza
della sinonimia e dell’antinomia.
Le due trame sono sinonimiche nel senso che possono sovrapporsi
mostrando gli stessi elementi tematici e dinamici. Non parlo, ovviamente,
della interrelazione con i clowns. Dico che la vicenda di Piramo e Tisbe è,
per certi aspetti, la stessa del quartetto gentile. In entrambi i casi si ha: 1)
due amanti vengono ostacolati, 2) decidono di fuggire dalla città nella
selva, 3) attuano il loro programma alla luce lunare, 4) nella selva sono
vittime di una illusione. Si ricorderà che mentre Tisbe attende il proprio
amante, un leone la insegue e le lacera il manto. Piramo, alla vista
dell’indumento, crede che la belva abbia divorato la fanciulla e, in un
eccesso di passione, si uccide. Anche Tisbe si pugnala sul corpo del
giovane innamorato. Ciò che sostanzialmente differenzia i due intrecci è
soltanto il finale: il lieto fine, nel primo caso, e l’esito tragico, nel secondo.
Quasi il drammaturgo profilasse dietro alla prescelta maschera comica la