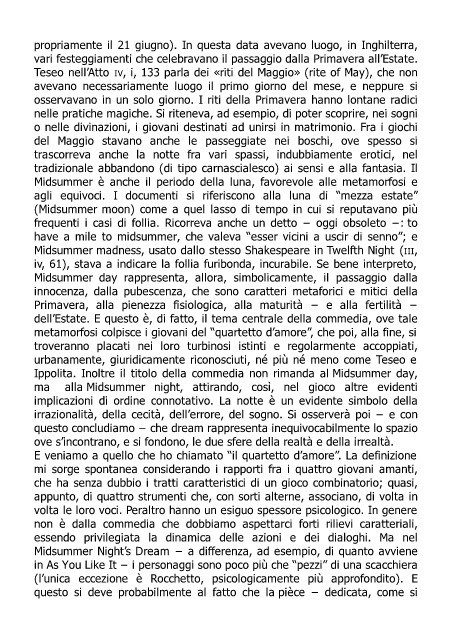Page 2517 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2517
propriamente il 21 giugno). In questa data avevano luogo, in Inghilterra,
vari festeggiamenti che celebravano il passaggio dalla Primavera all’Estate.
Teseo nell’Atto IV, i, 133 parla dei «riti del Maggio» (rite of May), che non
avevano necessariamente luogo il primo giorno del mese, e neppure si
osservavano in un solo giorno. I riti della Primavera hanno lontane radici
nelle pratiche magiche. Si riteneva, ad esempio, di poter scoprire, nei sogni
o nelle divinazioni, i giovani destinati ad unirsi in matrimonio. Fra i giochi
del Maggio stavano anche le passeggiate nei boschi, ove spesso si
trascorreva anche la notte fra vari spassi, indubbiamente erotici, nel
tradizionale abbandono (di tipo carnascialesco) ai sensi e alla fantasia. Il
Midsummer è anche il periodo della luna, favorevole alle metamorfosi e
agli equivoci. I documenti si riferiscono alla luna di “mezza estate”
(Midsummer moon) come a quel lasso di tempo in cui si reputavano più
frequenti i casi di follia. Ricorreva anche un detto - oggi obsoleto -: to
have a mile to midsummer, che valeva “esser vicini a uscir di senno”; e
Midsummer madness, usato dallo stesso Shakespeare in Twelfth Night (III,
iv, 61), stava a indicare la follia furibonda, incurabile. Se bene interpreto,
Midsummer day rappresenta, allora, simbolicamente, il passaggio dalla
innocenza, dalla pubescenza, che sono caratteri metaforici e mitici della
Primavera, alla pienezza fisiologica, alla maturità - e alla fertilità -
dell’Estate. E questo è, di fatto, il tema centrale della commedia, ove tale
metamorfosi colpisce i giovani del “quartetto d’amore”, che poi, alla fine, si
troveranno placati nei loro turbinosi istinti e regolarmente accoppiati,
urbanamente, giuridicamente riconosciuti, né più né meno come Teseo e
Ippolita. Inoltre il titolo della commedia non rimanda al Midsummer day,
ma alla Midsummer night, attirando, così, nel gioco altre evidenti
implicazioni di ordine connotativo. La notte è un evidente simbolo della
irrazionalità, della cecità, dell’errore, del sogno. Si osserverà poi - e con
questo concludiamo - che dream rappresenta inequivocabilmente lo spazio
ove s’incontrano, e si fondono, le due sfere della realtà e della irrealtà.
E veniamo a quello che ho chiamato “il quartetto d’amore”. La definizione
mi sorge spontanea considerando i rapporti fra i quattro giovani amanti,
che ha senza dubbio i tratti caratteristici di un gioco combinatorio; quasi,
appunto, di quattro strumenti che, con sorti alterne, associano, di volta in
volta le loro voci. Peraltro hanno un esiguo spessore psicologico. In genere
non è dalla commedia che dobbiamo aspettarci forti rilievi caratteriali,
essendo privilegiata la dinamica delle azioni e dei dialoghi. Ma nel
Midsummer Night’s Dream - a differenza, ad esempio, di quanto avviene
in As You Like It - i personaggi sono poco più che “pezzi” di una scacchiera
(l’unica eccezione è Rocchetto, psicologicamente più approfondito). E
questo si deve probabilmente al fatto che la pièce - dedicata, come si