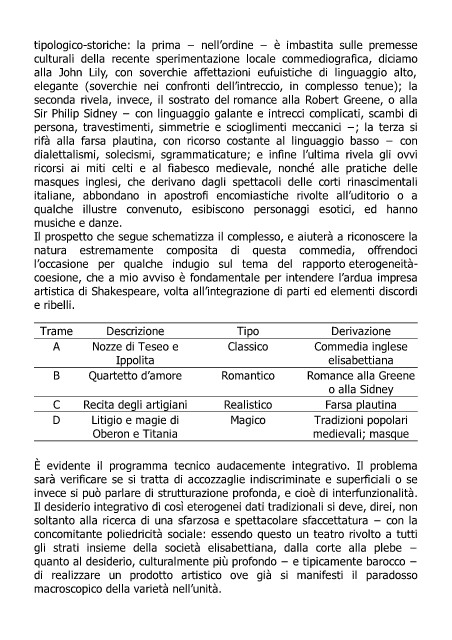Page 2512 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2512
tipologico-storiche: la prima - nell’ordine - è imbastita sulle premesse
culturali della recente sperimentazione locale commediografica, diciamo
alla John Lily, con soverchie affettazioni eufuistiche di linguaggio alto,
elegante (soverchie nei confronti dell’intreccio, in complesso tenue); la
seconda rivela, invece, il sostrato del romance alla Robert Greene, o alla
Sir Philip Sidney - con linguaggio galante e intrecci complicati, scambi di
persona, travestimenti, simmetrie e scioglimenti meccanici -; la terza si
rifà alla farsa plautina, con ricorso costante al linguaggio basso - con
dialettalismi, solecismi, sgrammaticature; e infine l’ultima rivela gli ovvi
ricorsi ai miti celti e al fiabesco medievale, nonché alle pratiche delle
masques inglesi, che derivano dagli spettacoli delle corti rinascimentali
italiane, abbondano in apostrofi encomiastiche rivolte all’uditorio o a
qualche illustre convenuto, esibiscono personaggi esotici, ed hanno
musiche e danze.
Il prospetto che segue schematizza il complesso, e aiuterà a riconoscere la
natura estremamente composita di questa commedia, offrendoci
l’occasione per qualche indugio sul tema del rapporto eterogeneità-
coesione, che a mio avviso è fondamentale per intendere l’ardua impresa
artistica di Shakespeare, volta all’integrazione di parti ed elementi discordi
e ribelli.
Trame Descrizione Tipo Derivazione
A Nozze di Teseo e Classico
Commedia inglese
B Ippolita Romantico elisabettiana
Quartetto d’amore
Realistico Romance alla Greene
C Recita degli artigiani Magico o alla Sidney
D Litigio e magie di Farsa plautina
Oberon e Titania
Tradizioni popolari
medievali; masque
È evidente il programma tecnico audacemente integrativo. Il problema
sarà verificare se si tratta di accozzaglie indiscriminate e superficiali o se
invece si può parlare di strutturazione profonda, e cioè di interfunzionalità.
Il desiderio integrativo di così eterogenei dati tradizionali si deve, direi, non
soltanto alla ricerca di una sfarzosa e spettacolare sfaccettatura - con la
concomitante poliedricità sociale: essendo questo un teatro rivolto a tutti
gli strati insieme della società elisabettiana, dalla corte alla plebe -
quanto al desiderio, culturalmente più profondo - e tipicamente barocco -
di realizzare un prodotto artistico ove già si manifesti il paradosso
macroscopico della varietà nell’unità.