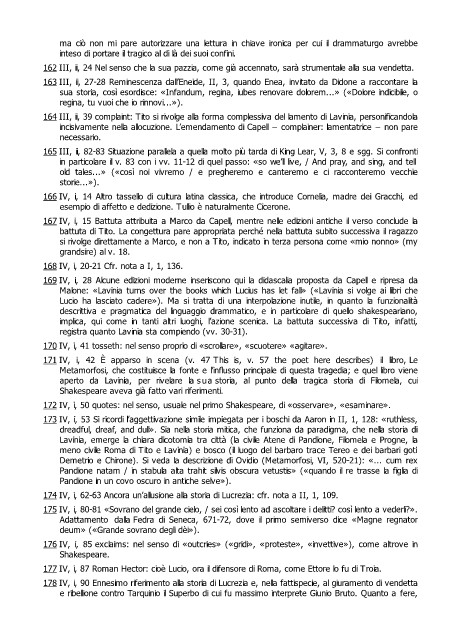Page 2224 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2224
ma ciò non mi pare autorizzare una lettura in chiave ironica per cui il drammaturgo avrebbe
inteso di portare il tragico al di là dei suoi confini.
162 III, ii, 24 Nel senso che la sua pazzia, come già accennato, sarà strumentale alla sua vendetta.
163 III, ii, 27-28 Reminescenza dall’Eneide, II, 3, quando Enea, invitato da Didone a raccontare la
sua storia, così esordisce: «Infandum, regina, iubes renovare dolorem...» («Dolore indicibile, o
regina, tu vuoi che io rinnovi...»).
164 III, ii, 39 complaint: Tito si rivolge alla forma complessiva del lamento di Lavinia, personificandola
incisivamente nella allocuzione. L’emendamento di Capell - complainer: lamentatrice - non pare
necessario.
165 III, ii, 82-83 Situazione parallela a quella molto più tarda di King Lear, V, 3, 8 e sgg. Si confronti
in particolare il v. 83 con i vv. 11-12 di quel passo: «so we’ll live, / And pray, and sing, and tell
old tales...» («così noi vivremo / e pregheremo e canteremo e ci racconteremo vecchie
storie...»).
166 IV, i, 14 Altro tassello di cultura latina classica, che introduce Cornelia, madre dei Gracchi, ed
esempio di affetto e dedizione. Tullio è naturalmente Cicerone.
167 IV, i, 15 Battuta attribuita a Marco da Capell, mentre nelle edizioni antiche il verso conclude la
battuta di Tito. La congettura pare appropriata perché nella battuta subito successiva il ragazzo
si rivolge direttamente a Marco, e non a Tito, indicato in terza persona come «mio nonno» (my
grandsire) al v. 18.
168 IV, i, 20-21 Cfr. nota a I, 1, 136.
169 IV, i, 28 Alcune edizioni moderne inseriscono qui la didascalia proposta da Capell e ripresa da
Malone: «Lavinia turns over the books which Lucius has let fall» («Lavinia si volge ai libri che
Lucio ha lasciato cadere»). Ma si tratta di una interpolazione inutile, in quanto la funzionalità
descrittiva e pragmatica del linguaggio drammatico, e in particolare di quello shakespeariano,
implica, qui come in tanti altri luoghi, l’azione scenica. La battuta successiva di Tito, infatti,
registra quanto Lavinia sta compiendo (vv. 30-31).
170 IV, i, 41 tosseth: nel senso proprio di «scrollare», «scuotere» «agitare».
171 IV, i, 42 È apparso in scena (v. 47 This is, v. 57 the poet here describes) il libro, Le
Metamorfosi, che costituisce la fonte e l’influsso principale di questa tragedia; e quel libro viene
aperto da Lavinia, per rivelare la s u a storia, al punto della tragica storia di Filomela, cui
Shakespeare aveva già fatto vari riferimenti.
172 IV, i, 50 quotes: nel senso, usuale nel primo Shakespeare, di «osservare», «esaminare».
173 IV, i, 53 Si ricordi l’aggettivazione simile impiegata per i boschi da Aaron in II, 1, 128: «ruthless,
dreadful, dreaf, and dull». Sia nella storia mitica, che funziona da paradigma, che nella storia di
Lavinia, emerge la chiara dicotomia tra città (la civile Atene di Pandione, Filomela e Progne, la
meno civile Roma di Tito e Lavinia) e bosco (il luogo del barbaro trace Tereo e dei barbari goti
Demetrio e Chirone). Si veda la descrizione di Ovidio (Metamorfosi, VI, 520-21): «... cum rex
Pandione natam / in stabula alta trahit silvis obscura vetustis» («quando il re trasse la figlia di
Pandione in un covo oscuro in antiche selve»).
174 IV, i, 62-63 Ancora un’allusione alla storia di Lucrezia: cfr. nota a II, 1, 109.
175 IV, i, 80-81 «Sovrano del grande cielo, / sei così lento ad ascoltare i delitti? così lento a vederli?».
Adattamento dalla Fedra di Seneca, 671-72, dove il primo semiverso dice «Magne regnator
deum» («Grande sovrano degli dèi»).
176 IV, i, 85 exclaims: nel senso di «outcries» («gridi», «proteste», «invettive»), come altrove in
Shakespeare.
177 IV, i, 87 Roman Hector: cioè Lucio, ora il difensore di Roma, come Ettore lo fu di Troia.
178 IV, i, 90 Ennesimo riferimento alla storia di Lucrezia e, nella fattispecie, al giuramento di vendetta
e ribellione contro Tarquinio il Superbo di cui fu massimo interprete Giunio Bruto. Quanto a fere,