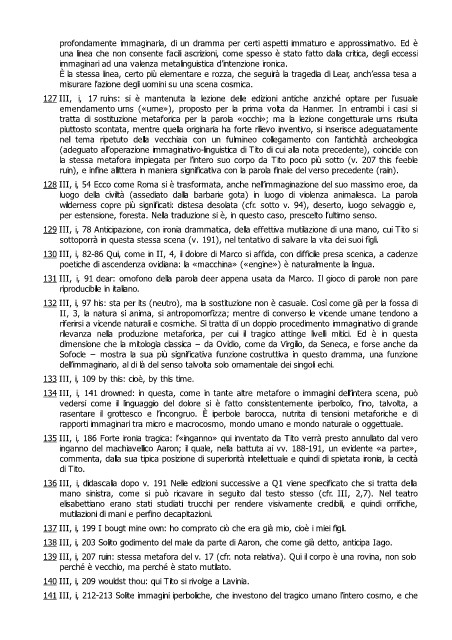Page 2221 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2221
profondamente immaginaria, di un dramma per certi aspetti immaturo e approssimativo. Ed è
una linea che non consente facili ascrizioni, come spesso è stato fatto dalla critica, degli eccessi
immaginari ad una valenza metalinguistica d’intenzione ironica.
È la stessa linea, certo più elementare e rozza, che seguirà la tragedia di Lear, anch’essa tesa a
misurare l’azione degli uomini su una scena cosmica.
127 III, i, 17 ruins: si è mantenuta la lezione delle edizioni antiche anziché optare per l’usuale
emendamento urns («urne»), proposto per la prima volta da Hanmer. In entrambi i casi si
tratta di sostituzione metaforica per la parola «occhi»; ma la lezione congetturale urns risulta
piuttosto scontata, mentre quella originaria ha forte rilievo inventivo, si inserisce adeguatamente
nel tema ripetuto della vecchiaia con un fulmineo collegamento con l’antichità archeologica
(adeguato all’operazione immaginativo-linguistica di Tito di cui alla nota precedente), coincide con
la stessa metafora impiegata per l’intero suo corpo da Tito poco più sotto (v. 207 this feeble
ruin), e infine allittera in maniera significativa con la parola finale del verso precedente (rain).
128 III, i, 54 Ecco come Roma si è trasformata, anche nell’immaginazione del suo massimo eroe, da
luogo della civiltà (assediato dalla barbarie gota) in luogo di violenza animalesca. La parola
wilderness copre più significati: distesa desolata (cfr. sotto v. 94), deserto, luogo selvaggio e,
per estensione, foresta. Nella traduzione si è, in questo caso, prescelto l’ultimo senso.
129 III, i, 78 Anticipazione, con ironia drammatica, della effettiva mutilazione di una mano, cui Tito si
sottoporrà in questa stessa scena (v. 191), nel tentativo di salvare la vita dei suoi figli.
130 III, i, 82-86 Qui, come in II, 4, il dolore di Marco si affida, con difficile presa scenica, a cadenze
poetiche di ascendenza ovidiana: la «macchina» («engine») è naturalmente la lingua.
131 III, i, 91 dear: omofono della parola deer appena usata da Marco. Il gioco di parole non pare
riproducibile in italiano.
132 III, i, 97 his: sta per its (neutro), ma la sostituzione non è casuale. Così come già per la fossa di
II, 3, la natura si anima, si antropomorfizza; mentre di converso le vicende umane tendono a
riferirsi a vicende naturali e cosmiche. Si tratta di un doppio procedimento immaginativo di grande
rilevanza nella produzione metaforica, per cui il tragico attinge livelli mitici. Ed è in questa
dimensione che la mitologia classica - da Ovidio, come da Virgilio, da Seneca, e forse anche da
Sofocle - mostra la sua più significativa funzione costruttiva in questo dramma, una funzione
dell’immaginario, al di là del senso talvolta solo ornamentale dei singoli echi.
133 III, i, 109 by this: cioè, by this time.
134 III, i, 141 drowned: in questa, come in tante altre metafore o immagini dell’intera scena, può
vedersi come il linguaggio del dolore si è fatto consistentemente iperbolico, fino, talvolta, a
rasentare il grottesco e l’incongruo. È iperbole barocca, nutrita di tensioni metaforiche e di
rapporti immaginari tra micro e macrocosmo, mondo umano e mondo naturale o oggettuale.
135 III, i, 186 Forte ironia tragica: l’«inganno» qui inventato da Tito verrà presto annullato dal vero
inganno del machiavellico Aaron; il quale, nella battuta ai vv. 188-191, un evidente «a parte»,
commenta, dalla sua tipica posizione di superiorità intellettuale e quindi di spietata ironia, la cecità
di Tito.
136 III, i, didascalia dopo v. 191 Nelle edizioni successive a Q1 viene specificato che si tratta della
mano sinistra, come si può ricavare in seguito dal testo stesso (cfr. III, 2,7). Nel teatro
elisabettiano erano stati studiati trucchi per rendere visivamente credibili, e quindi orrifiche,
mutilazioni di mani e perfino decapitazioni.
137 III, i, 199 I bougt mine own: ho comprato ciò che era già mio, cioè i miei figli.
138 III, i, 203 Solito godimento del male da parte di Aaron, che come già detto, anticipa Iago.
139 III, i, 207 ruin: stessa metafora del v. 17 (cfr. nota relativa). Qui il corpo è una rovina, non solo
perché è vecchio, ma perché è stato mutilato.
140 III, i, 209 wouldst thou: qui Tito si rivolge a Lavinia.
141 III, i, 212-213 Solite immagini iperboliche, che investono del tragico umano l’intero cosmo, e che