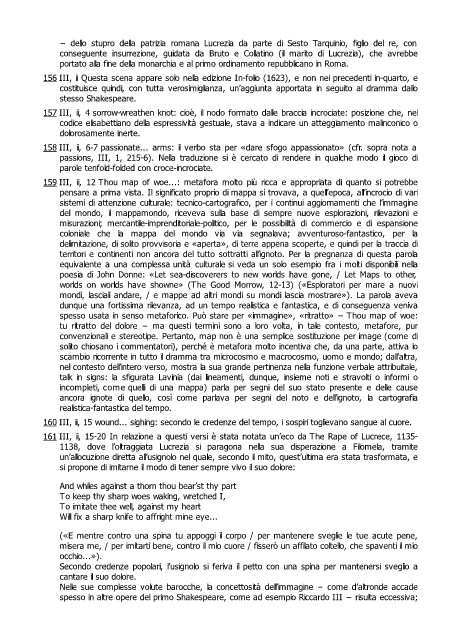Page 2223 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2223
- dello stupro della patrizia romana Lucrezia da parte di Sesto Tarquinio, figlio del re, con
conseguente insurrezione, guidata da Bruto e Collatino (il marito di Lucrezia), che avrebbe
portato alla fine della monarchia e al primo ordinamento repubblicano in Roma.
156 III, ii Questa scena appare solo nella edizione In-folio (1623), e non nei precedenti in-quarto, e
costituisce quindi, con tutta verosimiglianza, un’aggiunta apportata in seguito al dramma dallo
stesso Shakespeare.
157 III, ii, 4 sorrow-wreathen knot: cioè, il nodo formato dalle braccia incrociate: posizione che, nel
codice elisabettiano della espressività gestuale, stava a indicare un atteggiamento malinconico o
dolorosamente inerte.
158 III, ii, 6-7 passionate... arms: il verbo sta per «dare sfogo appassionato» (cfr. sopra nota a
passions, III, 1, 215-6). Nella traduzione si è cercato di rendere in qualche modo il gioco di
parole tenfold-folded con croce-incrociate.
159 III, ii, 12 Thou map of woe...: metafora molto più ricca e appropriata di quanto si potrebbe
pensare a prima vista. Il significato proprio di mappa si trovava, a quell’epoca, all’incrocio di vari
sistemi di attenzione culturale: tecnico-cartografico, per i continui aggiornamenti che l’immagine
del mondo, il mappamondo, riceveva sulla base di sempre nuove esplorazioni, rilevazioni e
misurazioni; mercantile-imprenditoriale-politico, per le possibilità di commercio e di espansione
coloniale che la mappa del mondo via via segnalava; avventuroso-fantastico, per la
delimitazione, di solito provvisoria e «aperta», di terre appena scoperte, e quindi per la traccia di
territori e continenti non ancora del tutto sottratti all’ignoto. Per la pregnanza di questa parola
equivalente a una complessa unità culturale si veda un solo esempio fra i molti disponibili nella
poesia di John Donne: «Let sea-discoverers to new worlds have gone, / Let Maps to other,
worlds on worlds have showne» (The Good Morrow, 12-13) («Esploratori per mare a nuovi
mondi, lasciali andare, / e mappe ad altri mondi su mondi lascia mostrare»). La parola aveva
dunque una fortissima rilevanza, ad un tempo realistica e fantastica, e di conseguenza veniva
spesso usata in senso metaforico. Può stare per «immagine», «ritratto» - Thou map of woe:
tu ritratto del dolore - ma questi termini sono a loro volta, in tale contesto, metafore, pur
convenzionali e stereotipe. Pertanto, map non è una semplice sostituzione per image (come di
solito chiosano i commentatori), perché è metafora molto incentiva che, da una parte, attiva lo
scambio ricorrente in tutto il dramma tra microcosmo e macrocosmo, uomo e mondo; dall’altra,
nel contesto dell’intero verso, mostra la sua grande pertinenza nella funzione verbale attribuitale,
talk in signs: la sfigurata Lavinia (dai lineamenti, dunque, insieme noti e stravolti o informi o
incompleti, come quelli di una mappa) parla per segni del suo stato presente e delle cause
ancora ignote di quello, così come parlava per segni del noto e dell’ignoto, la cartografia
realistica-fantastica del tempo.
160 III, ii, 15 wound... sighing: secondo le credenze del tempo, i sospiri toglievano sangue al cuore.
161 III, ii, 15-20 In relazione a questi versi è stata notata un’eco da The Rape of Lucrece, 1135-
1138, dove l’oltraggiata Lucrezia si paragona nella sua disperazione a Filomela, tramite
un’allocuzione diretta all’usignolo nel quale, secondo il mito, quest’ultima era stata trasformata, e
si propone di imitarne il modo di tener sempre vivo il suo dolore:
And whiles against a thorn thou bear’st thy part
To keep thy sharp woes waking, wretched I,
To imitate thee well, against my heart
Will fix a sharp knife to affright mine eye...
(«E mentre contro una spina tu appoggi il corpo / per mantenere sveglie le tue acute pene,
misera me, / per imitarti bene, contro il mio cuore / fisserò un affilato coltello, che spaventi il mio
occhio...»).
Secondo credenze popolari, l’usignolo si feriva il petto con una spina per mantenersi sveglio a
cantare il suo dolore.
Nelle sue complesse volute barocche, la concettosità dell’immagine - come d’altronde accade
spesso in altre opere del primo Shakespeare, come ad esempio Riccardo III - risulta eccessiva;