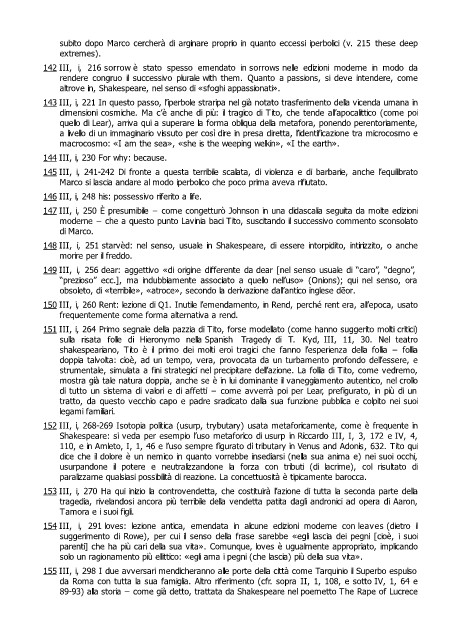Page 2222 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2222
subito dopo Marco cercherà di arginare proprio in quanto eccessi iperbolici (v. 215 these deep
extremes).
142 III, i, 216 sorrow è stato spesso emendato in sorrows nelle edizioni moderne in modo da
rendere congruo il successivo plurale with them. Quanto a passions, si deve intendere, come
altrove in, Shakespeare, nel senso di «sfoghi appassionati».
143 III, i, 221 In questo passo, l’iperbole straripa nel già notato trasferimento della vicenda umana in
dimensioni cosmiche. Ma c’è anche di più: il tragico di Tito, che tende all’apocalittico (come poi
quello di Lear), arriva qui a superare la forma obliqua della metafora, ponendo perentoriamente,
a livello di un immaginario vissuto per così dire in presa diretta, l’identificazione tra microcosmo e
macrocosmo: «I am the sea», «she is the weeping welkin», «I the earth».
144 III, i, 230 For why: because.
145 III, i, 241-242 Di fronte a questa terribile scalata, di violenza e di barbarie, anche l’equilibrato
Marco si lascia andare al modo iperbolico che poco prima aveva rifiutato.
146 III, i, 248 his: possessivo riferito a life.
147 III, i, 250 È presumibile - come congetturò Johnson in una didascalia seguita da molte edizioni
moderne - che a questo punto Lavinia baci Tito, suscitando il successivo commento sconsolato
di Marco.
148 III, i, 251 starvèd: nel senso, usuale in Shakespeare, di essere intorpidito, intirizzito, o anche
morire per il freddo.
149 III, i, 256 dear: aggettivo «di origine differente da dear [nel senso usuale di “caro”, “degno”,
“prezioso” ecc.], ma indubbiamente associato a quello nell’uso» (Onions); qui nel senso, ora
obsoleto, di «terribile», «atroce», secondo la derivazione dall’antico inglese deor.
150 III, i, 260 Rent: lezione di Q1. Inutile l’emendamento, in Rend, perché rent era, all’epoca, usato
frequentemente come forma alternativa a rend.
151 III, i, 264 Primo segnale della pazzia di Tito, forse modellato (come hanno suggerito molti critici)
sulla risata folle di Hieronymo nella Spanish Tragedy di T. Kyd, III, 11, 30. Nel teatro
shakespeariano, Tito è il primo dei molti eroi tragici che fanno l’esperienza della follia - follia
doppia talvolta: cioè, ad un tempo, vera, provocata da un turbamento profondo dell’essere, e
strumentale, simulata a fini strategici nel precipitare dell’azione. La follia di Tito, come vedremo,
mostra già tale natura doppia, anche se è in lui dominante il vaneggiamento autentico, nel crollo
di tutto un sistema di valori e di affetti - come avverrà poi per Lear, prefigurato, in più di un
tratto, da questo vecchio capo e padre sradicato dalla sua funzione pubblica e colpito nei suoi
legami familiari.
152 III, i, 268-269 Isotopia politica (usurp, trybutary) usata metaforicamente, come è frequente in
Shakespeare: si veda per esempio l’uso metaforico di usurp in Riccardo III, I, 3, 172 e IV, 4,
110, e in Amleto, I, 1, 46 e l’uso sempre figurato di tributary in Venus and Adonis, 632. Tito qui
dice che il dolore è un nemico in quanto vorrebbe insediarsi (nella sua anima e) nei suoi occhi,
usurpandone il potere e neutralizzandone la forza con tributi (di lacrime), col risultato di
paralizzarne qualsiasi possibilità di reazione. La concettuosità è tipicamente barocca.
153 III, i, 270 Ha qui inizio la controvendetta, che costituirà l’azione di tutta la seconda parte della
tragedia, rivelandosi ancora più terribile della vendetta patita dagli andronici ad opera di Aaron,
Tamora e i suoi figli.
154 III, i, 291 loves: lezione antica, emendata in alcune edizioni moderne con leaves (dietro il
suggerimento di Rowe), per cui il senso della frase sarebbe «egli lascia dei pegni [cioè, i suoi
parenti] che ha più cari della sua vita». Comunque, loves è ugualmente appropriato, implicando
solo un ragionamento più ellittico: «egli ama i pegni (che lascia) più della sua vita».
155 III, i, 298 I due avversari mendicheranno alle porte della città come Tarquinio il Superbo espulso
da Roma con tutta la sua famiglia. Altro riferimento (cfr. sopra II, 1, 108, e sotto IV, 1, 64 e
89-93) alla storia - come già detto, trattata da Shakespeare nel poemetto The Rape of Lucrece