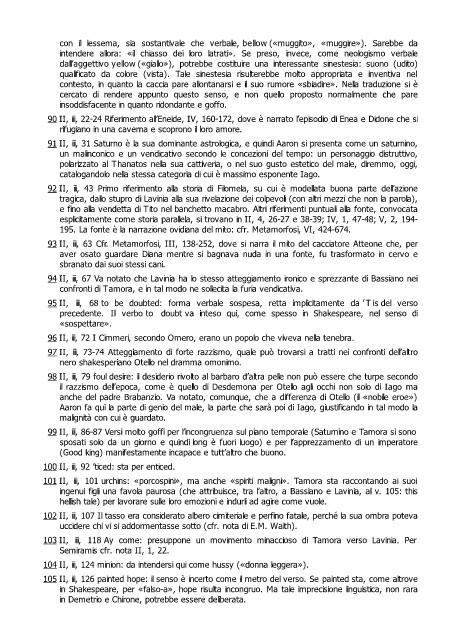Page 2218 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2218
con il lessema, sia sostantivale che verbale, bellow («muggito», «muggire»). Sarebbe da
intendere allora: «il chiasso dei loro latrati». Se preso, invece, come neologismo verbale
dall’aggettivo yellow («giallo»), potrebbe costituire una interessante sinestesia: suono (udito)
qualificato da colore (vista). Tale sinestesia risulterebbe molto appropriata e inventiva nel
contesto, in quanto la caccia pare allontanarsi e il suo rumore «sbiadire». Nella traduzione si è
cercato di rendere appunto questo senso, e non quello proposto normalmente che pare
insoddisfacente in quanto ridondante e goffo.
90 II, iii, 22-24 Riferimento all’Eneide, IV, 160-172, dove è narrato l’episodio di Enea e Didone che si
rifugiano in una caverna e scoprono il loro amore.
91 II, iii, 31 Saturno è la sua dominante astrologica, e quindi Aaron si presenta come un saturnino,
un malinconico e un vendicativo secondo le concezioni del tempo: un personaggio distruttivo,
polarizzato al Thanatos nella sua cattiveria, o nel suo gusto estetico del male, diremmo, oggi,
catalogandolo nella stessa categoria di cui è massimo esponente Iago.
92 II, iii, 43 Primo riferimento alla storia di Filomela, su cui è modellata buona parte dell’azione
tragica, dallo stupro di Lavinia alla sua rivelazione dei colpevoli (con altri mezzi che non la parola),
e fino alla vendetta di Tito nel banchetto macabro. Altri riferimenti puntuali alla fonte, convocata
esplicitamente come storia parallela, si trovano in II, 4, 26-27 e 38-39; IV, 1, 47-48; V, 2, 194-
195. La fonte è la narrazione ovidiana del mito: cfr. Metamorfosi, VI, 424-674.
93 II, iii, 63 Cfr. Metamorfosi, III, 138-252, dove si narra il mito del cacciatore Atteone che, per
aver osato guardare Diana mentre si bagnava nuda in una fonte, fu trasformato in cervo e
sbranato dai suoi stessi cani.
94 II, iii, 67 Va notato che Lavinia ha lo stesso atteggiamento ironico e sprezzante di Bassiano nei
confronti di Tamora, e in tal modo ne sollecita la furia vendicativa.
95 II, iii, 68 to be doubted: forma verbale sospesa, retta implicitamente da ’ T is del verso
precedente. Il verbo to doubt va inteso qui, come spesso in Shakespeare, nel senso di
«sospettare».
96 II, iii, 72 I Cimmeri, secondo Omero, erano un popolo che viveva nella tenebra.
97 II, iii, 73-74 Atteggiamento di forte razzismo, quale può trovarsi a tratti nei confronti dell’altro
nero shakesperiano Otello nel dramma omonimo.
98 II, iii, 79 foul desire: il desiderio rivolto al barbaro d’altra pelle non può essere che turpe secondo
il razzismo dell’epoca, come è quello di Desdemona per Otello agli occhi non solo di Iago ma
anche del padre Brabanzio. Va notato, comunque, che a differenza di Otello (il «nobile eroe»)
Aaron fa qui la parte di genio del male, la parte che sarà poi di Iago, giustificando in tal modo la
malignità con cui è guardato.
99 II, iii, 86-87 Versi molto goffi per l’incongruenza sul piano temporale (Saturnino e Tamora si sono
sposati solo da un giorno e quindi long è fuori luogo) e per l’apprezzamento di un imperatore
(Good king) manifestamente incapace e tutt’altro che buono.
100 II, iii, 92 ’ticed: sta per enticed.
101 II, iii, 101 urchins: «porcospini», ma anche «spiriti maligni». Tamora sta raccontando ai suoi
ingenui figli una favola paurosa (che attribuisce, tra l’altro, a Bassiano e Lavinia, al v. 105: this
hellish tale) per lavorare sulle loro emozioni e indurli ad agire come vuole.
102 II, iii, 107 Il tasso era considerato albero cimiteriale e perfino fatale, perché la sua ombra poteva
uccidere chi vi si addormentasse sotto (cfr. nota di E.M. Waith).
103 II, iii, 118 Ay come: presuppone un movimento minaccioso di Tamora verso Lavinia. Per
Semiramis cfr. nota II, 1, 22.
104 II, iii, 124 minion: da intendersi qui come hussy («donna leggera»).
105 II, iii, 126 painted hope: il senso è incerto come il metro del verso. Se painted sta, come altrove
in Shakespeare, per «falso-a», hope risulta incongruo. Ma tale imprecisione linguistica, non rara
in Demetrio e Chirone, potrebbe essere deliberata.