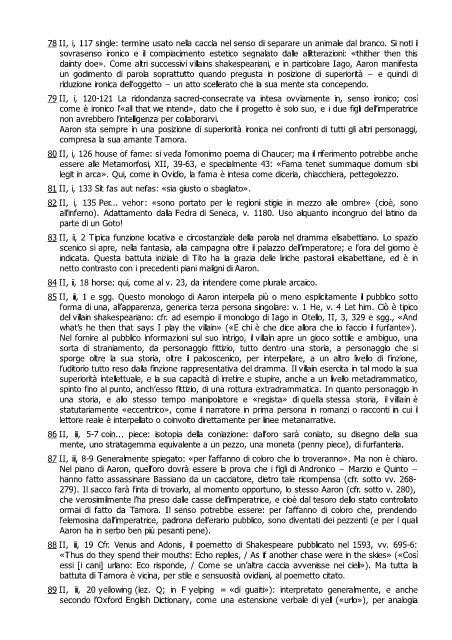Page 2217 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2217
78 II, i, 117 single: termine usato nella caccia nel senso di separare un animale dal branco. Si noti il
sovrasenso ironico e il compiacimento estetico segnalato dalle allitterazioni: «thither then this
dainty doe». Come altri successivi villains shakespeariani, e in particolare Iago, Aaron manifesta
un godimento di parola soprattutto quando pregusta in posizione di superiorità - e quindi di
riduzione ironica dell’oggetto - un atto scellerato che la sua mente sta concependo.
79 II, i, 120-121 La ridondanza sacred-consecrate va intesa ovviamente in, senso ironico; così
come è ironico l’«all that we intend», dato che il progetto è solo suo, e i due figli dell’imperatrice
non avrebbero l’intelligenza per collaborarvi.
Aaron sta sempre in una posizione di superiorità ironica nei confronti di tutti gli altri personaggi,
compresa la sua amante Tamora.
80 II, i, 126 house of fame: si veda l’omonimo poema di Chaucer; ma il riferimento potrebbe anche
essere alle Metamorfosi, XII, 39-63, e specialmente 43: «Fama tenet summaque domum sibi
legit in arca». Qui, come in Ovidio, la fama è intesa come diceria, chiacchiera, pettegolezzo.
81 II, i, 133 Sit fas aut nefas: «sia giusto o sbagliato».
82 II, i, 135 Per... vehor : «sono portato per le regioni stigie in mezzo alle ombre» (cioè, sono
all’inferno). Adattamento dalla Fedra di Seneca, v. 1180. Uso alquanto incongruo del latino da
parte di un Goto!
83 II, ii, 2 Tipica funzione locativa e circostanziale della parola nel dramma elisabettiano. Lo spazio
scenico si apre, nella fantasia, alla campagna oltre il palazzo dell’imperatore; e l’ora del giorno è
indicata. Questa battuta iniziale di Tito ha la grazia delle liriche pastorali elisabettiane, ed è in
netto contrasto con i precedenti piani maligni di Aaron.
84 II, ii, 18 horse: qui, come al v. 23, da intendere come plurale arcaico.
85 II, iii, 1 e sgg. Questo monologo di Aaron interpella più o meno esplicitamente il pubblico sotto
forma di una, all’apparenza, generica terza persona singolare: v. 1 He, v. 4 Let him. Ciò è tipico
del villain shakespeariano: cfr. ad esempio il monologo di Iago in Otello, II, 3, 329 e sgg., «And
what’s he then that says I play the villain» («E chi è che dice allora che io faccio il furfante»).
Nel fornire al pubblico informazioni sul suo intrigo, il villain apre un gioco sottile e ambiguo, una
sorta di straniamento, da personaggio fittizio, tutto dentro una storia, a personaggio che si
sporge oltre la sua storia, oltre il palcoscenico, per interpellare, a un altro livello di finzione,
l’uditorio tutto reso dalla finzione rappresentativa del dramma. Il villain esercita in tal modo la sua
superiorità intellettuale, e la sua capacità di irretire e stupire, anche a un livello metadrammatico,
spinto fino al punto, anch’esso fittizio, di una rottura extradrammatica. In quanto personaggio in
una storia, e allo stesso tempo manipolatore e «regista» di quella stessa storia, il villain è
statutariamente «eccentrico», come il narratore in prima persona in romanzi o racconti in cui il
lettore reale è interpellato o coinvolto direttamente per linee metanarrative.
86 II, iii, 5-7 coin... piece: isotopia della coniazione: dall’oro sarà coniato, su disegno della sua
mente, uno stratagemma equivalente a un pezzo, una moneta (penny piece), di furfanteria.
87 II, iii, 8-9 Generalmente spiegato: «per l’affanno di coloro che lo troveranno». Ma non è chiaro.
Nel piano di Aaron, quell’oro dovrà essere la prova che i figli di Andronico - Marzio e Quinto -
hanno fatto assassinare Bassiano da un cacciatore, dietro tale ricompensa (cfr. sotto vv. 268-
279). Il sacco farà finta di trovarlo, al momento opportuno, lo stesso Aaron (cfr. sotto v. 280),
che verosimilmente l’ha preso dalle casse dell’imperatrice, e cioè dal tesoro dello stato controllato
ormai di fatto da Tamora. Il senso potrebbe essere: per l’affanno di coloro che, prendendo
l’elemosina dall’imperatrice, padrona dell’erario pubblico, sono diventati dei pezzenti (e per i quali
Aaron ha in serbo ben più pesanti pene).
88 II, iii, 19 Cfr. Venus and Adonis, il poemetto di Shakespeare pubblicato nel 1593, vv. 695-6:
«Thus do they spend their mouths: Echo replies, / As if another chase were in the skies» («Così
essi [i cani] urlano: Eco risponde, / Come se un’altra caccia avvenisse nei cieli»). Ma tutta la
battuta di Tamora è vicina, per stile e sensuosità ovidiani, al poemetto citato.
89 II, iii, 20 yellowing (lez. Q; in F yelping = «di guaiti»): interpretato generalmente, e anche
secondo l’Oxford English Dictionary, come una estensione verbale di yell («urlo»), per analogia