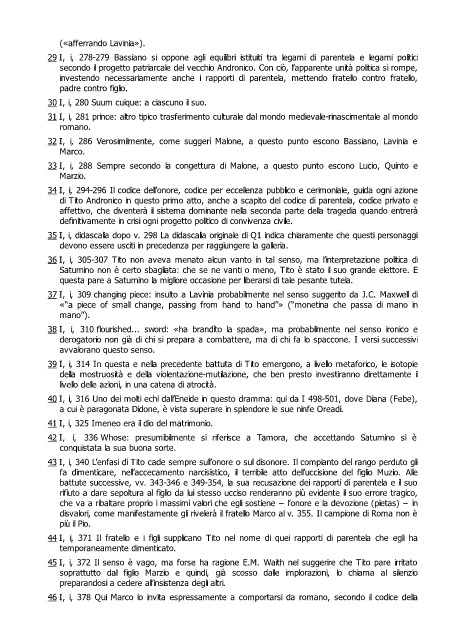Page 2214 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2214
(«afferrando Lavinia»).
29 I, i, 278-279 Bassiano si oppone agli equilibri istituiti tra legami di parentela e legami politici
secondo il progetto patriarcale del vecchio Andronico. Con ciò, l’apparente unità politica si rompe,
investendo necessariamente anche i rapporti di parentela, mettendo fratello contro fratello,
padre contro figlio.
30 I, i, 280 Suum cuique: a ciascuno il suo.
31 I, i, 281 prince: altro tipico trasferimento culturale dal mondo medievale-rinascimentale al mondo
romano.
32 I, i, 286 Verosimilmente, come suggerì Malone, a questo punto escono Bassiano, Lavinia e
Marco.
33 I, i, 288 Sempre secondo la congettura di Malone, a questo punto escono Lucio, Quinto e
Marzio.
34 I, i, 294-296 Il codice dell’onore, codice per eccellenza pubblico e cerimoniale, guida ogni azione
di Tito Andronico in questo primo atto, anche a scapito del codice di parentela, codice privato e
affettivo, che diventerà il sistema dominante nella seconda parte della tragedia quando entrerà
definitivamente in crisi ogni progetto politico di convivenza civile.
35 I, i, didascalia dopo v. 298 La didascalia originale di Q1 indica chiaramente che questi personaggi
devono essere usciti in precedenza per raggiungere la galleria.
36 I, i, 305-307 Tito non aveva menato alcun vanto in tal senso, ma l’interpretazione politica di
Saturnino non è certo sbagliata: che se ne vanti o meno, Tito è stato il suo grande elettore. E
questa pare a Saturnino la migliore occasione per liberarsi di tale pesante tutela.
37 I, i, 309 changing piece: insulto a Lavinia probabilmente nel senso suggerito da J.C. Maxwell di
«“a piece of small change, passing from hand to hand”» (“monetina che passa di mano in
mano”).
38 I, i, 310 flourished... sword: «ha brandìto la spada», ma probabilmente nel senso ironico e
derogatorio non già di chi si prepara a combattere, ma di chi fa lo spaccone. I versi successivi
avvalorano questo senso.
39 I, i, 314 In questa e nella precedente battuta di Tito emergono, a livello metaforico, le isotopie
della mostruosità e della violentazione-mutilazione, che ben presto investiranno direttamente il
livello delle azioni, in una catena di atrocità.
40 I, i, 316 Uno dei molti echi dall’Eneide in questo dramma: qui da I 498-501, dove Diana (Febe),
a cui è paragonata Didone, è vista superare in splendore le sue ninfe Oreadi.
41 I, i, 325 Imeneo era il dio del matrimonio.
42 I, i, 336 Whose: presumibilmente si riferisce a Tamora, che accettando Saturnino si è
conquistata la sua buona sorte.
43 I, i, 340 L’enfasi di Tito cade sempre sull’onore o sul disonore. Il compianto del rango perduto gli
fa dimenticare, nell’accecamento narcisistico, il terribile atto dell’uccisione del figlio Muzio. Alle
battute successive, vv. 343-346 e 349-354, la sua recusazione dei rapporti di parentela e il suo
rifiuto a dare sepoltura al figlio da lui stesso ucciso renderanno più evidente il suo errore tragico,
che va a ribaltare proprio i massimi valori che egli sostiene - l’onore e la devozione (pietas) - in
disvalori, come manifestamente gli rivelerà il fratello Marco al v. 355. Il campione di Roma non è
più il Pio.
44 I, i, 371 Il fratello e i figli supplicano Tito nel nome di quei rapporti di parentela che egli ha
temporaneamente dimenticato.
45 I, i, 372 Il senso è vago, ma forse ha ragione E.M. Waith nel suggerire che Tito pare irritato
soprattutto dal figlio Marzio e quindi, già scosso dalle implorazioni, lo chiama al silenzio
preparandosi a cedere all’insistenza degli altri.
46 I, i, 378 Qui Marco lo invita espressamente a comportarsi da romano, secondo il codice della