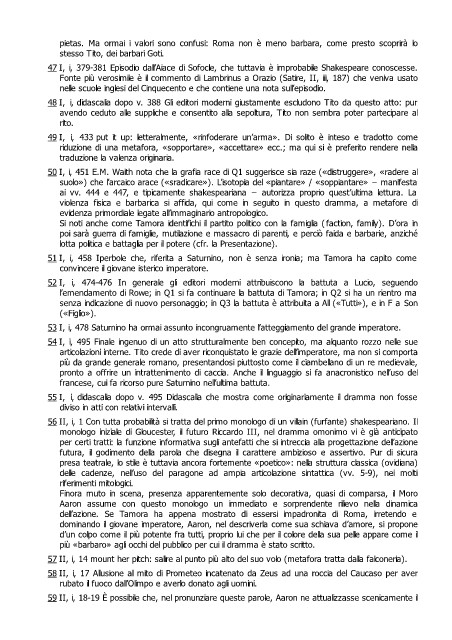Page 2215 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2215
pietas. Ma ormai i valori sono confusi: Roma non è meno barbara, come presto scoprirà lo
stesso Tito, dei barbari Goti.
47 I, i, 379-381 Episodio dall’Aiace di Sofocle, che tuttavia è improbabile Shakespeare conoscesse.
Fonte più verosimile è il commento di Lambrinus a Orazio (Satire, II, iii, 187) che veniva usato
nelle scuole inglesi del Cinquecento e che contiene una nota sull’episodio.
48 I, i, didascalia dopo v. 388 Gli editori moderni giustamente escludono Tito da questo atto: pur
avendo ceduto alle suppliche e consentito alla sepoltura, Tito non sembra poter partecipare al
rito.
49 I, i, 433 put it up: letteralmente, «rinfoderare un’arma». Di solito è inteso e tradotto come
riduzione di una metafora, «sopportare», «accettare» ecc.; ma qui si è preferito rendere nella
traduzione la valenza originaria.
50 I, i, 451 E.M. Waith nota che la grafia race di Q1 suggerisce sia raze («distruggere», «radere al
suolo») che l’arcaico arace («sradicare»). L’isotopia del «piantare» / «soppiantare» - manifesta
ai vv. 444 e 447, e tipicamente shakespeariana - autorizza proprio quest’ultima lettura. La
violenza fisica e barbarica si affida, qui come in seguito in questo dramma, a metafore di
evidenza primordiale legate all’immaginario antropologico.
Si noti anche come Tamora identifichi il partito politico con la famiglia ( faction, family). D’ora in
poi sarà guerra di famiglie, mutilazione e massacro di parenti, e perciò faida e barbarie, anziché
lotta politica e battaglia per il potere (cfr. la Presentazione).
51 I, i, 458 Iperbole che, riferita a Saturnino, non è senza ironia; ma Tamora ha capito come
convincere il giovane isterico imperatore.
52 I, i, 474-476 In generale gli editori moderni attribuiscono la battuta a Lucio, seguendo
l’emendamento di Rowe; in Q1 si fa continuare la battuta di Tamora; in Q2 si ha un rientro ma
senza indicazione di nuovo personaggio; in Q3 la battuta è attribuita a All («Tutti»), e in F a Son
(«Figlio»).
53 I, i, 478 Saturnino ha ormai assunto incongruamente l’atteggiamento del grande imperatore.
54 I, i, 495 Finale ingenuo di un atto strutturalmente ben concepito, ma alquanto rozzo nelle sue
articolazioni interne. Tito crede di aver riconquistato le grazie dell’imperatore, ma non si comporta
più da grande generale romano, presentandosi piuttosto come il ciambellano di un re medievale,
pronto a offrire un intrattenimento di caccia. Anche il linguaggio si fa anacronistico nell’uso del
francese, cui fa ricorso pure Saturnino nell’ultima battuta.
55 I, i, didascalia dopo v. 495 Didascalia che mostra come originariamente il dramma non fosse
diviso in atti con relativi intervalli.
56 II, i, 1 Con tutta probabilità si tratta del primo monologo di un villain (furfante) shakespeariano. Il
monologo iniziale di Gloucester, il futuro Riccardo III, nel dramma omonimo vi è già anticipato
per certi tratti: la funzione informativa sugli antefatti che si intreccia alla progettazione dell’azione
futura, il godimento della parola che disegna il carattere ambizioso e assertivo. Pur di sicura
presa teatrale, lo stile è tuttavia ancora fortemente «poetico»: nella struttura classica (ovidiana)
delle cadenze, nell’uso del paragone ad ampia articolazione sintattica (vv. 5-9), nei molti
riferimenti mitologici.
Finora muto in scena, presenza apparentemente solo decorativa, quasi di comparsa, il Moro
Aaron assume con questo monologo un immediato e sorprendente rilievo nella dinamica
dell’azione. Se Tamora ha appena mostrato di essersi impadronita di Roma, irretendo e
dominando il giovane imperatore, Aaron, nel descriverla come sua schiava d’amore, si propone
d’un colpo come il più potente fra tutti, proprio lui che per il colore della sua pelle appare come il
più «barbaro» agli occhi del pubblico per cui il dramma è stato scritto.
57 II, i, 14 mount her pitch: salire al punto più alto del suo volo (metafora tratta dalla falconeria).
58 II, i, 17 Allusione al mito di Prometeo incatenato da Zeus ad una roccia del Caucaso per aver
rubato il fuoco dall’Olimpo e averlo donato agli uomini.
59 II, i, 18-19 È possibile che, nel pronunziare queste parole, Aaron ne attualizzasse scenicamente il