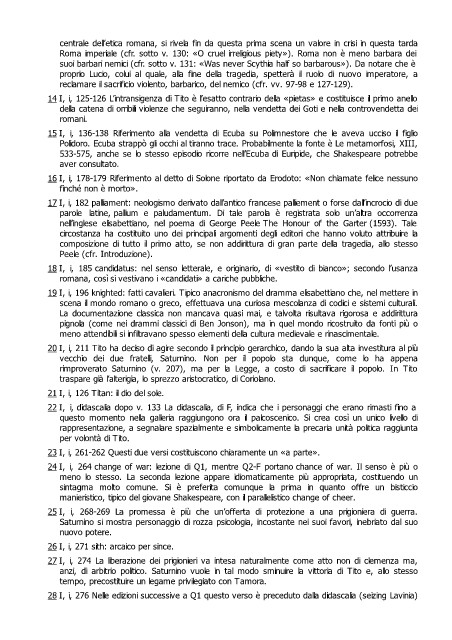Page 2213 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2213
centrale dell’etica romana, si rivela fin da questa prima scena un valore in crisi in questa tarda
Roma imperiale (cfr. sotto v. 130: «O cruel irreligious piety»). Roma non è meno barbara dei
suoi barbari nemici (cfr. sotto v. 131: «Was never Scythia half so barbarous»). Da notare che è
proprio Lucio, colui al quale, alla fine della tragedia, spetterà il ruolo di nuovo imperatore, a
reclamare il sacrificio violento, barbarico, del nemico (cfr. vv. 97-98 e 127-129).
14 I, i, 125-126 L’intransigenza di Tito è l’esatto contrario della «pietas» e costituisce il primo anello
della catena di orribili violenze che seguiranno, nella vendetta dei Goti e nella controvendetta dei
romani.
15 I, i, 136-138 Riferimento alla vendetta di Ecuba su Polimnestore che le aveva ucciso il figlio
Polidoro. Ecuba strappò gli occhi al tiranno trace. Probabilmente la fonte è Le metamorfosi, XIII,
533-575, anche se lo stesso episodio ricorre nell’Ecuba di Euripide, che Shakespeare potrebbe
aver consultato.
16 I, i, 178-179 Riferimento al detto di Solone riportato da Erodoto: «Non chiamate felice nessuno
finché non è morto».
17 I, i, 182 palliament: neologismo derivato dall’antico francese palliement o forse dall’incrocio di due
parole latine, pallium e paludamentum. Di tale parola è registrata solo un’altra occorrenza
nell’inglese elisabettiano, nel poema di George Peele The Honour of the Garter (1593). Tale
circostanza ha costituito uno dei principali argomenti degli editori che hanno voluto attribuire la
composizione di tutto il primo atto, se non addirittura di gran parte della tragedia, allo stesso
Peele (cfr. Introduzione).
18 I, i, 185 candidatus: nel senso letterale, e originario, di «vestito di bianco»; secondo l’usanza
romana, così si vestivano i «candidati» a cariche pubbliche.
19 I, i, 196 knighted: fatti cavalieri. Tipico anacronismo del dramma elisabettiano che, nel mettere in
scena il mondo romano o greco, effettuava una curiosa mescolanza di codici e sistemi culturali.
La documentazione classica non mancava quasi mai, e talvolta risultava rigorosa e addirittura
pignola (come nei drammi classici di Ben Jonson), ma in quel mondo ricostruito da fonti più o
meno attendibili si infiltravano spesso elementi della cultura medievale e rinascimentale.
20 I, i, 211 Tito ha deciso di agire secondo il principio gerarchico, dando la sua alta investitura al più
vecchio dei due fratelli, Saturnino. Non per il popolo sta dunque, come lo ha appena
rimproverato Saturnino (v. 207), ma per la Legge, a costo di sacrificare il popolo. In Tito
traspare già l’alterigia, lo sprezzo aristocratico, di Coriolano.
21 I, i, 126 Titan: il dio del sole.
22 I, i, didascalia dopo v. 133 La didascalia, di F, indica che i personaggi che erano rimasti fino a
questo momento nella galleria raggiungono ora il palcoscenico. Si crea così un unico livello di
rappresentazione, a segnalare spazialmente e simbolicamente la precaria unità politica raggiunta
per volontà di Tito.
23 I, i, 261-262 Questi due versi costituiscono chiaramente un «a parte».
24 I, i, 264 change of war: lezione di Q1, mentre Q2-F portano chance of war. Il senso è più o
meno lo stesso. La seconda lezione appare idiomaticamente più appropriata, costituendo un
sintagma molto comune. Si è preferita comunque la prima in quanto offre un bisticcio
manieristico, tipico del giovane Shakespeare, con il parallelistico change of cheer.
25 I, i, 268-269 La promessa è più che un’offerta di protezione a una prigioniera di guerra.
Saturnino si mostra personaggio di rozza psicologia, incostante nei suoi favori, inebriato dal suo
nuovo potere.
26 I, i, 271 sith: arcaico per since.
27 I, i, 274 La liberazione dei prigionieri va intesa naturalmente come atto non di clemenza ma,
anzi, di arbitrio politico. Saturnino vuole in tal modo sminuire la vittoria di Tito e, allo stesso
tempo, precostituire un legame privilegiato con Tamora.
28 I, i, 276 Nelle edizioni successive a Q1 questo verso è preceduto dalla didascalia (seizing Lavinia)