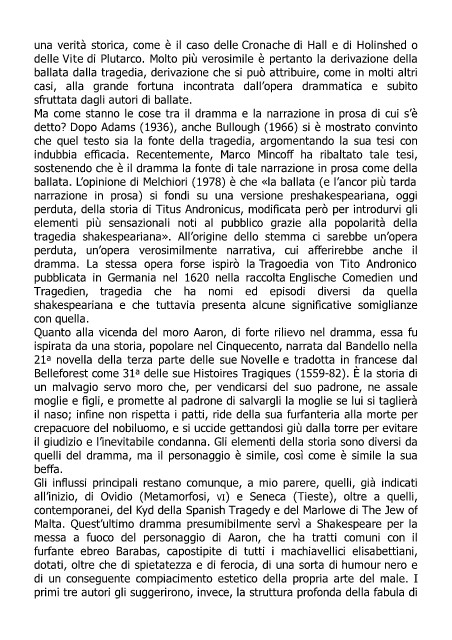Page 1999 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1999
una verità storica, come è il caso delle Cronache di Hall e di Holinshed o
delle Vite di Plutarco. Molto più verosimile è pertanto la derivazione della
ballata dalla tragedia, derivazione che si può attribuire, come in molti altri
casi, alla grande fortuna incontrata dall’opera drammatica e subito
sfruttata dagli autori di ballate.
Ma come stanno le cose tra il dramma e la narrazione in prosa di cui s’è
detto? Dopo Adams (1936), anche Bullough (1966) si è mostrato convinto
che quel testo sia la fonte della tragedia, argomentando la sua tesi con
indubbia efficacia. Recentemente, Marco Mincoff ha ribaltato tale tesi,
sostenendo che è il dramma la fonte di tale narrazione in prosa come della
ballata. L’opinione di Melchiori (1978) è che «la ballata (e l’ancor più tarda
narrazione in prosa) si fondi su una versione preshakespeariana, oggi
perduta, della storia di Titus Andronicus, modificata però per introdurvi gli
elementi più sensazionali noti al pubblico grazie alla popolarità della
tragedia shakespeariana». All’origine dello stemma ci sarebbe un’opera
perduta, un’opera verosimilmente narrativa, cui afferirebbe anche il
dramma. La stessa opera forse ispirò la Tragoedia von Tito Andronico
pubblicata in Germania nel 1620 nella raccolta Englische Comedien und
Tragedien, tragedia che ha nomi ed episodi diversi da quella
shakespeariana e che tuttavia presenta alcune significative somiglianze
con quella.
Quanto alla vicenda del moro Aaron, di forte rilievo nel dramma, essa fu
ispirata da una storia, popolare nel Cinquecento, narrata dal Bandello nella
21a novella della terza parte delle sue Novelle e tradotta in francese dal
Belleforest come 31a delle sue Histoires Tragiques (1559-82). È la storia di
un malvagio servo moro che, per vendicarsi del suo padrone, ne assale
moglie e figli, e promette al padrone di salvargli la moglie se lui si taglierà
il naso; infine non rispetta i patti, ride della sua furfanteria alla morte per
crepacuore del nobiluomo, e si uccide gettandosi giù dalla torre per evitare
il giudizio e l’inevitabile condanna. Gli elementi della storia sono diversi da
quelli del dramma, ma il personaggio è simile, così come è simile la sua
beffa.
Gli influssi principali restano comunque, a mio parere, quelli, già indicati
all’inizio, di Ovidio (Metamorfosi, VI) e Seneca (Tieste), oltre a quelli,
contemporanei, del Kyd della Spanish Tragedy e del Marlowe di The Jew of
Malta. Quest’ultimo dramma presumibilmente servì a Shakespeare per la
messa a fuoco del personaggio di Aaron, che ha tratti comuni con il
furfante ebreo Barabas, capostipite di tutti i machiavellici elisabettiani,
dotati, oltre che di spietatezza e di ferocia, di una sorta di humour nero e
di un conseguente compiacimento estetico della propria arte del male. I
primi tre autori gli suggerirono, invece, la struttura profonda della fabula di