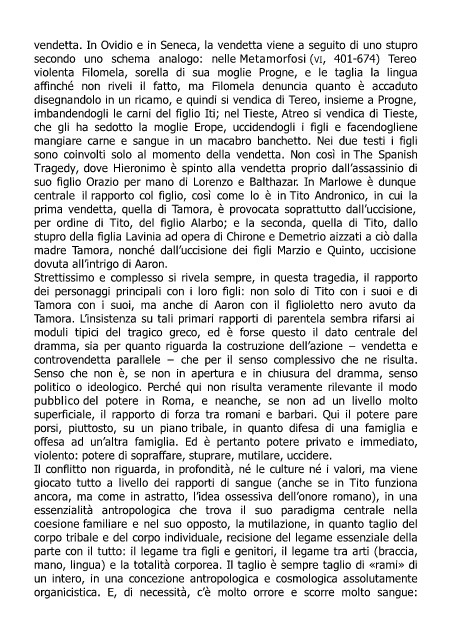Page 2000 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2000
vendetta. In Ovidio e in Seneca, la vendetta viene a seguito di uno stupro
secondo uno schema analogo: nelle Metamorfosi (VI, 401-674) Tereo
violenta Filomela, sorella di sua moglie Progne, e le taglia la lingua
affinché non riveli il fatto, ma Filomela denuncia quanto è accaduto
disegnandolo in un ricamo, e quindi si vendica di Tereo, insieme a Progne,
imbandendogli le carni del figlio Iti; nel Tieste, Atreo si vendica di Tieste,
che gli ha sedotto la moglie Erope, uccidendogli i figli e facendogliene
mangiare carne e sangue in un macabro banchetto. Nei due testi i figli
sono coinvolti solo al momento della vendetta. Non così in The Spanish
Tragedy, dove Hieronimo è spinto alla vendetta proprio dall’assassinio di
suo figlio Orazio per mano di Lorenzo e Balthazar. In Marlowe è dunque
centrale il rapporto col figlio, così come lo è in Tito Andronico, in cui la
prima vendetta, quella di Tamora, è provocata soprattutto dall’uccisione,
per ordine di Tito, del figlio Alarbo; e la seconda, quella di Tito, dallo
stupro della figlia Lavinia ad opera di Chirone e Demetrio aizzati a ciò dalla
madre Tamora, nonché dall’uccisione dei figli Marzio e Quinto, uccisione
dovuta all’intrigo di Aaron.
Strettissimo e complesso si rivela sempre, in questa tragedia, il rapporto
dei personaggi principali con i loro figli: non solo di Tito con i suoi e di
Tamora con i suoi, ma anche di Aaron con il figlioletto nero avuto da
Tamora. L’insistenza su tali primari rapporti di parentela sembra rifarsi ai
moduli tipici del tragico greco, ed è forse questo il dato centrale del
dramma, sia per quanto riguarda la costruzione dell’azione - vendetta e
controvendetta parallele - che per il senso complessivo che ne risulta.
Senso che non è, se non in apertura e in chiusura del dramma, senso
politico o ideologico. Perché qui non risulta veramente rilevante il modo
pubblico del potere in Roma, e neanche, se non ad un livello molto
superficiale, il rapporto di forza tra romani e barbari. Qui il potere pare
porsi, piuttosto, su un piano tribale, in quanto difesa di una famiglia e
offesa ad un’altra famiglia. Ed è pertanto potere privato e immediato,
violento: potere di sopraffare, stuprare, mutilare, uccidere.
Il conflitto non riguarda, in profondità, né le culture né i valori, ma viene
giocato tutto a livello dei rapporti di sangue (anche se in Tito funziona
ancora, ma come in astratto, l’idea ossessiva dell’onore romano), in una
essenzialità antropologica che trova il suo paradigma centrale nella
coesione familiare e nel suo opposto, la mutilazione, in quanto taglio del
corpo tribale e del corpo individuale, recisione del legame essenziale della
parte con il tutto: il legame tra figli e genitori, il legame tra arti (braccia,
mano, lingua) e la totalità corporea. Il taglio è sempre taglio di «rami» di
un intero, in una concezione antropologica e cosmologica assolutamente
organicistica. E, di necessità, c’è molto orrore e scorre molto sangue: