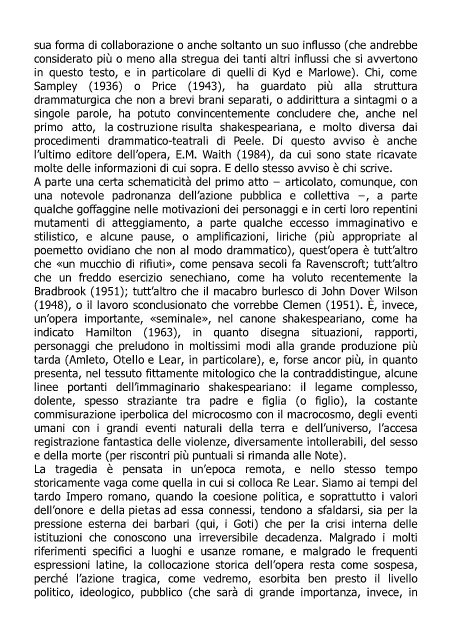Page 1997 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1997
sua forma di collaborazione o anche soltanto un suo influsso (che andrebbe
considerato più o meno alla stregua dei tanti altri influssi che si avvertono
in questo testo, e in particolare di quelli di Kyd e Marlowe). Chi, come
Sampley (1936) o Price (1943), ha guardato più alla struttura
drammaturgica che non a brevi brani separati, o addirittura a sintagmi o a
singole parole, ha potuto convincentemente concludere che, anche nel
primo atto, la costruzione risulta shakespeariana, e molto diversa dai
procedimenti drammatico-teatrali di Peele. Di questo avviso è anche
l’ultimo editore dell’opera, E.M. Waith (1984), da cui sono state ricavate
molte delle informazioni di cui sopra. E dello stesso avviso è chi scrive.
A parte una certa schematicità del primo atto - articolato, comunque, con
una notevole padronanza dell’azione pubblica e collettiva -, a parte
qualche goffaggine nelle motivazioni dei personaggi e in certi loro repentini
mutamenti di atteggiamento, a parte qualche eccesso immaginativo e
stilistico, e alcune pause, o amplificazioni, liriche (più appropriate al
poemetto ovidiano che non al modo drammatico), quest’opera è tutt’altro
che «un mucchio di rifiuti», come pensava secoli fa Ravenscroft; tutt’altro
che un freddo esercizio senechiano, come ha voluto recentemente la
Bradbrook (1951); tutt’altro che il macabro burlesco di John Dover Wilson
(1948), o il lavoro sconclusionato che vorrebbe Clemen (1951). È, invece,
un’opera importante, «seminale», nel canone shakespeariano, come ha
indicato Hamilton (1963), in quanto disegna situazioni, rapporti,
personaggi che preludono in moltissimi modi alla grande produzione più
tarda (Amleto, Otello e Lear, in particolare), e, forse ancor più, in quanto
presenta, nel tessuto fittamente mitologico che la contraddistingue, alcune
linee portanti dell’immaginario shakespeariano: il legame complesso,
dolente, spesso straziante tra padre e figlia (o figlio), la costante
commisurazione iperbolica del microcosmo con il macrocosmo, degli eventi
umani con i grandi eventi naturali della terra e dell’universo, l’accesa
registrazione fantastica delle violenze, diversamente intollerabili, del sesso
e della morte (per riscontri più puntuali si rimanda alle Note).
La tragedia è pensata in un’epoca remota, e nello stesso tempo
storicamente vaga come quella in cui si colloca Re Lear. Siamo ai tempi del
tardo Impero romano, quando la coesione politica, e soprattutto i valori
dell’onore e della pietas ad essa connessi, tendono a sfaldarsi, sia per la
pressione esterna dei barbari (qui, i Goti) che per la crisi interna delle
istituzioni che conoscono una irreversibile decadenza. Malgrado i molti
riferimenti specifici a luoghi e usanze romane, e malgrado le frequenti
espressioni latine, la collocazione storica dell’opera resta come sospesa,
perché l’azione tragica, come vedremo, esorbita ben presto il livello
politico, ideologico, pubblico (che sarà di grande importanza, invece, in