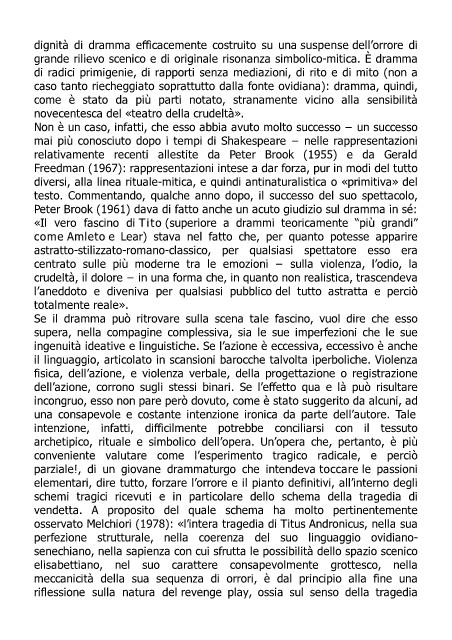Page 2002 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2002
dignità di dramma efficacemente costruito su una suspense dell’orrore di
grande rilievo scenico e di originale risonanza simbolico-mitica. È dramma
di radici primigenie, di rapporti senza mediazioni, di rito e di mito (non a
caso tanto riecheggiato soprattutto dalla fonte ovidiana): dramma, quindi,
come è stato da più parti notato, stranamente vicino alla sensibilità
novecentesca del «teatro della crudeltà».
Non è un caso, infatti, che esso abbia avuto molto successo - un successo
mai più conosciuto dopo i tempi di Shakespeare - nelle rappresentazioni
relativamente recenti allestite da Peter Brook (1955) e da Gerald
Freedman (1967): rappresentazioni intese a dar forza, pur in modi del tutto
diversi, alla linea rituale-mitica, e quindi antinaturalistica o «primitiva» del
testo. Commentando, qualche anno dopo, il successo del suo spettacolo,
Peter Brook (1961) dava di fatto anche un acuto giudizio sul dramma in sé:
«Il vero fascino di Ti to (superiore a drammi teoricamente “più grandi”
come Amleto e Lear) stava nel fatto che, per quanto potesse apparire
astratto-stilizzato-romano-classico, per qualsiasi spettatore esso era
centrato sulle più moderne tra le emozioni - sulla violenza, l’odio, la
crudeltà, il dolore - in una forma che, in quanto non realistica, trascendeva
l’aneddoto e diveniva per qualsiasi pubblico del tutto astratta e perciò
totalmente reale».
Se il dramma può ritrovare sulla scena tale fascino, vuol dire che esso
supera, nella compagine complessiva, sia le sue imperfezioni che le sue
ingenuità ideative e linguistiche. Se l’azione è eccessiva, eccessivo è anche
il linguaggio, articolato in scansioni barocche talvolta iperboliche. Violenza
fisica, dell’azione, e violenza verbale, della progettazione o registrazione
dell’azione, corrono sugli stessi binari. Se l’effetto qua e là può risultare
incongruo, esso non pare però dovuto, come è stato suggerito da alcuni, ad
una consapevole e costante intenzione ironica da parte dell’autore. Tale
intenzione, infatti, difficilmente potrebbe conciliarsi con il tessuto
archetipico, rituale e simbolico dell’opera. Un’opera che, pertanto, è più
conveniente valutare come l’esperimento tragico radicale, e perciò
parziale!, di un giovane drammaturgo che intendeva toccare le passioni
elementari, dire tutto, forzare l’orrore e il pianto definitivi, all’interno degli
schemi tragici ricevuti e in particolare dello schema della tragedia di
vendetta. A proposito del quale schema ha molto pertinentemente
osservato Melchiori (1978): «l’intera tragedia di Titus Andronicus, nella sua
perfezione strutturale, nella coerenza del suo linguaggio ovidiano-
senechiano, nella sapienza con cui sfrutta le possibilità dello spazio scenico
elisabettiano, nel suo carattere consapevolmente grottesco, nella
meccanicità della sua sequenza di orrori, è dal principio alla fine una
riflessione sulla natura del revenge play, ossia sul senso della tragedia