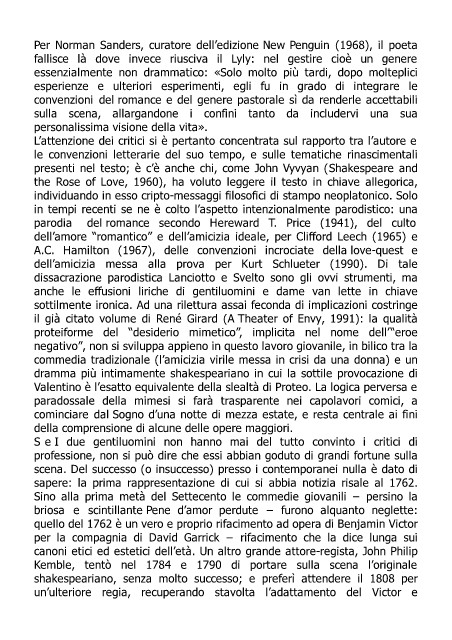Page 1761 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1761
Per Norman Sanders, curatore dell’edizione New Penguin (1968), il poeta
fallisce là dove invece riusciva il Lyly: nel gestire cioè un genere
essenzialmente non drammatico: «Solo molto più tardi, dopo molteplici
esperienze e ulteriori esperimenti, egli fu in grado di integrare le
convenzioni del romance e del genere pastorale sì da renderle accettabili
sulla scena, allargandone i confini tanto da includervi una sua
personalissima visione della vita».
L’attenzione dei critici si è pertanto concentrata sul rapporto tra l’autore e
le convenzioni letterarie del suo tempo, e sulle tematiche rinascimentali
presenti nel testo; è c’è anche chi, come John Vyvyan (Shakespeare and
the Rose of Love, 1960), ha voluto leggere il testo in chiave allegorica,
individuando in esso cripto-messaggi filosofici di stampo neoplatonico. Solo
in tempi recenti se ne è colto l’aspetto intenzionalmente parodistico: una
parodia del romance secondo Hereward T. Price (1941), del culto
dell’amore “romantico” e dell’amicizia ideale, per Clifford Leech (1965) e
A.C. Hamilton (1967), delle convenzioni incrociate della love-quest e
dell’amicizia messa alla prova per Kurt Schlueter (1990). Di tale
dissacrazione parodistica Lanciotto e Svelto sono gli ovvi strumenti, ma
anche le effusioni liriche di gentiluomini e dame van lette in chiave
sottilmente ironica. Ad una rilettura assai feconda di implicazioni costringe
il già citato volume di René Girard (A Theater of Envy, 1991): la qualità
proteiforme del “desiderio mimetico”, implicita nel nome dell’“eroe
negativo”, non si sviluppa appieno in questo lavoro giovanile, in bilico tra la
commedia tradizionale (l’amicizia virile messa in crisi da una donna) e un
dramma più intimamente shakespeariano in cui la sottile provocazione di
Valentino è l’esatto equivalente della slealtà di Proteo. La logica perversa e
paradossale della mimesi si farà trasparente nei capolavori comici, a
cominciare dal Sogno d’una notte di mezza estate, e resta centrale ai fini
della comprensione di alcune delle opere maggiori.
S e I due gentiluomini non hanno mai del tutto convinto i critici di
professione, non si può dire che essi abbian goduto di grandi fortune sulla
scena. Del successo (o insuccesso) presso i contemporanei nulla è dato di
sapere: la prima rappresentazione di cui si abbia notizia risale al 1762.
Sino alla prima metà del Settecento le commedie giovanili - persino la
briosa e scintillante Pene d’amor perdute - furono alquanto neglette:
quello del 1762 è un vero e proprio rifacimento ad opera di Benjamin Victor
per la compagnia di David Garrick - rifacimento che la dice lunga sui
canoni etici ed estetici dell’età. Un altro grande attore-regista, John Philip
Kemble, tentò nel 1784 e 1790 di portare sulla scena l’originale
shakespeariano, senza molto successo; e preferì attendere il 1808 per
un’ulteriore regia, recuperando stavolta l’adattamento del Victor e