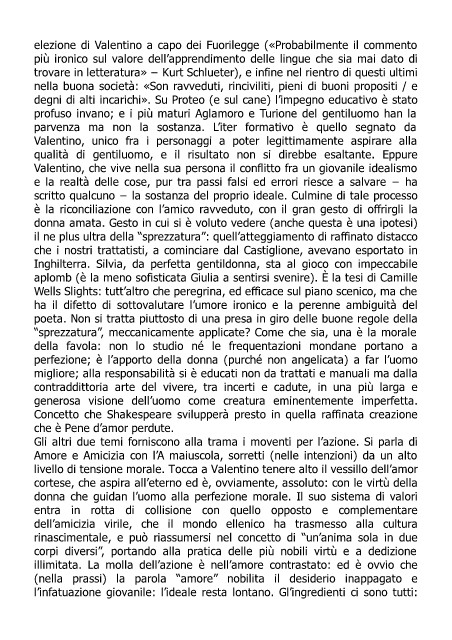Page 1757 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1757
elezione di Valentino a capo dei Fuorilegge («Probabilmente il commento
più ironico sul valore dell’apprendimento delle lingue che sia mai dato di
trovare in letteratura» - Kurt Schlueter), e infine nel rientro di questi ultimi
nella buona società: «Son ravveduti, rinciviliti, pieni di buoni propositi / e
degni di alti incarichi». Su Proteo (e sul cane) l’impegno educativo è stato
profuso invano; e i più maturi Aglamoro e Turione del gentiluomo han la
parvenza ma non la sostanza. L’iter formativo è quello segnato da
Valentino, unico fra i personaggi a poter legittimamente aspirare alla
qualità di gentiluomo, e il risultato non si direbbe esaltante. Eppure
Valentino, che vive nella sua persona il conflitto fra un giovanile idealismo
e la realtà delle cose, pur tra passi falsi ed errori riesce a salvare - ha
scritto qualcuno - la sostanza del proprio ideale. Culmine di tale processo
è la riconciliazione con l’amico ravveduto, con il gran gesto di offrirgli la
donna amata. Gesto in cui si è voluto vedere (anche questa è una ipotesi)
il ne plus ultra della “sprezzatura”: quell’atteggiamento di raffinato distacco
che i nostri trattatisti, a cominciare dal Castiglione, avevano esportato in
Inghilterra. Silvia, da perfetta gentildonna, sta al gioco con impeccabile
aplomb (è la meno sofisticata Giulia a sentirsi svenire). È la tesi di Camille
Wells Slights: tutt’altro che peregrina, ed efficace sul piano scenico, ma che
ha il difetto di sottovalutare l’umore ironico e la perenne ambiguità del
poeta. Non si tratta piuttosto di una presa in giro delle buone regole della
“sprezzatura”, meccanicamente applicate? Come che sia, una è la morale
della favola: non lo studio né le frequentazioni mondane portano a
perfezione; è l’apporto della donna (purché non angelicata) a far l’uomo
migliore; alla responsabilità si è educati non da trattati e manuali ma dalla
contraddittoria arte del vivere, tra incerti e cadute, in una più larga e
generosa visione dell’uomo come creatura eminentemente imperfetta.
Concetto che Shakespeare svilupperà presto in quella raffinata creazione
che è Pene d’amor perdute.
Gli altri due temi forniscono alla trama i moventi per l’azione. Si parla di
Amore e Amicizia con l’A maiuscola, sorretti (nelle intenzioni) da un alto
livello di tensione morale. Tocca a Valentino tenere alto il vessillo dell’amor
cortese, che aspira all’eterno ed è, ovviamente, assoluto: con le virtù della
donna che guidan l’uomo alla perfezione morale. Il suo sistema di valori
entra in rotta di collisione con quello opposto e complementare
dell’amicizia virile, che il mondo ellenico ha trasmesso alla cultura
rinascimentale, e può riassumersi nel concetto di “un’anima sola in due
corpi diversi”, portando alla pratica delle più nobili virtù e a dedizione
illimitata. La molla dell’azione è nell’amore contrastato: ed è ovvio che
(nella prassi) la parola “amore” nobilita il desiderio inappagato e
l’infatuazione giovanile: l’ideale resta lontano. Gl’ingredienti ci sono tutti: