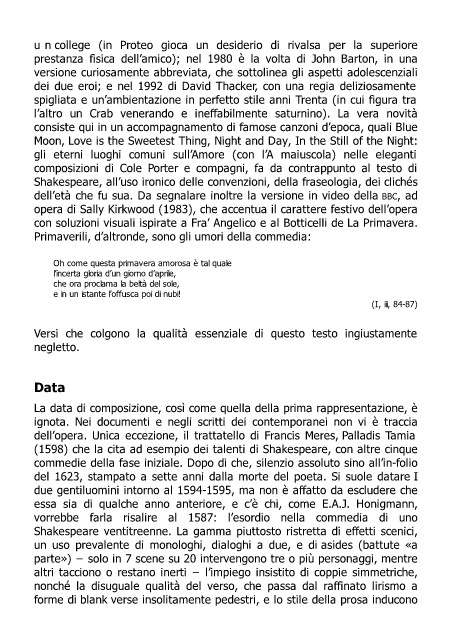Page 1763 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1763
u n college (in Proteo gioca un desiderio di rivalsa per la superiore
prestanza fisica dell’amico); nel 1980 è la volta di John Barton, in una
versione curiosamente abbreviata, che sottolinea gli aspetti adolescenziali
dei due eroi; e nel 1992 di David Thacker, con una regia deliziosamente
spigliata e un’ambientazione in perfetto stile anni Trenta (in cui figura tra
l’altro un Crab venerando e ineffabilmente saturnino). La vera novità
consiste qui in un accompagnamento di famose canzoni d’epoca, quali Blue
Moon, Love is the Sweetest Thing, Night and Day, In the Still of the Night:
gli eterni luoghi comuni sull’Amore (con l’A maiuscola) nelle eleganti
composizioni di Cole Porter e compagni, fa da contrappunto al testo di
Shakespeare, all’uso ironico delle convenzioni, della fraseologia, dei clichés
dell’età che fu sua. Da segnalare inoltre la versione in video della BBC, ad
opera di Sally Kirkwood (1983), che accentua il carattere festivo dell’opera
con soluzioni visuali ispirate a Fra’ Angelico e al Botticelli de La Primavera.
Primaverili, d’altronde, sono gli umori della commedia:
Oh come questa primavera amorosa è tal quale
l’incerta gloria d’un giorno d’aprile,
che ora proclama la beltà del sole,
e in un istante l’offusca poi di nubi!
(I, iii, 84-87)
Versi che colgono la qualità essenziale di questo testo ingiustamente
negletto.
Data
La data di composizione, così come quella della prima rappresentazione, è
ignota. Nei documenti e negli scritti dei contemporanei non vi è traccia
dell’opera. Unica eccezione, il trattatello di Francis Meres, Palladis Tamia
(1598) che la cita ad esempio dei talenti di Shakespeare, con altre cinque
commedie della fase iniziale. Dopo di che, silenzio assoluto sino all’in-folio
del 1623, stampato a sette anni dalla morte del poeta. Si suole datare I
due gentiluomini intorno al 1594-1595, ma non è affatto da escludere che
essa sia di qualche anno anteriore, e c’è chi, come E.A.J. Honigmann,
vorrebbe farla risalire al 1587: l’esordio nella commedia di uno
Shakespeare ventitreenne. La gamma piuttosto ristretta di effetti scenici,
un uso prevalente di monologhi, dialoghi a due, e di asides (battute «a
parte») - solo in 7 scene su 20 intervengono tre o più personaggi, mentre
altri tacciono o restano inerti - l’impiego insistito di coppie simmetriche,
nonché la disuguale qualità del verso, che passa dal raffinato lirismo a
forme di blank verse insolitamente pedestri, e lo stile della prosa inducono