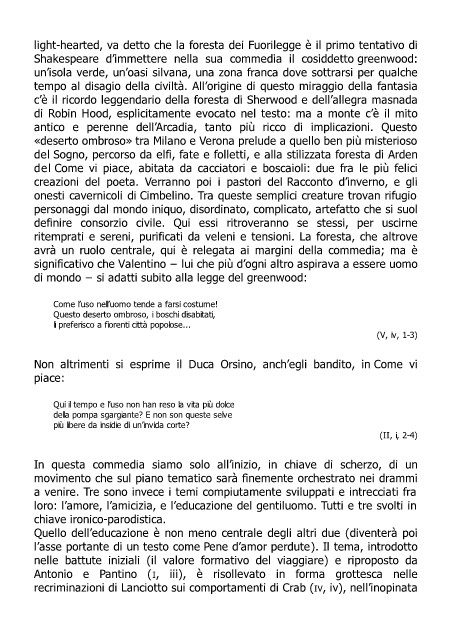Page 1756 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1756
light-hearted, va detto che la foresta dei Fuorilegge è il primo tentativo di
Shakespeare d’immettere nella sua commedia il cosiddetto greenwood:
un’isola verde, un’oasi silvana, una zona franca dove sottrarsi per qualche
tempo al disagio della civiltà. All’origine di questo miraggio della fantasia
c’è il ricordo leggendario della foresta di Sherwood e dell’allegra masnada
di Robin Hood, esplicitamente evocato nel testo: ma a monte c’è il mito
antico e perenne dell’Arcadia, tanto più ricco di implicazioni. Questo
«deserto ombroso» tra Milano e Verona prelude a quello ben più misterioso
del Sogno, percorso da elfi, fate e folletti, e alla stilizzata foresta di Arden
del Come vi piace, abitata da cacciatori e boscaioli: due fra le più felici
creazioni del poeta. Verranno poi i pastori del Racconto d’inverno, e gli
onesti cavernicoli di Cimbelino. Tra queste semplici creature trovan rifugio
personaggi dal mondo iniquo, disordinato, complicato, artefatto che si suol
definire consorzio civile. Qui essi ritroveranno se stessi, per uscirne
ritemprati e sereni, purificati da veleni e tensioni. La foresta, che altrove
avrà un ruolo centrale, qui è relegata ai margini della commedia; ma è
significativo che Valentino - lui che più d’ogni altro aspirava a essere uomo
di mondo - si adatti subito alla legge del greenwood:
Come l’uso nell’uomo tende a farsi costume!
Questo deserto ombroso, i boschi disabitati,
li preferisco a fiorenti città popolose...
(V, iv, 1-3)
Non altrimenti si esprime il Duca Orsino, anch’egli bandito, in Come vi
piace:
Qui il tempo e l’uso non han reso la vita più dolce
della pompa sgargiante? E non son queste selve
più libere da insidie di un’invida corte?
(II, i, 2-4)
In questa commedia siamo solo all’inizio, in chiave di scherzo, di un
movimento che sul piano tematico sarà finemente orchestrato nei drammi
a venire. Tre sono invece i temi compiutamente sviluppati e intrecciati fra
loro: l’amore, l’amicizia, e l’educazione del gentiluomo. Tutti e tre svolti in
chiave ironico-parodistica.
Quello dell’educazione è non meno centrale degli altri due (diventerà poi
l’asse portante di un testo come Pene d’amor perdute). Il tema, introdotto
nelle battute iniziali (il valore formativo del viaggiare) e riproposto da
Antonio e Pantino (I, iii), è risollevato in forma grottesca nelle
recriminazioni di Lanciotto sui comportamenti di Crab (IV, iv), nell’inopinata