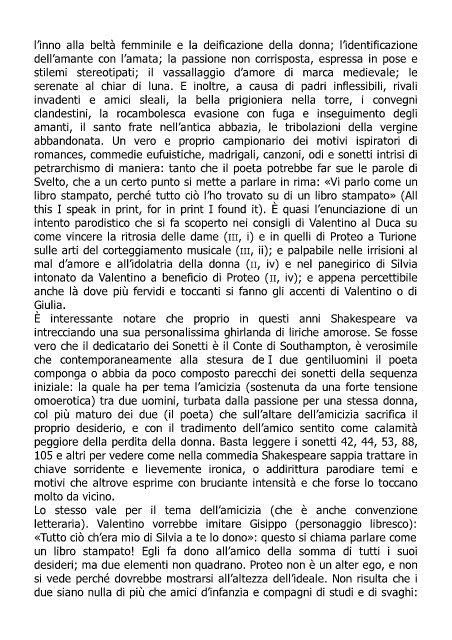Page 1758 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1758
l’inno alla beltà femminile e la deificazione della donna; l’identificazione
dell’amante con l’amata; la passione non corrisposta, espressa in pose e
stilemi stereotipati; il vassallaggio d’amore di marca medievale; le
serenate al chiar di luna. E inoltre, a causa di padri inflessibili, rivali
invadenti e amici sleali, la bella prigioniera nella torre, i convegni
clandestini, la rocambolesca evasione con fuga e inseguimento degli
amanti, il santo frate nell’antica abbazia, le tribolazioni della vergine
abbandonata. Un vero e proprio campionario dei motivi ispiratori di
romances, commedie eufuistiche, madrigali, canzoni, odi e sonetti intrisi di
petrarchismo di maniera: tanto che il poeta potrebbe far sue le parole di
Svelto, che a un certo punto si mette a parlare in rima: «Vi parlo come un
libro stampato, perché tutto ciò l’ho trovato su di un libro stampato» (All
this I speak in print, for in print I found it). È quasi l’enunciazione di un
intento parodistico che si fa scoperto nei consigli di Valentino al Duca su
come vincere la ritrosia delle dame (III, i) e in quelli di Proteo a Turione
sulle arti del corteggiamento musicale (III, ii); e palpabile nelle irrisioni al
mal d’amore e all’idolatria della donna (II, iv) e nel panegirico di Silvia
intonato da Valentino a beneficio di Proteo (II, iv); e appena percettibile
anche là dove più fervidi e toccanti si fanno gli accenti di Valentino o di
Giulia.
È interessante notare che proprio in questi anni Shakespeare va
intrecciando una sua personalissima ghirlanda di liriche amorose. Se fosse
vero che il dedicatario dei Sonetti è il Conte di Southampton, è verosimile
che contemporaneamente alla stesura de I due gentiluomini il poeta
componga o abbia da poco composto parecchi dei sonetti della sequenza
iniziale: la quale ha per tema l’amicizia (sostenuta da una forte tensione
omoerotica) tra due uomini, turbata dalla passione per una stessa donna,
col più maturo dei due (il poeta) che sull’altare dell’amicizia sacrifica il
proprio desiderio, e con il tradimento dell’amico sentito come calamità
peggiore della perdita della donna. Basta leggere i sonetti 42, 44, 53, 88,
105 e altri per vedere come nella commedia Shakespeare sappia trattare in
chiave sorridente e lievemente ironica, o addirittura parodiare temi e
motivi che altrove esprime con bruciante intensità e che forse lo toccano
molto da vicino.
Lo stesso vale per il tema dell’amicizia (che è anche convenzione
letteraria). Valentino vorrebbe imitare Gisippo (personaggio libresco):
«Tutto ciò ch’era mio di Silvia a te lo dono»: questo si chiama parlare come
un libro stampato! Egli fa dono all’amico della somma di tutti i suoi
desideri; ma due elementi non quadrano. Proteo non è un alter ego, e non
si vede perché dovrebbe mostrarsi all’altezza dell’ideale. Non risulta che i
due siano nulla di più che amici d’infanzia e compagni di studi e di svaghi: