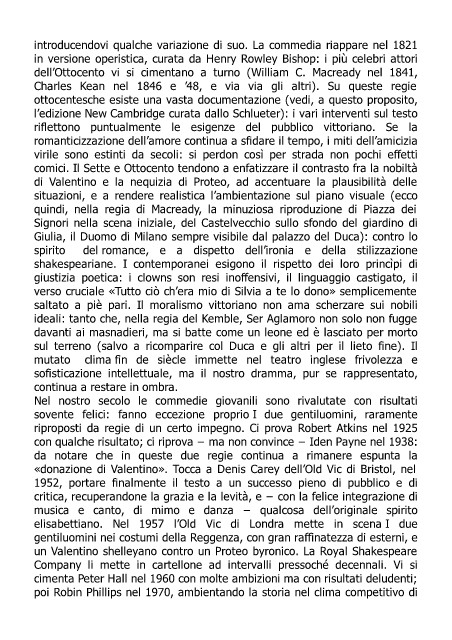Page 1762 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1762
introducendovi qualche variazione di suo. La commedia riappare nel 1821
in versione operistica, curata da Henry Rowley Bishop: i più celebri attori
dell’Ottocento vi si cimentano a turno (William C. Macready nel 1841,
Charles Kean nel 1846 e ’48, e via via gli altri). Su queste regie
ottocentesche esiste una vasta documentazione (vedi, a questo proposito,
l’edizione New Cambridge curata dallo Schlueter): i vari interventi sul testo
riflettono puntualmente le esigenze del pubblico vittoriano. Se la
romanticizzazione dell’amore continua a sfidare il tempo, i miti dell’amicizia
virile sono estinti da secoli: si perdon così per strada non pochi effetti
comici. Il Sette e Ottocento tendono a enfatizzare il contrasto fra la nobiltà
di Valentino e la nequizia di Proteo, ad accentuare la plausibilità delle
situazioni, e a rendere realistica l’ambientazione sul piano visuale (ecco
quindi, nella regia di Macready, la minuziosa riproduzione di Piazza dei
Signori nella scena iniziale, del Castelvecchio sullo sfondo del giardino di
Giulia, il Duomo di Milano sempre visibile dal palazzo del Duca): contro lo
spirito del romance, e a dispetto dell’ironia e della stilizzazione
shakespeariane. I contemporanei esigono il rispetto dei loro princìpi di
giustizia poetica: i clowns son resi inoffensivi, il linguaggio castigato, il
verso cruciale «Tutto ciò ch’era mio di Silvia a te lo dono» semplicemente
saltato a piè pari. Il moralismo vittoriano non ama scherzare sui nobili
ideali: tanto che, nella regia del Kemble, Ser Aglamoro non solo non fugge
davanti ai masnadieri, ma si batte come un leone ed è lasciato per morto
sul terreno (salvo a ricomparire col Duca e gli altri per il lieto fine). Il
mutato clima fin de siècle immette nel teatro inglese frivolezza e
sofisticazione intellettuale, ma il nostro dramma, pur se rappresentato,
continua a restare in ombra.
Nel nostro secolo le commedie giovanili sono rivalutate con risultati
sovente felici: fanno eccezione proprio I due gentiluomini, raramente
riproposti da regie di un certo impegno. Ci prova Robert Atkins nel 1925
con qualche risultato; ci riprova - ma non convince - Iden Payne nel 1938:
da notare che in queste due regie continua a rimanere espunta la
«donazione di Valentino». Tocca a Denis Carey dell’Old Vic di Bristol, nel
1952, portare finalmente il testo a un successo pieno di pubblico e di
critica, recuperandone la grazia e la levità, e - con la felice integrazione di
musica e canto, di mimo e danza - qualcosa dell’originale spirito
elisabettiano. Nel 1957 l’Old Vic di Londra mette in scena I due
gentiluomini nei costumi della Reggenza, con gran raffinatezza di esterni, e
un Valentino shelleyano contro un Proteo byronico. La Royal Shakespeare
Company li mette in cartellone ad intervalli pressoché decennali. Vi si
cimenta Peter Hall nel 1960 con molte ambizioni ma con risultati deludenti;
poi Robin Phillips nel 1970, ambientando la storia nel clima competitivo di