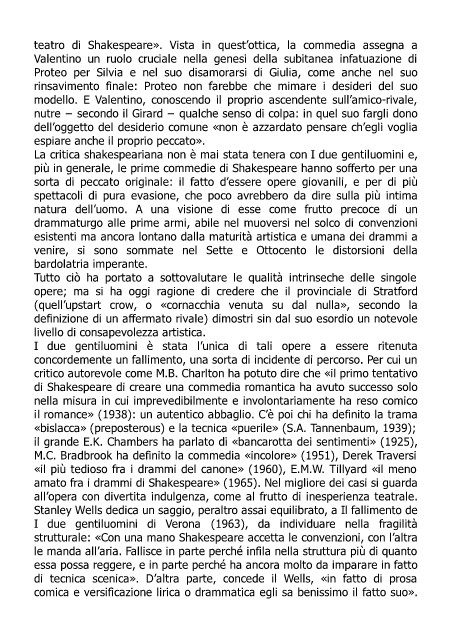Page 1760 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1760
teatro di Shakespeare». Vista in quest’ottica, la commedia assegna a
Valentino un ruolo cruciale nella genesi della subitanea infatuazione di
Proteo per Silvia e nel suo disamorarsi di Giulia, come anche nel suo
rinsavimento finale: Proteo non farebbe che mimare i desideri del suo
modello. E Valentino, conoscendo il proprio ascendente sull’amico-rivale,
nutre - secondo il Girard - qualche senso di colpa: in quel suo fargli dono
dell’oggetto del desiderio comune «non è azzardato pensare ch’egli voglia
espiare anche il proprio peccato».
La critica shakespeariana non è mai stata tenera con I due gentiluomini e,
più in generale, le prime commedie di Shakespeare hanno sofferto per una
sorta di peccato originale: il fatto d’essere opere giovanili, e per di più
spettacoli di pura evasione, che poco avrebbero da dire sulla più intima
natura dell’uomo. A una visione di esse come frutto precoce di un
drammaturgo alle prime armi, abile nel muoversi nel solco di convenzioni
esistenti ma ancora lontano dalla maturità artistica e umana dei drammi a
venire, si sono sommate nel Sette e Ottocento le distorsioni della
bardolatria imperante.
Tutto ciò ha portato a sottovalutare le qualità intrinseche delle singole
opere; ma si ha oggi ragione di credere che il provinciale di Stratford
(quell’upstart crow, o «cornacchia venuta su dal nulla», secondo la
definizione di un affermato rivale) dimostri sin dal suo esordio un notevole
livello di consapevolezza artistica.
I due gentiluomini è stata l’unica di tali opere a essere ritenuta
concordemente un fallimento, una sorta di incidente di percorso. Per cui un
critico autorevole come M.B. Charlton ha potuto dire che «il primo tentativo
di Shakespeare di creare una commedia romantica ha avuto successo solo
nella misura in cui imprevedibilmente e involontariamente ha reso comico
il romance» (1938): un autentico abbaglio. C’è poi chi ha definito la trama
«bislacca» (preposterous) e la tecnica «puerile» (S.A. Tannenbaum, 1939);
il grande E.K. Chambers ha parlato di «bancarotta dei sentimenti» (1925),
M.C. Bradbrook ha definito la commedia «incolore» (1951), Derek Traversi
«il più tedioso fra i drammi del canone» (1960), E.M.W. Tillyard «il meno
amato fra i drammi di Shakespeare» (1965). Nel migliore dei casi si guarda
all’opera con divertita indulgenza, come al frutto di inesperienza teatrale.
Stanley Wells dedica un saggio, peraltro assai equilibrato, a Il fallimento de
I due gentiluomini di Verona (1963), da individuare nella fragilità
strutturale: «Con una mano Shakespeare accetta le convenzioni, con l’altra
le manda all’aria. Fallisce in parte perché infila nella struttura più di quanto
essa possa reggere, e in parte perché ha ancora molto da imparare in fatto
di tecnica scenica». D’altra parte, concede il Wells, «in fatto di prosa
comica e versificazione lirica o drammatica egli sa benissimo il fatto suo».