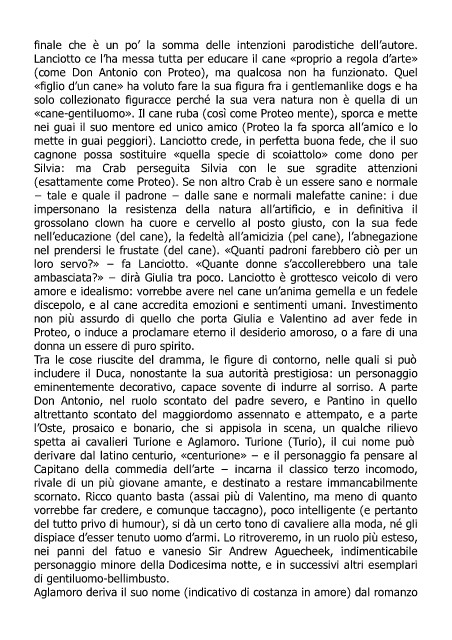Page 1754 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1754
finale che è un po’ la somma delle intenzioni parodistiche dell’autore.
Lanciotto ce l’ha messa tutta per educare il cane «proprio a regola d’arte»
(come Don Antonio con Proteo), ma qualcosa non ha funzionato. Quel
«figlio d’un cane» ha voluto fare la sua figura fra i gentlemanlike dogs e ha
solo collezionato figuracce perché la sua vera natura non è quella di un
«cane-gentiluomo». Il cane ruba (così come Proteo mente), sporca e mette
nei guai il suo mentore ed unico amico (Proteo la fa sporca all’amico e lo
mette in guai peggiori). Lanciotto crede, in perfetta buona fede, che il suo
cagnone possa sostituire «quella specie di scoiattolo» come dono per
Silvia: ma Crab perseguita Silvia con le sue sgradite attenzioni
(esattamente come Proteo). Se non altro Crab è un essere sano e normale
- tale e quale il padrone - dalle sane e normali malefatte canine: i due
impersonano la resistenza della natura all’artificio, e in definitiva il
grossolano clown ha cuore e cervello al posto giusto, con la sua fede
nell’educazione (del cane), la fedeltà all’amicizia (pel cane), l’abnegazione
nel prendersi le frustate (del cane). «Quanti padroni farebbero ciò per un
loro servo?» - fa Lanciotto. «Quante donne s’accollerebbero una tale
ambasciata?» - dirà Giulia tra poco. Lanciotto è grottesco veicolo di vero
amore e idealismo: vorrebbe avere nel cane un’anima gemella e un fedele
discepolo, e al cane accredita emozioni e sentimenti umani. Investimento
non più assurdo di quello che porta Giulia e Valentino ad aver fede in
Proteo, o induce a proclamare eterno il desiderio amoroso, o a fare di una
donna un essere di puro spirito.
Tra le cose riuscite del dramma, le figure di contorno, nelle quali si può
includere il Duca, nonostante la sua autorità prestigiosa: un personaggio
eminentemente decorativo, capace sovente di indurre al sorriso. A parte
Don Antonio, nel ruolo scontato del padre severo, e Pantino in quello
altrettanto scontato del maggiordomo assennato e attempato, e a parte
l’Oste, prosaico e bonario, che si appisola in scena, un qualche rilievo
spetta ai cavalieri Turione e Aglamoro. Turione (Turio), il cui nome può
derivare dal latino centurio, «centurione» - e il personaggio fa pensare al
Capitano della commedia dell’arte - incarna il classico terzo incomodo,
rivale di un più giovane amante, e destinato a restare immancabilmente
scornato. Ricco quanto basta (assai più di Valentino, ma meno di quanto
vorrebbe far credere, e comunque taccagno), poco intelligente (e pertanto
del tutto privo di humour), si dà un certo tono di cavaliere alla moda, né gli
dispiace d’esser tenuto uomo d’armi. Lo ritroveremo, in un ruolo più esteso,
nei panni del fatuo e vanesio Sir Andrew Aguecheek, indimenticabile
personaggio minore della Dodicesima notte, e in successivi altri esemplari
di gentiluomo-bellimbusto.
Aglamoro deriva il suo nome (indicativo di costanza in amore) dal romanzo