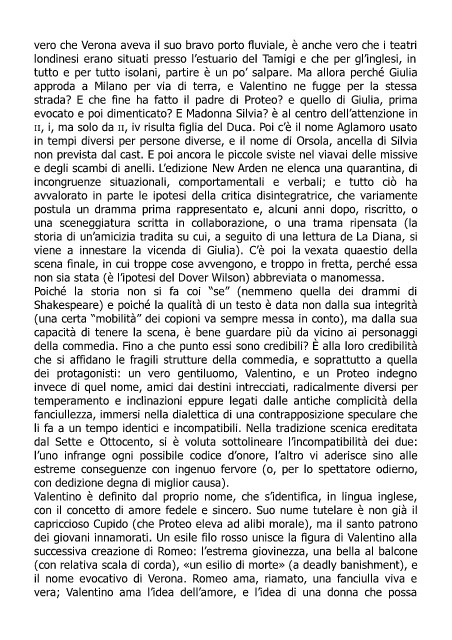Page 1747 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1747
vero che Verona aveva il suo bravo porto fluviale, è anche vero che i teatri
londinesi erano situati presso l’estuario del Tamigi e che per gl’inglesi, in
tutto e per tutto isolani, partire è un po’ salpare. Ma allora perché Giulia
approda a Milano per via di terra, e Valentino ne fugge per la stessa
strada? E che fine ha fatto il padre di Proteo? e quello di Giulia, prima
evocato e poi dimenticato? E Madonna Silvia? è al centro dell’attenzione in
II, i, ma solo da II, iv risulta figlia del Duca. Poi c’è il nome Aglamoro usato
in tempi diversi per persone diverse, e il nome di Orsola, ancella di Silvia
non prevista dal cast. E poi ancora le piccole sviste nel viavai delle missive
e degli scambi di anelli. L’edizione New Arden ne elenca una quarantina, di
incongruenze situazionali, comportamentali e verbali; e tutto ciò ha
avvalorato in parte le ipotesi della critica disintegratrice, che variamente
postula un dramma prima rappresentato e, alcuni anni dopo, riscritto, o
una sceneggiatura scritta in collaborazione, o una trama ripensata (la
storia di un’amicizia tradita su cui, a seguito di una lettura de La Diana, si
viene a innestare la vicenda di Giulia). C’è poi la vexata quaestio della
scena finale, in cui troppe cose avvengono, e troppo in fretta, perché essa
non sia stata (è l’ipotesi del Dover Wilson) abbreviata o manomessa.
Poiché la storia non si fa coi “se” (nemmeno quella dei drammi di
Shakespeare) e poiché la qualità di un testo è data non dalla sua integrità
(una certa “mobilità” dei copioni va sempre messa in conto), ma dalla sua
capacità di tenere la scena, è bene guardare più da vicino ai personaggi
della commedia. Fino a che punto essi sono credibili? È alla loro credibilità
che si affidano le fragili strutture della commedia, e soprattutto a quella
dei protagonisti: un vero gentiluomo, Valentino, e un Proteo indegno
invece di quel nome, amici dai destini intrecciati, radicalmente diversi per
temperamento e inclinazioni eppure legati dalle antiche complicità della
fanciullezza, immersi nella dialettica di una contrapposizione speculare che
li fa a un tempo identici e incompatibili. Nella tradizione scenica ereditata
dal Sette e Ottocento, si è voluta sottolineare l’incompatibilità dei due:
l’uno infrange ogni possibile codice d’onore, l’altro vi aderisce sino alle
estreme conseguenze con ingenuo fervore (o, per lo spettatore odierno,
con dedizione degna di miglior causa).
Valentino è definito dal proprio nome, che s’identifica, in lingua inglese,
con il concetto di amore fedele e sincero. Suo nume tutelare è non già il
capriccioso Cupido (che Proteo eleva ad alibi morale), ma il santo patrono
dei giovani innamorati. Un esile filo rosso unisce la figura di Valentino alla
successiva creazione di Romeo: l’estrema giovinezza, una bella al balcone
(con relativa scala di corda), «un esilio di morte» (a deadly banishment), e
il nome evocativo di Verona. Romeo ama, riamato, una fanciulla viva e
vera; Valentino ama l’idea dell’amore, e l’idea di una donna che possa