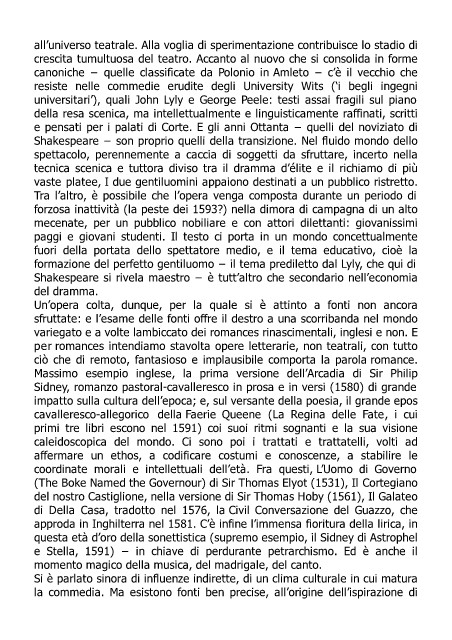Page 1742 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1742
all’universo teatrale. Alla voglia di sperimentazione contribuisce lo stadio di
crescita tumultuosa del teatro. Accanto al nuovo che si consolida in forme
canoniche - quelle classificate da Polonio in Amleto - c’è il vecchio che
resiste nelle commedie erudite degli University Wits (‘i begli ingegni
universitari’), quali John Lyly e George Peele: testi assai fragili sul piano
della resa scenica, ma intellettualmente e linguisticamente raffinati, scritti
e pensati per i palati di Corte. E gli anni Ottanta - quelli del noviziato di
Shakespeare - son proprio quelli della transizione. Nel fluido mondo dello
spettacolo, perennemente a caccia di soggetti da sfruttare, incerto nella
tecnica scenica e tuttora diviso tra il dramma d’élite e il richiamo di più
vaste platee, I due gentiluomini appaiono destinati a un pubblico ristretto.
Tra l’altro, è possibile che l’opera venga composta durante un periodo di
forzosa inattività (la peste dei 1593?) nella dimora di campagna di un alto
mecenate, per un pubblico nobiliare e con attori dilettanti: giovanissimi
paggi e giovani studenti. Il testo ci porta in un mondo concettualmente
fuori della portata dello spettatore medio, e il tema educativo, cioè la
formazione del perfetto gentiluomo - il tema prediletto dal Lyly, che qui di
Shakespeare si rivela maestro - è tutt’altro che secondario nell’economia
del dramma.
Un’opera colta, dunque, per la quale si è attinto a fonti non ancora
sfruttate: e l’esame delle fonti offre il destro a una scorribanda nel mondo
variegato e a volte lambiccato dei romances rinascimentali, inglesi e non. E
per romances intendiamo stavolta opere letterarie, non teatrali, con tutto
ciò che di remoto, fantasioso e implausibile comporta la parola romance.
Massimo esempio inglese, la prima versione dell’Arcadia di Sir Philip
Sidney, romanzo pastoral-cavalleresco in prosa e in versi (1580) di grande
impatto sulla cultura dell’epoca; e, sul versante della poesia, il grande epos
cavalleresco-allegorico della Faerie Queene (La Regina delle Fate, i cui
primi tre libri escono nel 1591) coi suoi ritmi sognanti e la sua visione
caleidoscopica del mondo. Ci sono poi i trattati e trattatelli, volti ad
affermare un ethos, a codificare costumi e conoscenze, a stabilire le
coordinate morali e intellettuali dell’età. Fra questi, L’Uomo di Governo
(The Boke Named the Governour) di Sir Thomas Elyot (1531), Il Cortegiano
del nostro Castiglione, nella versione di Sir Thomas Hoby (1561), Il Galateo
di Della Casa, tradotto nel 1576, la Civil Conversazione del Guazzo, che
approda in Inghilterra nel 1581. C’è infine l’immensa fioritura della lirica, in
questa età d’oro della sonettistica (supremo esempio, il Sidney di Astrophel
e Stella, 1591) - in chiave di perdurante petrarchismo. Ed è anche il
momento magico della musica, del madrigale, del canto.
Si è parlato sinora di influenze indirette, di un clima culturale in cui matura
la commedia. Ma esistono fonti ben precise, all’origine dell’ispirazione di