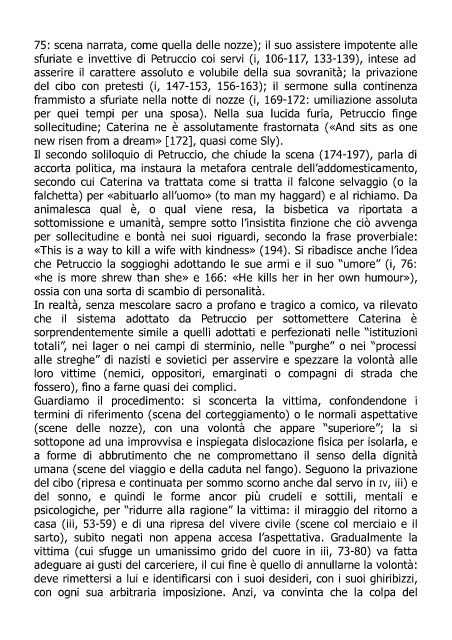Page 1272 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1272
75: scena narrata, come quella delle nozze); il suo assistere impotente alle
sfuriate e invettive di Petruccio coi servi (i, 106-117, 133-139), intese ad
asserire il carattere assoluto e volubile della sua sovranità; la privazione
del cibo con pretesti (i, 147-153, 156-163); il sermone sulla continenza
frammisto a sfuriate nella notte di nozze (i, 169-172: umiliazione assoluta
per quei tempi per una sposa). Nella sua lucida furia, Petruccio finge
sollecitudine; Caterina ne è assolutamente frastornata («And sits as one
new risen from a dream» [172], quasi come Sly).
Il secondo soliloquio di Petruccio, che chiude la scena (174-197), parla di
accorta politica, ma instaura la metafora centrale dell’addomesticamento,
secondo cui Caterina va trattata come si tratta il falcone selvaggio (o la
falchetta) per «abituarlo all’uomo» (to man my haggard) e al richiamo. Da
animalesca qual è, o qual viene resa, la bisbetica va riportata a
sottomissione e umanità, sempre sotto l’insistita finzione che ciò avvenga
per sollecitudine e bontà nei suoi riguardi, secondo la frase proverbiale:
«This is a way to kill a wife with kindness» (194). Si ribadisce anche l’idea
che Petruccio la soggioghi adottando le sue armi e il suo “umore” (i, 76:
«he is more shrew than she» e 166: «He kills her in her own humour»),
ossia con una sorta di scambio di personalità.
In realtà, senza mescolare sacro a profano e tragico a comico, va rilevato
che il sistema adottato da Petruccio per sottomettere Caterina è
sorprendentemente simile a quelli adottati e perfezionati nelle “istituzioni
totali”, nei lager o nei campi di sterminio, nelle “purghe” o nei “processi
alle streghe” di nazisti e sovietici per asservire e spezzare la volontà alle
loro vittime (nemici, oppositori, emarginati o compagni di strada che
fossero), fino a farne quasi dei complici.
Guardiamo il procedimento: si sconcerta la vittima, confondendone i
termini di riferimento (scena del corteggiamento) o le normali aspettative
(scene delle nozze), con una volontà che appare “superiore”; la si
sottopone ad una improvvisa e inspiegata dislocazione fisica per isolarla, e
a forme di abbrutimento che ne compromettano il senso della dignità
umana (scene del viaggio e della caduta nel fango). Seguono la privazione
del cibo (ripresa e continuata per sommo scorno anche dal servo in IV, iii) e
del sonno, e quindi le forme ancor più crudeli e sottili, mentali e
psicologiche, per “ridurre alla ragione” la vittima: il miraggio del ritorno a
casa (iii, 53-59) e di una ripresa del vivere civile (scene col merciaio e il
sarto), subito negati non appena accesa l’aspettativa. Gradualmente la
vittima (cui sfugge un umanissimo grido del cuore in iii, 73-80) va fatta
adeguare ai gusti del carceriere, il cui fine è quello di annullarne la volontà:
deve rimettersi a lui e identificarsi con i suoi desideri, con i suoi ghiribizzi,
con ogni sua arbitraria imposizione. Anzi, va convinta che la colpa del