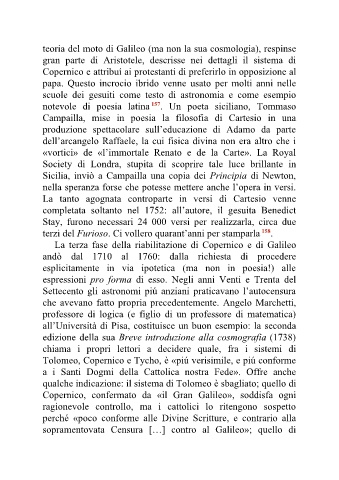Page 552 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 552
teoria del moto di Galileo (ma non la sua cosmologia), respinse
gran parte di Aristotele, descrisse nei dettagli il sistema di
Copernico e attribuí ai protestanti di preferirlo in opposizione al
papa. Questo incrocio ibrido venne usato per molti anni nelle
scuole dei gesuiti come testo di astronomia e come esempio
notevole di poesia latina 157 . Un poeta siciliano, Tommaso
Campailla, mise in poesia la filosofia di Cartesio in una
produzione spettacolare sull’educazione di Adamo da parte
dell’arcangelo Raffaele, la cui fisica divina non era altro che i
«vortici» de «l’immortale Renato e de la Carte». La Royal
Society di Londra, stupita di scoprire tale luce brillante in
Sicilia, inviò a Campailla una copia dei Principia di Newton,
nella speranza forse che potesse mettere anche l’opera in versi.
La tanto agognata controparte in versi di Cartesio venne
completata soltanto nel 1752: all’autore, il gesuita Benedict
Stay, furono necessari 24 000 versi per realizzarla, circa due
terzi del Furioso. Ci vollero quarant’anni per stamparla 158 .
La terza fase della riabilitazione di Copernico e di Galileo
andò dal 1710 al 1760: dalla richiesta di procedere
esplicitamente in via ipotetica (ma non in poesia!) alle
espressioni pro forma di esso. Negli anni Venti e Trenta del
Settecento gli astronomi piú anziani praticavano l’autocensura
che avevano fatto propria precedentemente. Angelo Marchetti,
professore di logica (e figlio di un professore di matematica)
all’Università di Pisa, costituisce un buon esempio: la seconda
edizione della sua Breve introduzione alla cosmografia (1738)
chiama i propri lettori a decidere quale, fra i sistemi di
Tolomeo, Copernico e Tycho, è «piú verisimile, e piú conforme
a i Santi Dogmi della Cattolica nostra Fede». Offre anche
qualche indicazione: il sistema di Tolomeo è sbagliato; quello di
Copernico, confermato da «il Gran Galileo», soddisfa ogni
ragionevole controllo, ma i cattolici lo ritengono sospetto
perché «poco conforme alle Divine Scritture, e contrario alla
sopramentovata Censura […] contro al Galileo»; quello di