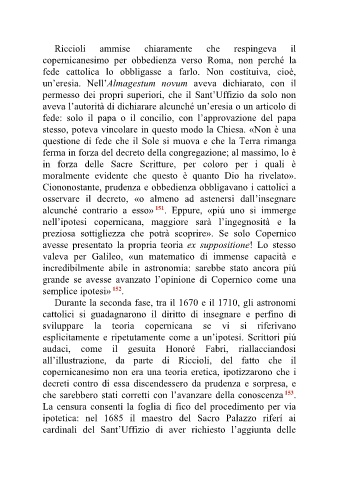Page 550 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 550
Riccioli ammise chiaramente che respingeva il
copernicanesimo per obbedienza verso Roma, non perché la
fede cattolica lo obbligasse a farlo. Non costituiva, cioè,
un’eresia. Nell’Almagestum novum aveva dichiarato, con il
permesso dei propri superiori, che il Sant’Uffizio da solo non
aveva l’autorità di dichiarare alcunché un’eresia o un articolo di
fede: solo il papa o il concilio, con l’approvazione del papa
stesso, poteva vincolare in questo modo la Chiesa. «Non è una
questione di fede che il Sole si muova e che la Terra rimanga
ferma in forza del decreto della congregazione; al massimo, lo è
in forza delle Sacre Scritture, per coloro per i quali è
moralmente evidente che questo è quanto Dio ha rivelato».
Ciononostante, prudenza e obbedienza obbligavano i cattolici a
osservare il decreto, «o almeno ad astenersi dall’insegnare
alcunché contrario a esso» 151 . Eppure, «piú uno si immerge
nell’ipotesi copernicana, maggiore sarà l’ingegnosità e la
preziosa sottigliezza che potrà scoprire». Se solo Copernico
avesse presentato la propria teoria ex suppositione! Lo stesso
valeva per Galileo, «un matematico di immense capacità e
incredibilmente abile in astronomia: sarebbe stato ancora piú
grande se avesse avanzato l’opinione di Copernico come una
semplice ipotesi» 152 .
Durante la seconda fase, tra il 1670 e il 1710, gli astronomi
cattolici si guadagnarono il diritto di insegnare e perfino di
sviluppare la teoria copernicana se vi si riferivano
esplicitamente e ripetutamente come a un’ipotesi. Scrittori piú
audaci, come il gesuita Honoré Fabri, riallacciandosi
all’illustrazione, da parte di Riccioli, del fatto che il
copernicanesimo non era una teoria eretica, ipotizzarono che i
decreti contro di essa discendessero da prudenza e sorpresa, e
che sarebbero stati corretti con l’avanzare della conoscenza 153 .
La censura consentí la foglia di fico del procedimento per via
ipotetica: nel 1685 il maestro del Sacro Palazzo riferí ai
cardinali del Sant’Uffizio di aver richiesto l’aggiunta delle