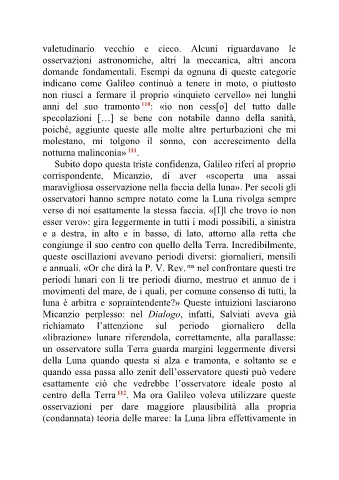Page 533 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 533
valetudinario vecchio e cieco. Alcuni riguardavano le
osservazioni astronomiche, altri la meccanica, altri ancora
domande fondamentali. Esempi da ognuna di queste categorie
indicano come Galileo continuò a tenere in moto, o piuttosto
non riuscí a fermare il proprio «inquieto cervello» nei lunghi
anni del suo tramonto 110 : «io non cess[o] del tutto dalle
specolazioni […] se bene con notabile danno della sanità,
poiché, aggiunte queste alle molte altre perturbazioni che mi
molestano, mi tolgono il sonno, con accrescimento della
notturna malinconia» 111 .
Subito dopo questa triste confidenza, Galileo riferí al proprio
corrispondente, Micanzio, di aver «scoperta una assai
maravigliosa osservazione nella faccia della luna». Per secoli gli
osservatori hanno sempre notato come la Luna rivolga sempre
verso di noi esattamente la stessa faccia. «[I]l che trovo io non
esser vero»: gira leggermente in tutti i modi possibili, a sinistra
e a destra, in alto e in basso, di lato, attorno alla retta che
congiunge il suo centro con quello della Terra. Incredibilmente,
queste oscillazioni avevano periodi diversi: giornalieri, mensili
ma
e annuali. «Or che dirà la P. V. Rev. nel confrontare questi tre
periodi lunari con li tre periodi diurno, mestruo et annuo de i
movimenti del mare, de i quali, per comune consenso di tutti, la
luna è arbitra e sopraintendente?» Queste intuizioni lasciarono
Micanzio perplesso: nel Dialogo, infatti, Salviati aveva già
richiamato l’attenzione sul periodo giornaliero della
«librazione» lunare riferendola, correttamente, alla parallasse:
un osservatore sulla Terra guarda margini leggermente diversi
della Luna quando questa si alza e tramonta, e soltanto se e
quando essa passa allo zenit dell’osservatore questi può vedere
esattamente ciò che vedrebbe l’osservatore ideale posto al
centro della Terra 112 . Ma ora Galileo voleva utilizzare queste
osservazioni per dare maggiore plausibilità alla propria
(condannata) teoria delle maree: la Luna libra effettivamente in