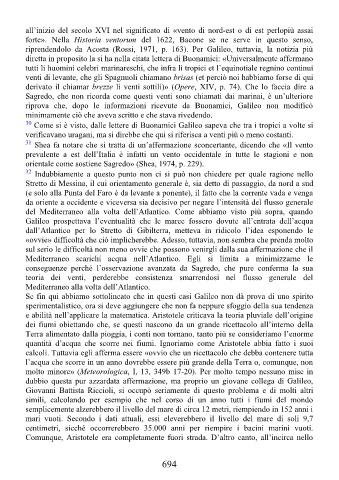Page 694 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 694
all’inizio del secolo XVI nel significato di «vento di nord-est o di est perlopiù assai
forte». Nella Historia ventorum del 1622, Bacone se ne serve in questo senso,
riprendendolo da Acosta (Rossi, 1971, p. 163). Per Galileo, tuttavia, la notizia più
diretta in proposito la si ha nella citata lettera di Buonamici: «Universalmente affermano
tutti li huomini celebri marinareschi, che infra li tropici et l’equinotiale regnino continui
venti di levante, che gli Spagnuoli chiamano brisas (et perciò noi habbiamo forse di qui
derivato il chiamar brezze li venti sottili)» (Opere, XIV, p. 74). Che lo faccia dire a
Sagredo, che non ricorda come questi venti sono chiamati dai marinai, è un’ulteriore
riprova che, dopo le informazioni ricevute da Buonamici, Galileo non modificò
minimamente ciò che aveva scritto e che stava rivedendo.
30 Come si è visto, dalle lettere di Buonamici Galileo sapeva che tra i tropici a volte si
verificavano uragani, ma si direbbe che qui si riferisca a venti più o meno costanti.
31
Shea fa notare che si tratta di un’affermazione sconcertante, dicendo che «Il vento
prevalente a est dell’Italia è infatti un vento occidentale in tutte le stagioni e non
orientale come sostiene Sagredo» (Shea, 1974, p. 229).
32
Indubbiamente a questo punto non ci si può non chiedere per quale ragione nello
Stretto di Messina, il cui orientamento generale è, sia detto di passaggio, da nord a sud
(e solo alla Punta del Faro è da levante a ponente), il fatto che la corrente vada e venga
da oriente a occidente e viceversa sia decisivo per negare l’intensità del flusso generale
del Mediterraneo alla volta dell’Atlantico. Come abbiamo visto più sopra, quando
Galileo prospettava l’eventualità che le maree fossero dovute all’entrata dell’acqua
dall’Atlantico per lo Stretto di Gibilterra, metteva in ridicolo l’idea esponendo le
«ovvie» difficoltà che ciò implicherebbe. Adesso, tuttavia, non sembra che prenda molto
sul serio le difficoltà non meno ovvie che possono venirgli dalla sua affermazione che il
Mediterraneo scarichi acqua nell’Atlantico. Egli si limita a minimizzarne le
conseguenze perché l’osservazione avanzata da Sagredo, che pure conferma la sua
teoria dei venti, perderebbe consistenza smarrendosi nel flusso generale del
Mediterraneo alla volta dell’Atlantico.
Se fin qui abbiamo sottolineato che in questi casi Galileo non dà prova di uno spirito
sperimentalistico, ora si deve aggiungere che non fa neppure sfoggio della sua tendenza
e abilità nell’applicare la matematica. Aristotele criticava la teoria pluviale dell’origine
dei fiumi obiettando che, se questi nascono da un grande ricettacolo all’interno della
Terra alimentato dalla pioggia, i conti non tornano, tanto più se consideriamo l’enorme
quantità d’acqua che scorre nei fiumi. Ignoriamo come Aristotele abbia fatto i suoi
calcoli. Tuttavia egli afferma essere «ovvio che un ricettacolo che debba contenere tutta
l’acqua che scorre in un anno dovrebbe essere più grande della Terra o, comunque, non
molto minore» (Meteorologica, I, 13, 349b 17-20). Per molto tempo nessuno mise in
dubbio questa pur azzardata affermazione, ma proprio un giovane collega di Galileo,
Giovanni Battista Riccioli, si occupò seriamente di questo problema e di molti altri
simili, calcolando per esempio che nel corso di un anno tutti i fiumi del mondo
semplicemente alzerebbero il livello del mare di circa 12 metri, riempiendo in 152 anni i
mari vuoti. Secondo i dati attuali, essi eleverebbero il livello del mare di soli 9,7
centimetri, sicché occorrerebbero 35.000 anni per riempire i bacini marini vuoti.
Comunque, Aristotele era completamente fuori strada. D’altro canto, all’incirca nello
694