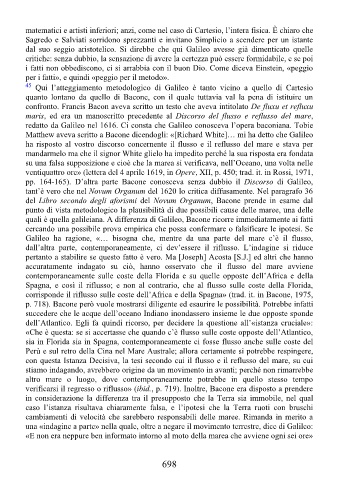Page 698 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 698
matematici e artisti inferiori; anzi, come nel caso di Cartesio, l’intera fisica. È chiaro che
Sagredo e Salviati sorridono sprezzanti e invitano Simplicio a scendere per un istante
dal suo seggio aristotelico. Si direbbe che qui Galileo avesse già dimenticato quelle
critiche: senza dubbio, la sensazione di avere la certezza può essere formidabile, e se poi
i fatti non obbediscono, ci si arrabbia con il buon Dio. Come diceva Einstein, «peggio
per i fatti», e quindi «peggio per il metodo».
45 Qui l’atteggiamento metodologico di Galileo è tanto vicino a quello di Cartesio
quanto lontano da quello di Bacone, con il quale tuttavia val la pena di istituire un
confronto. Francis Bacon aveva scritto un testo che aveva intitolato De fluxu et refluxu
maris, ed era un manoscritto precedente al Discorso del flusso e reflusso del mare,
redatto da Galileo nel 1616. Ci consta che Galileo conosceva l’opera baconiana. Tobie
Matthew aveva scritto a Bacone dicendogli: «[Richard White]… mi ha detto che Galileo
ha risposto al vostro discorso concernente il flusso e il reflusso del mare e stava per
mandarmelo ma che il signor White glielo ha impedito perché la sua risposta era fondata
su una falsa supposizione e cioè che la marea si verificava, nell’Oceano, una volta nelle
ventiquattro ore» (lettera del 4 aprile 1619, in Opere, XII, p. 450; trad. it. in Rossi, 1971,
pp. 164-165). D’altra parte Bacone conosceva senza dubbio il Discorso di Galileo,
tant’è vero che nel Novum Organum del 1620 lo critica diffusamente. Nel paragrafo 36
del Libro secondo degli aforismi del Novum Organum, Bacone prende in esame dal
punto di vista metodologico la plausibilità di due possibili cause delle maree, una delle
quali è quella galileiana. A differenza di Galileo, Bacone ricorre immediatamente ai fatti
cercando una possibile prova empirica che possa confermare o falsificare le ipotesi. Se
Galileo ha ragione, «… bisogna che, mentre da una parte del mare c’è il flusso,
dall’altra parte, contemporaneamente, ci dev’essere il riflusso. L’indagine si riduce
pertanto a stabilire se questo fatto è vero. Ma [Joseph] Acosta [S.J.] ed altri che hanno
accuratamente indagato su ciò, hanno osservato che il flusso del mare avviene
contemporaneamente sulle coste della Florida e su quelle opposte dell’Africa e della
Spagna, e così il riflusso; e non al contrario, che al flusso sulle coste della Florida,
corrisponde il riflusso sulle coste dell’Africa e della Spagna» (trad. it. in Bacone, 1975,
p. 718). Bacone però vuole mostrarsi diligente ed esaurire le possibilità. Potrebbe infatti
succedere che le acque dell’oceano Indiano inondassero insieme le due opposte sponde
dell’Atlantico. Egli fa quindi ricorso, per decidere la questione all’«istanza cruciale»:
«Che è questa: se si accertasse che quando c’è flusso sulle coste opposte dell’Atlantico,
sia in Florida sia in Spagna, contemporaneamente ci fosse flusso anche sulle coste del
Perù e sul retro della Cina nel Mare Australe; allora certamente si potrebbe respingere,
con questa Istanza Decisiva, la tesi secondo cui il flusso e il reflusso del mare, su cui
stiamo indagando, avrebbero origine da un movimento in avanti; perché non rimarrebbe
altro mare o luogo, dove contemporaneamente potrebbe in quello stesso tempo
verificarsi il regresso o riflusso» (ibid., p. 719). Inoltre, Bacone era disposto a prendere
in considerazione la differenza tra il presupposto che la Terra sia immobile, nel qual
caso l’istanza risultava chiaramente falsa, e l’ipotesi che la Terra ruoti con bruschi
cambiamenti di velocità che sarebbero responsabili delle maree. Rimanda in merito a
una «indagine a parte» nella quale, oltre a negare il movimento terrestre, dice di Galileo:
«E non era neppure ben informato intorno al moto della marea che avviene ogni sei ore»
698