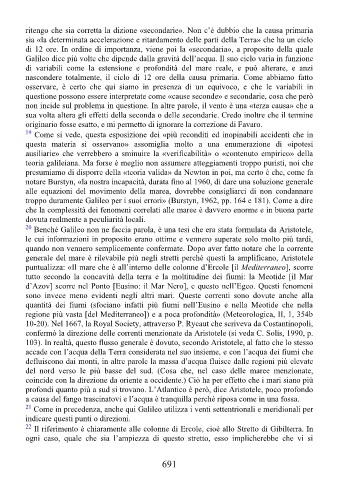Page 691 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 691
ritengo che sia corretta la dizione «secondarie». Non c’è dubbio che la causa primaria
sia «la determinata accelerazione e ritardamento delle parti della Terra» che ha un ciclo
di 12 ore. In ordine di importanza, viene poi la «secondaria», a proposito della quale
Galileo dice più volte che dipende dalla gravità dell’acqua. Il suo ciclo varia in funzione
di variabili come la estensione e profondità del mare reale, e può alterare, e anzi
nascondere totalmente, il ciclo di 12 ore della causa primaria. Come abbiamo fatto
osservare, è certo che qui siamo in presenza di un equivoco, e che le variabili in
questione possono essere interpretate come «cause seconde» e secondarie, cosa che però
non incide sul problema in questione. In altre parole, il vento è una «terza causa» che a
sua volta altera gli effetti della seconda o delle secondarie. Credo inoltre che il termine
originario fosse esatto, e mi permetto di ignorare la correzione di Favaro.
19
Come si vede, questa esposizione dei «più reconditi ed inopinabili accidenti che in
questa materia si osservano» assomiglia molto a una enumerazione di «ipotesi
ausiliarie» che verrebbero a sminuire la «verificabilità» o «contenuto empirico» della
teoria galileiana. Ma forse è meglio non assumere atteggiamenti troppo puristi, noi che
presumiamo di disporre della «teoria valida» da Newton in poi, ma certo è che, come fa
notare Burstyn, «la nostra incapacità, durata fino al 1960, di dare una soluzione generale
alle equazioni del movimento della marea, dovrebbe consigliarci di non condannare
troppo duramente Galileo per i suoi errori» (Burstyn, 1962, pp. 164 e 181). Come a dire
che la complessità dei fenomeni correlati alle maree è davvero enorme e in buona parte
dovuta realmente a peculiarità locali.
20 Benché Galileo non ne faccia parola, è una tesi che era stata formulata da Aristotele,
le cui informazioni in proposito erano ottime e vennero superate solo molto più tardi,
quando non vennero semplicemente confermate. Dopo aver fatto notare che la corrente
generale del mare è rilevabile più negli stretti perché questi la amplificano, Aristotele
puntualizza: «Il mare che è all’interno delle colonne d’Ercole [il Mediterraneo], scorre
tutto secondo la concavità della terra e la moltitudine dei fiumi: la Meotide [il Mar
d’Azov] scorre nel Ponto [Eusino: il Mar Nero], e questo nell’Egeo. Questi fenomeni
sono invece meno evidenti negli altri mari. Queste correnti sono dovute anche alla
quantità dei fiumi (sfociano infatti più fiumi nell’Eusino e nella Meotide che nella
regione più vasta [del Mediterraneo]) e a poca profondità» (Meteorologica, II, 1, 354b
10-20). Nel 1667, la Royal Society, attraverso P. Rycaut che scriveva da Costantinopoli,
confermò la direzione delle correnti menzionate da Aristotele (si veda C. Solís, 1990, p.
103). In realtà, questo flusso generale è dovuto, secondo Aristotele, al fatto che lo stesso
accade con l’acqua della Terra considerata nel suo insieme, e con l’acqua dei fiumi che
defluiscono dai monti, in altre parole la massa d’acqua fluisce dalle regioni più elevate
del nord verso le più basse del sud. (Cosa che, nel caso delle maree menzionate,
coincide con la direzione da oriente a occidente.) Ciò ha per effetto che i mari siano più
profondi quanto più a sud si trovano. L’Atlantico è però, dice Aristotele, poco profondo
a causa del fango trascinatovi e l’acqua è tranquilla perché riposa come in una fossa.
21 Come in precedenza, anche qui Galileo utilizza i venti settentrionali e meridionali per
indicare questi punti o direzioni.
22
Il riferimento è chiaramente alle colonne di Ercole, cioè allo Stretto di Gibilterra. In
ogni caso, quale che sia l’ampiezza di questo stretto, esso implicherebbe che vi si
691