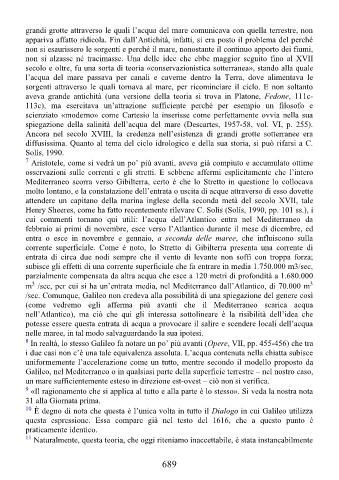Page 689 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 689
grandi grotte attraverso le quali l’acqua del mare comunicava con quella terrestre, non
appariva affatto ridicola. Fin dall’Antichità, infatti, si era posto il problema del perché
non si esaurissero le sorgenti e perché il mare, nonostante il continuo apporto dei fiumi,
non si alzasse né tracimasse. Una delle idee che ebbe maggior seguito fino al XVII
secolo e oltre, fu una sorta di teoria «conservazionistica sotterranea», stando alla quale
l’acqua del mare passava per canali e caverne dentro la Terra, dove alimentava le
sorgenti attraverso le quali tornava al mare, per ricominciare il ciclo. E non soltanto
aveva grande antichità (una versione della teoria si trova in Platone, Fedone, 111c-
113c), ma esercitava un’attrazione sufficiente perché per esempio un filosofo e
scienziato «moderno» come Cartesio la inserisse come perfettamente ovvia nella sua
spiegazione della salinità dell’acqua del mare (Descartes, 1957-58, vol. VI, p. 255).
Ancora nel secolo XVIII, la credenza nell’esistenza di grandi grotte sotterranee era
diffusissima. Quanto al tema del ciclo idrologico e della sua storia, si può rifarsi a C.
Solís, 1990.
7 Aristotele, come si vedrà un po’ più avanti, aveva già compiuto e accumulato ottime
osservazioni sulle correnti e gli stretti. E sebbene affermi esplicitamente che l’intero
Mediterraneo scorra verso Gibilterra, certo è che lo Stretto in questione lo collocava
molto lontano, e la constatazione dell’entrata o uscita di acque attraverso di esso dovette
attendere un capitano della marina inglese della seconda metà del secolo XVII, tale
Henry Sheeres, come ha fatto recentemente rilevare C. Solís (Solís, 1990, pp. 101 ss.), i
cui commenti tornano qui utili: l’acqua dell’Atlantico entra nel Mediterraneo da
febbraio ai primi di novembre, esce verso l’Atlantico durante il mese di dicembre, ed
entra o esce in novembre e gennaio, a seconda delle maree, che influiscono sulla
corrente superficiale. Come è noto, lo Stretto di Gibilterra presenta una corrente di
entrata di circa due nodi sempre che il vento di levante non soffi con troppa forza;
subisce gli effetti di una corrente superficiale che fa entrare in media 1.750.000 m3/sec,
parzialmente compensata da altra acqua che esce a 120 metri di profondità a 1.680.000
3
m /sec, per cui si ha un’entrata media, nel Mediterraneo dall’Atlantico, di 70.000 m 3
/sec. Comunque, Galileo non credeva alla possibilità di una spiegazione del genere così
(come vedremo egli afferma più avanti che il Mediterraneo scarica acqua
nell’Atlantico), ma ciò che qui gli interessa sottolineare è la risibilità dell’idea che
potesse essere questa entrata di acqua a provocare il salire e scendere locali dell’acqua
nelle maree, in tal modo salvaguardando la sua ipotesi.
8
In realtà, lo stesso Galileo fa notare un po’ più avanti (Opere, VII, pp. 455-456) che tra
i due casi non c’è una tale equivalenza assoluta. L’acqua contenuta nella chiatta subisce
uniformemente l’accelerazione come un tutto, mentre secondo il modello proposto da
Galileo, nel Mediterraneo o in qualsiasi parte della superficie terrestre – nel nostro caso,
un mare sufficientemente esteso in direzione est-ovest – ciò non si verifica.
9
«Il ragionamento che si applica al tutto e alla parte è lo stesso». Si veda la nostra nota
31 alla Giornata prima.
10 È degno di nota che questa è l’unica volta in tutto il Dialogo in cui Galileo utilizza
questa espressione. Essa compare già nel testo del 1616, che a questo punto è
praticamente identico.
11 Naturalmente, questa teoria, che oggi riteniamo inaccettabile, è stata instancabilmente
689