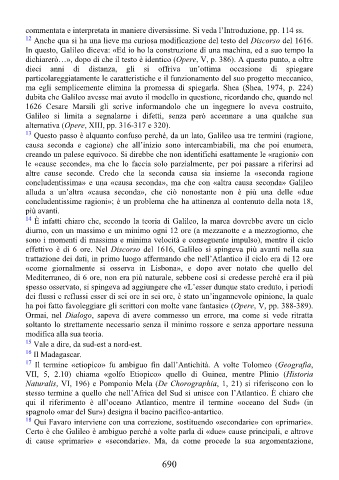Page 690 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 690
commentata e interpretata in maniere diversissime. Si veda l’Introduzione, pp. 114 ss.
12
Anche qua si ha una lieve ma curiosa modificazione del testo del Discorso del 1616.
In questo, Galileo diceva: «Ed io ho la construzione di una machina, ed a suo tempo la
dichiarerò…», dopo di che il testo è identico (Opere, V, p. 386). A questo punto, a oltre
dieci anni di distanza, gli si offriva un’ottima occasione di spiegare
particolareggiatamente le caratteristiche e il funzionamento del suo progetto meccanico,
ma egli semplicemente elimina la promessa di spiegarla. Shea (Shea, 1974, p. 224)
dubita che Galileo avesse mai avuto il modello in questione, ricordando che, quando nel
1626 Cesare Marsili gli scrive informandolo che un ingegnere lo aveva costruito,
Galileo si limita a segnalarne i difetti, senza però accennare a una qualche sua
alternativa (Opere, XIII, pp. 316-317 e 320).
13 Questo passo è alquanto confuso perché, da un lato, Galileo usa tre termini (ragione,
causa seconda e cagione) che all’inizio sono intercambiabili, ma che poi enumera,
creando un palese equivoco. Si direbbe che non identifichi esattamente le «ragioni» con
le «cause seconde», ma che lo faccia solo parzialmente, per poi passare a riferirsi ad
altre cause seconde. Credo che la seconda causa sia insieme la «seconda ragione
concludentissima» e una «causa seconda», ma che con «altra causa seconda» Galileo
alluda a un’altra «causa seconda», che ciò nonostante non è più una delle «due
concludentissime ragioni»; è un problema che ha attinenza al contenuto della nota 18,
più avanti.
14 È infatti chiaro che, secondo la teoria di Galileo, la marea dovrebbe avere un ciclo
diurno, con un massimo e un minimo ogni 12 ore (a mezzanotte e a mezzogiorno, che
sono i momenti di massima e minima velocità e conseguente impulso), mentre il ciclo
effettivo è di 6 ore. Nel Discorso del 1616, Galileo si spingeva più avanti nella sua
trattazione dei dati, in primo luogo affermando che nell’Atlantico il ciclo era di 12 ore
«come giornalmente si osserva in Lisbona», e dopo aver notato che quello del
Mediterraneo, di 6 ore, non era più naturale, sebbene così si credesse perché era il più
spesso osservato, si spingeva ad aggiungere che «L’esser dunque stato creduto, i periodi
dei flussi e reflussi esser di sei ore in sei ore, è stato un’ingannevole opinione, la quale
ha poi fatto favoleggiare gli scrittori con molte vane fantasie» (Opere, V, pp. 388-389).
Ormai, nel Dialogo, sapeva di avere commesso un errore, ma come si vede ritratta
soltanto lo strettamente necessario senza il minimo rossore e senza apportare nessuna
modifica alla sua teoria.
15 Vale a dire, da sud-est a nord-est.
16 Il Madagascar.
17 Il termine «etiopico» fu ambiguo fin dall’Antichità. A volte Tolomeo (Geografia,
VII, 5, 2.10) chiama «golfo Etiopico» quello di Guinea, mentre Plinio (Historia
Naturalis, VI, 196) e Pomponio Mela (De Chorographia, 1, 21) si riferiscono con lo
stesso termine a quello che nell’Africa del Sud si unisce con l’Atlantico. È chiaro che
qui il riferimento è all’oceano Atlantico, mentre il termine «oceano del Sud» (in
spagnolo «mar del Sur») designa il bacino pacifico-antartico.
18
Qui Favaro interviene con una correzione, sostituendo «secondarie» con «primarie».
Certo è che Galileo è ambiguo perché a volte parla di «due» cause principali, e altrove
di cause «primarie» e «secondarie». Ma, da come procede la sua argomentazione,
690