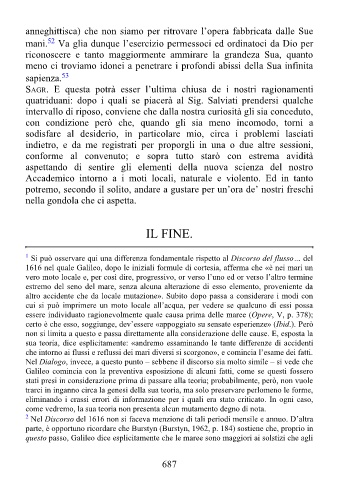Page 687 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 687
anneghittisca) che non siamo per ritrovare l’opera fabbricata dalle Sue
52
mani. Va glia dunque l’esercizio permessoci ed ordinatoci da Dio per
riconoscere e tanto maggiormente ammirare la grandeza Sua, quanto
meno ci troviamo idonei a penetrare i profondi abissi della Sua infinita
sapienza. 53
SAGR. E questa potrà esser l’ultima chiusa de i nostri ragionamenti
quatriduani: dopo i quali se piacerà al Sig. Salviati prendersi qualche
intervallo di riposo, conviene che dalla nostra curiosità gli sia conceduto,
con condizione però che, quando gli sia meno incomodo, torni a
sodisfare al desiderio, in particolare mio, circa i problemi lasciati
indietro, e da me registrati per proporgli in una o due altre sessioni,
conforme al convenuto; e sopra tutto starò con estrema avidità
aspettando di sentire gli elementi della nuova scienza del nostro
Accademico intorno a i moti locali, naturale e violento. Ed in tanto
potremo, secondo il solito, andare a gustare per un’ora de’ nostri freschi
nella gondola che ci aspetta.
IL FINE.
1 Si può osservare qui una differenza fondamentale rispetto al Discorso del flusso… del
1616 nel quale Galileo, dopo le iniziali formule di cortesia, afferma che «è nei mari un
vero moto locale e, per così dire, progressivo, or verso l’uno ed or verso l’altro termine
estremo del seno del mare, senza alcuna alterazione di esso elemento, proveniente da
altro accidente che da locale mutazione». Subito dopo passa a considerare i modi con
cui si può imprimere un moto locale all’acqua, per vedere se qualcuno di essi possa
essere individuato ragionevolmente quale causa prima delle maree (Opere, V, p. 378);
certo è che esso, soggiunge, dev’essere «appoggiato su sensate esperienze» (Ibid.). Però
non si limita a questo e passa direttamente alla considerazione delle cause. E, esposta la
sua teoria, dice esplicitamente: «andremo essaminando le tante differenze di accidenti
che intorno ai flussi e reflussi dei mari diversi si scorgono», e comincia l’esame dei fatti.
Nel Dialogo, invece, a questo punto – sebbene il discorso sia molto simile – si vede che
Galileo comincia con la preventiva esposizione di alcuni fatti, come se questi fossero
stati presi in considerazione prima di passare alla teoria; probabilmente, però, non vuole
trarci in inganno circa la genesi della sua teoria, ma solo preservare perlomeno le forme,
eliminando i crassi errori di informazione per i quali era stato criticato. In ogni caso,
come vedremo, la sua teoria non presenta alcun mutamento degno di nota.
2 Nel Discorso del 1616 non si faceva menzione di tali periodi mensile e annuo. D’altra
parte, è opportuno ricordare che Burstyn (Burstyn, 1962, p. 184) sostiene che, proprio in
questo passo, Galileo dice esplicitamente che le maree sono maggiori ai solstizi che agli
687