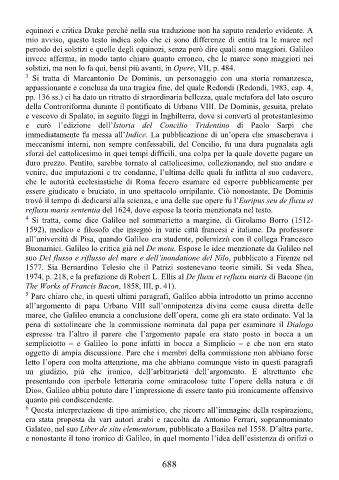Page 688 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 688
equinozi e critica Drake perché nella sua traduzione non ha saputo renderlo evidente. A
mio avviso, questo testo indica solo che ci sono differenze di entità tra le maree nel
periodo dei solstizi e quelle degli equinozi, senza però dire quali sono maggiori. Galileo
invece afferma, in modo tanto chiaro quanto erroneo, che le maree sono maggiori nei
solstizi, ma non lo fa qui, bensì più avanti, in Opere, VII, p. 484.
3
Si tratta di Marcantonio De Dominis, un personaggio con una storia romanzesca,
appassionante e conclusa da una tragica fine, del quale Redondi (Redondi, 1983, cap. 4,
pp. 136 ss.) ci ha dato un ritratto di straordinaria bellezza, quale metafora del lato oscuro
della Controriforma durante il pontificato di Urbano VIII. De Dominis, gesuita, prelato
e vescovo di Spalato, in seguito fuggì in Inghilterra, dove si convertì al protestantesimo
e curò l’edizione dell’Istoria del Concilio Tridentino di Paolo Sarpi che
immediatamente fu messa all’Indice. La pubblicazione di un’opera che smascherava i
meccanismi interni, non sempre confessabili, del Concilio, fu una dura pugnalata agli
sforzi del cattolicesimo in quei tempi difficili, una colpa per la quale dovette pagare un
duro prezzo. Pentito, sarebbe tornato al cattolicesimo, collezionando, nel suo andare e
venire, due imputazioni e tre condanne, l’ultima delle quali fu inflitta al suo cadavere,
che le autorità ecclesiastiche di Roma fecero esumare ed esporre pubblicamente per
essere giudicato e bruciato, in uno spettacolo orripilante. Ciò nonostante, De Dominis
trovò il tempo di dedicarsi alla scienza, e una delle sue opere fu l’Euripus seu de fluxu et
refluxu maris sententia del 1624, dove espose la teoria menzionata nel testo.
4
Si tratta, come dice Galileo nel sommarietto a margine, di Girolamo Borro (1512-
1592), medico e filosofo che insegnò in varie città francesi e italiane. Da professore
all’università di Pisa, quando Galileo era studente, polemizzò con il collega Francesco
Buonamici. Galileo lo critica già nel De motu. Espose le idee menzionate da Galileo nel
suo Del flusso e riflusso del mare e dell’inondatione del Nilo, pubblicato a Firenze nel
1577. Sia Bernardino Telesio che il Patrizi sostenevano teorie simili. Si veda Shea,
1974, p. 218, e la prefazione di Robert L. Ellis al De fluxu et refluxu maris di Bacone (in
The Works of Francis Bacon, 1858, III, p. 41).
5 Pare chiaro che, in questi ultimi paragrafi, Galileo abbia introdotto un primo accenno
all’argomento di papa Urbano VIII sull’onnipotenza divina come causa diretta delle
maree, che Galileo enuncia a conclusione dell’opera, come gli era stato ordinato. Val la
pena di sottolineare che la commissione nominata dal papa per esaminare il Dialogo
espresse tra l’altro il parere che l’argomento papale era stato posto in bocca a un
sempliciotto – e Galileo lo pone infatti in bocca a Simplicio – e che non era stato
oggetto di ampia discussione. Pare che i membri della commissione non abbiano forse
letto l’opera con molta attenzione, ma che abbiano comunque visto in questi paragrafi
un giudizio, più che ironico, dell’arbitrarietà dell’argomento. E altrettanto che
presentando con iperbole letteraria come «miracolose tutte l’opere della natura e di
Dio», Galileo abbia potuto dare l’impressione di essere tanto più ironicamente offensivo
quanto più condiscendente.
6
Questa interpretazione di tipo animistico, che ricorre all’immagine della respirazione,
era stata proposta da vari autori arabi e raccolta da Antonio Ferrari, soprannominato
Galateo, nel suo Liber de situ elementorum, pubblicato a Basilea nel 1558. D’altra parte,
e nonostante il tono ironico di Galileo, in quel momento l’idea dell’esistenza di orifizi o
688