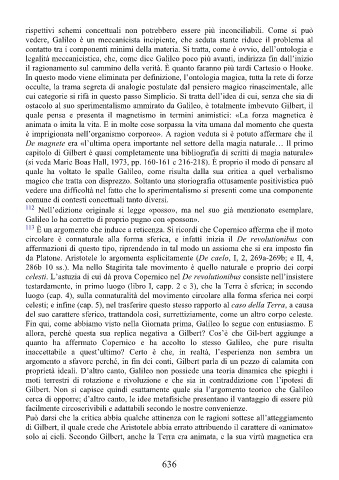Page 636 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 636
rispettivi schemi concettuali non potrebbero essere più inconciliabili. Come si può
vedere, Galileo è un meccanicista incipiente, che seduta stante riduce il problema al
contatto tra i componenti minimi della materia. Si tratta, come è ovvio, dell’ontologia e
legalità meccanicistica, che, come dice Galileo poco più avanti, indirizza fin dall’inizio
il ragionamento sul cammino della verità. È quanto faranno più tardi Cartesio o Hooke.
In questo modo viene eliminata per definizione, l’ontologia magica, tutta la rete di forze
occulte, la trama segreta di analogie postulate dal pensiero magico rinascimentale, alle
cui categorie si rifà in questo passo Simplicio. Si tratta dell’idea di cui, senza che sia di
ostacolo al suo sperimentalismo ammirato da Galileo, è totalmente imbevuto Gilbert, il
quale pensa e presenta il magnetismo in termini animistici: «La forza magnetica è
animata o imita la vita. E in molte cose sorpassa la vita umana dal momento che questa
è imprigionata nell’organismo corporeo». A ragion veduta si è potuto affermare che il
De magnete era «l’ultima opera importante nel settore della magia naturale… Il primo
capitolo di Gilbert è quasi completamente una bibliografia di scritti di magia naturale»
(si veda Marie Boas Hall, 1973, pp. 160-161 e 216-218). È proprio il modo di pensare al
quale ha voltato le spalle Galileo, come risulta dalla sua critica a quel verbalismo
magico che tratta con disprezzo. Soltanto una storiografia ottusamente positivistica può
vedere una difficoltà nel fatto che lo sperimentalismo si presenti come una componente
comune di contesti concettuali tanto diversi.
112
Nell’edizione originale si legge «posso», ma nel suo già menzionato esemplare,
Galileo lo ha corretto di proprio pugno con «posson».
113 È un argomento che induce a reticenza. Si ricordi che Copernico afferma che il moto
circolare è connaturale alla forma sferica, e infatti inizia il De revolutionibus con
affermazioni di questo tipo, riprendendo in tal modo un assioma che si era imposto fin
da Platone. Aristotele lo argomenta esplicitamente (De caelo, I, 2, 269a-269b; e II, 4,
286b 10 ss.). Ma nello Stagirita tale movimento è quello naturale e proprio dei corpi
celesti. L’astuzia di cui dà prova Copernico nel De revolutionibus consiste nell’insistere
testardamente, in primo luogo (libro I, capp. 2 e 3), che la Terra è sferica; in secondo
luogo (cap. 4), sulla connaturalità del movimento circolare alla forma sferica nei corpi
celesti; e infine (cap. 5), nel trasferire questo stesso rapporto al caso della Terra, a causa
del suo carattere sferico, trattandola così, surrettiziamente, come un altro corpo celeste.
Fin qui, come abbiamo visto nella Giornata prima, Galileo lo segue con entusiasmo. E
allora, perché questa sua replica negativa a Gilbert? Cos’è che Gil-bert aggiunge a
quanto ha affermato Copernico e ha accolto lo stesso Galileo, che pure risulta
inaccettabile a quest’ultimo? Certo è che, in realtà, l’esperienza non sembra un
argomento a sfavore perché, in fin dei conti, Gilbert parla di un pezzo di calamita con
proprietà ideali. D’altro canto, Galileo non possiede una teoria dinamica che spieghi i
moti terrestri di rotazione e rivoluzione e che sia in contraddizione con l’ipotesi di
Gilbert. Non si capisce quindi esattamente quale sia l’argomento teorico che Galileo
cerca di opporre; d’altro canto, le idee metafisiche presentano il vantaggio di essere più
facilmente circoscrivibili e adattabili secondo le nostre convenienze.
Può darsi che la critica abbia qualche attinenza con le ragioni sottese all’atteggiamento
di Gilbert, il quale crede che Aristotele abbia errato attribuendo il carattere di «animato»
solo ai cieli. Secondo Gilbert, anche la Terra era animata, e la sua virtù magnetica era
636